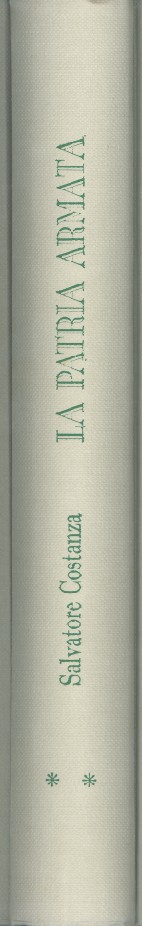Salvatore Costanza

la copertina
© Copyright 1989
Arti Grafiche Corrao
via Valenza, 31
Trapani
Finito di stampare
nel settembre 1989
Ringrazio l'amico
Vito Accardo
per avermi portato
alla conoscenza
di questo libro
Questa ricerca storica riproduce, con ampliamenti e integrazioni, l'omonimo studio pubblicato nel fascicolo speciale dei «Nuovi quaderni del meridione» dedicato alla rivoluzione palermitana del settembre 1866 (n. 16, ottobre/dicembre 1966, pp. 419-38).
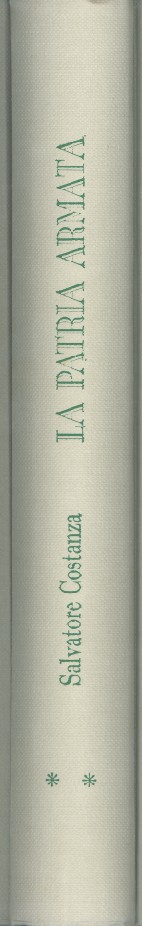
|

|
|
Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
|
LA PATRIA ARMATA di Salvatore Costanza
|
RIBELLI E MAFIOSI NEL TRAMONTO DEL BRIGANTAGGIO SOCIALE
9. Giustizia rovesciata o metagiustizia?
La vicenda del capobrigante di Castellammare e dei suoi compagni, che si è ora ricostruita, offre lo spunto a qualche riflessione. Delle fasi evolutive di essa si è già detto. E cosi anche dell'interna strutturazione della banda, oltre che della mentalità che ne ha sostenuto le azioni e i comportamenti come retaggio di antiche «utopie» refluenti dalla disgregazione del mondo feudale. Ciò che appare tuttavia atipico nella esperienza del brigantaggio siciliano è la sua marginale connotazione politica e - aspetto ancor piu atipico - la sua non marcata determinazione sociale. Risaltano, perciò, alcune sostanziali differenze con il coevo fenomeno del brigantaggio meridionale, fortemente segnato, invece, da un confuso sentimento di rivalsa dei legittimisti borbonici che vi presero parte e che riuscirono a lungo a influenzarlo101. Si può dire che, se a motivare in genere l'abbandono della legalità da parte dei ribelli fu il rifiuto della leva (meno l'aver subito un torto o un'ingiustizia), ad assicurare la consistenza numerica della banda, e a farIa durare ben al di là del tempo consentito a simili attività extralegali, fu il sostegno «funzionale» che vi prestarono gli ambienti di mafia. Sicché la collusione tra le bande brigantesche e gli esponenti del Comitato insurrezionale di Palermo, all'epoca della rivolta del settembre 1866, va interpretata alla luce di quella «opposizione mafiosa» allo Stato unitario che intendeva reintegrare nel suo disegno reazionario spinte politiche tra di loro contrapposte e forze sociali composite. Come è documentato dalle fonti demologiche e dalle carte istruttorie del processo, l'ambiguo segnale politico che si manifestò in quella occasione fu intermediato dai numerosi «adepti alla mafia» che sfruttarono la presenza delle bande nella zona per un proprio calcolo d'interferenza. Non vi fu, invece, quel concorso popolare cui altrove inducevano i comuni fattori di crisi e di miseria endemica delle masse. Non si può, quindi, parlare, nel caso del brigantaggio siciliano, di un «movente politico, reale o strumentale» 102, che l'abbia potuto ispirare; né veramente si riesce a scorgere nella «protesta» metaforizzata di un Cajozzo alcun programma d'intenti sociali che in qualche modo sussidi le aspirazioni del mondo contadino. Il senso della giustizia sociale che vi si evoca è, per cosi dire, metastorico. Non ha alcun concreto riferimento ai bisogni della gente; e nel contempo si dissolve nell'anarchico rancore dello sbannutu (cioè del perseguitato dagli sbirri e dagli 'nfami) l'originario significato del ribellismo antileva che aveva coinvolto il paese contadino nella protesta contro lo Stato e le sue strutture di potere.
101 F. MOLFESE, Storia del brigantaggio dopo l'Unità, Milano 1966. L'autore si sofferma nella prima parte del lavoro sull'ondata di «reazioni» dell'autunno 1860/inverno 1861, in cui i piani borbonico-clericali «si sovrapposero agli spontanei movimenti contadini, imprimendo loro un orientamento politico».
102 G. CINGARI, Il brigantaggio nella prima metà dell'Ottocento, in «Archivio storico per la Calabria e la Lucania», Roma, a. XLII (1975), pp. 51-97, Il momento politico avrebbe seguito la ricorrente rivolta sociale nelle campagne meridionali, dal moto antifrancese del 1799 alla rivoluzione garibaldina del 1860, come «una risposta primordiale e violenta alla progressiva espropriazione dei diritti contadini» (ivi, pp. 96-97).
Che cosa rimane allora del banditismo in Sicilia?
L'immagine del brigante/eroe, che deriva dalla letteratura romantico-popolare alla Linares1O3, oltre che dall'epica rudimentale dei cantastorie, sostiene la mentalità «eroica» di alcuni ribelli, forse piu di quanto non esprima un modello reale di comportamento, nel senso che essa è spesso mutuata da concezioni che si debbono riferire alla «circolarità» degli elementi culturali, come cifre superficiali di un complesso rapporto storico-tradizionale interclassista. Resta pertanto fondamentale, a mio giudizio, la domanda che si poneva Eric J. Hobsbawm: «Fino a che punto il mito del banditismo getta luce sul modello reale del comportamento del bandito?»104.
103 Vincenzo Linares è l'autore dei Racconti popolari (Palermo 1841-43) in cui la figura del brigante appare circonfusa di un alone leggendario di basso conio romantico ad uso popolare sco. Per gli aspetti letterari del mito del «buon brigante», si vedano le acute pagine di S.F. ROMANO, in Storia del/a mafia, pp. 31-50.
104 ERIC J. HOBSBA WM, Bandits, London 1969 (l banditi. Il banditismo sociale nel/'età moderna, Torino 1971). La figura del brigante sociale che viene tratteggiata da Hobsbawm ha però pochi riscontri con quella di Pasquale Turriciano. Se è un suo elemento tipico la moderazione nell'uccidere e nell'uso della violenza, insieme con l'assunzione del ruolo di giustiziere, volto soprattutto a dimostrare che «anche i diseredati e gl'indifesi, con le loro azioni, possono diventare terribili» (p. 52), non si può dire tuttavia che egli usi la violenza per «raddrizzare i torti» o togliere al ricco per dare ai poveri. Che poi venga ucciso «invariabilmente e inevitabilmente» per un tradimento, anche questo rientra nello stereotipo, ma con una variante «regionale» contrassegnata dal fatto che il tradimento, secondo la tradizione, è opera della perfidia femminina. Uniformi sono invece la tecnica che regola i fatti d'arme e la composizione brigantesca, secondo modelli già noti in passato. (Sulle tesi di Hobsbawm, v. i rilievi critici espressi da A. Blok in The Peasant and the Brigand: Social Banditry Reconsidered, in «Comparative Studies in Society and History», voI. 14, 1972, pp. 495-504). Per le problematiche connesse con i «marginali» nella società moderna, e con il loro rapporto con le istituzioni giudiziarie, v. gli atti del convegno di Venezia (3-5 novembre 1983) su Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli Stati europei di antico regime. Non mantiene, invece, le promesse del titolo l'esile raccolta dei contributi al 6° Seminario di studi di folklore siciliano (Trapani: pirateria e brigantaggio tra storia locale. storia e etnostoria. Trapani, 20-21 dicembre 1980).
I paradigmi culturali del brigante/eroe sono quelli feudali, che appartengono a un contesto omogeneo di valori e di simboli in cui si riconosceva un'intera società, senza distinzione tra egemoni e subalterni. Ciò che egli rappresenta, nella fase di disgregazione di quella società, è dunque una «superstizione» storica, un fattore d'inerzia sociale, non certo un ruolo contestativo e rivoluzionario (semmai il brigantaggio l'abbia avuto anche in passato).
In realtà, gli elementi di mobilità sociale che si verificano in questo periodo all'interno della società contadina hanno origine dalle spinte mafiose/borghesi verso l'acquisto della terra e verso una nuova distribuzione della rendita fondiaria. Il fenomeno del banditismo, se nasce dalle resistenze incontrate dall'amministrazione unitaria nella sua opera d'integrazione politica, non trova poi legittimità nell'ambiente locale per le sue «rivendicazioni», in quanto è ormai di fatto superato dai processi di compenetrazione compiuti dai diversi livelli del potere mafioso. Credo di aver dimostrato in tal senso che la solidarietà dei ceti contadini sia venuta sotto la forma del manutengolismo, anziché in nome di una vera e propria comunanza di aspirazioni sociali.
Tuttavia la mentalità che esprime la posizione in cui è precipitato il brigante non esclude una base comune di convinzioni e di schemi morali con quanti nella società contadina sentono piu forte il valore del rapporto con la tradizione. Del resto, il tempo che incalza i processi economico-sociali è quasi sempre piu veloce delle modificazioni culturali, che cosi rendono permutabili le stratificazioni della stessa mentalità entro realtà diverse e perfino antitetiche. Ciò si rende evidente soprattutto per quanto riguarda quelle forme «deviate» della giustizia (e dell'autogiustizia) che fanno parte dei comportamenti naturali dei ceti subalterni, oltre che dei «marginali». Nel caso specifico dell'essenza di giustizia rispecchiata nei loro pensieri valga, comunque, questa duplice considerazione:
a) Gl'istituti giudiziari operanti in Sicilia nella lunga durata del sistema feudale e semifeudale sono stati determinanti nel formarsi del particolare atteggiamento dei ceti inferiori verso lo Stato. La giustizia codificata, come spazio permanente di conflittualità, e insieme le modalità empiriche della legge, intesa come agire sociale, come condotta di chi la giustizia esercita interpretando le leggi, hanno operato quasi sempre con i caratteri della discrezionalità perversa a vantaggio delle classi egemoni. La legge ha cosi finito per rappresentare solo una consuetudine del potere. Non è stata accettata, ma è stata subita proprio per la sua natura coattiva non giusta nell'immediato e nel relativo, ancor piu che nel suo valore assoluto.
b) La parzialità delle leggi non è derivata soltanto dalla pressione sociale da esse esercitata, ma anche dal loro grado di separatezza rispetto alla morale corrente. Separatezza, anziché opposizione, perché nelle condizioni sovrastrutturali della vita contadina la legalità formale si è presentata come qualcosa di estraneo, e persino di innaturale, a fronte delle consuetudini inveterate del vivere quotidiano. Si è perciò configurata contro una tale legalità formale, o meglio al di fuori di essa, una sorta di metagiustizia, cioè di un sentimento della giustizia come valore astratto, in quanto devoluto all'autorità della tradizione, piuttosto che all'esercizio di una pratica consuetudinaria, del resto sempre piu ristretta e fittizia. Quindi l'idea di giustizia che siè stratificata nella coscienza popolare, proprio per la sua informalità, si è resa garante di un atteggiamento di passività e di atonia sociale, piu che di rivolta e di reazione. La sua scarsa permeabilità al «diritto» è in fondo il segno della sua estraneità alla storia scritta dai potenti di tumo105.
105 Chi incappava negli ingranaggi giudiziari, poiché era convinto di non potergli sfuggire altrimenti, tentava quasi sempre di trascinare i giudici tra le reti sottili dell'immemoriale e del contraddittorio, della prova apparente e dell'apparenza non provata. Camillo Cajozzo, davanti al tribunale che gli chiedeva conferma della sua appartenenza alla banda Turriciano, casi rispondeva: «Potrebbe esser si, potrebbe essere anche no» (AST, Corte d'Assise, Processi penali, b. 2, fasc. 23, interrogatorio del l'ottobre 1869), forse per un giuoco beffardo di contrarietà ad una logica giuridica che non gli apparteneva. E, inoltre, nella «storia vissuta)) che il brigante/poeta dettava con estemporanea veemenza prima del suo arresto, la furtuna, come simbolo rituale, era considerata legge imperscrutabile della vita e, insieme, unica forza di resistenza avverso la giustizia codificata.
Sarebbe, comunque, storicamente incongruo definire in termini perentori e classificatori tali sentimenti, come se si trattasse di qualcosa di statico e irredimibile. Un esame piu attento dei mutamenti intervenuti nel travagliato periodo postunitario ci mostra le variabili, le diacronie, le fratture politiche 'che si determinano per l'irrompere delle moderne ideologie demo-sociali a rimuovere concezioni escatologiche e feudali retaggi. Ciò porta a rimettere in circolo gl'interessi «separati» della società contadina nell'alveo dello Stato e delle sue istituzioni, da cui si sarebbe rivendicata una forte riparazione in termini di giustizia e di solidarietà.
I pròcessi d'integrazione delle masse nella vita unitaria agirono attraverso le forme organizzate della lotta sociale nel senso della maturazione della coscienza collettiva, ma soprattutto persuasero in qualche modo che la «giustizia» potesse rivendicarsi nell'ambito delle leggi. Non deve perciò ritenersi una forzatura populistica, o una declamazione folclorica, il ricordo del brigante di Castellammare che, un ventennio dopo, i socialisti deifasci avrebbero proposto come esemplare della linea evolutiva della «lotta di classe» in Sicilia, dalla ribellione individuale al movimento popolare riformatore; cioè dal rifiuto della legge alla conquista del «diritto»106.
106 «Il Mare», Periodico Socialista, Trapani, 22 ottobre 1893 («...il giovane brigante nemico dei prepotenti, dei deboli difensore ed amico»).
Alquanto diversa è la stagnante persuasività dei modelli culturali imposti dalle consuetudini della mafiosità, equivalente ad una giustizia rovesciata. Se le «mafie» nascono sul terreno della mafiosità latente nel mondo rurale, non per questo il potere informale che esse rappresentano esprime il senso della giustizia che si alimenta, tra i contadini, delle aspirazioni ad un ordine sociale piu retto. La storia del· mondo contadino siciliano, delle sue rivolte e delle sue forme di resistenza, comprova le conflittualità, piu o meno laceranti, tra i ceti inferiori che man mano emergono dallo stato di subalternità e i gruppi di mafia che di fatto si vanno accostando al potere della legalità statuale onde piegarlo ai propri interessi. E anche questo intreccio equivoco tra mafie e autorità del governo e dello Stato costituisce, in fondo, un'altra 'ngiuria verso i poveri e gl'indifesi, aumentando il sospetto delle masse nei confronti della legge.
|
|

|