
Salvatore Costanza

la copertina
© Copyright 1989
Arti Grafiche Corrao
via Valenza, 31
Trapani
Finito di stampare
nel settembre 1989
Ringrazio l'amico
Vito Accardo
per avermi portato
alla conoscenza
di questo libro
Questa ricerca storica riproduce, con ampliamenti e integrazioni, l'omonimo studio pubblicato nel fascicolo speciale dei «Nuovi quaderni del meridione» dedicato alla rivoluzione palermitana del settembre 1866 (n. 16, ottobre/dicembre 1966, pp. 419-38).
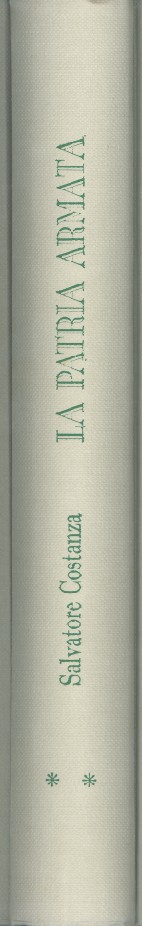
|

|
|
Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
|
LA PATRIA ARMATA di Salvatore Costanza
|
RIBELLI E MAFIOSI NEL TRAMONTO DEL BRIGANTAGGIO SOCIALE
8. Morte di un brigante
Giunto a compimento il processo di emarginazione del banditismo dalla società contadina, dalla solidarietà dei poveri e degli sfruttati, da quel senso antico dell'onore e della giustizia che la pratica della violenza mafiosa usata contro i piu deboli concretamente rifiutava, ciò che ormai restava del mito del brigante/eroe era solo un ammirato riconoscimento della forza e dell'audacia dimostrate in tante occasioni. Invano Cajozzo cercava di rinvigorire quel mito eroico coi versi «gridati» del suo disprezzo per sbirri e spie (li 'nfamuna ni tiranu li peri; str. 27, v. 5). Soltanto il furore degli odii non repressi egli poteva sostituire alla protesta sociale, l'affanno e il cruccio per la propria sorte all'epica rudimentale dello sbannutu.
Dunque, l'età eroica del brigantaggio, che Pasquale Turriciano aveva cercato di esemplare con le sue gesta, appare sempre piu come uno stereotipo medievale, privo di concrete risonanze sociali. Cuidera ricorderà bene nel suo studio antropologico del 1903 il divario di comportamento che si era determinato negli ultimi tempi tra il capobrigante e gli altri componenti della sua banda: «I compagni e gli eredi di Torregiano furono odiati ed aborriti da tutti i cittadini, e molti di essi si rinvennero cadaveri in mezzo ai vigneti, per opera degli stessi contadini, che non tolleravano la loro malvagità, spoglia di ogni sentimento generoso»90. Invece l'estraneità del capobrigante a quasi tutti i fatti criminosi imputati agli altri banditi prova se non altro il suo rifiuto a farsi strumento di violenza e di sopruso contro la povera gente.
Pasquale, cui la sorte aveva riservato il privilegio di essere lestu e guagghiardu di peri, era riuscito in otto anni di latitanza a sfuggire a tutti gli agguati. Ora però attendeva con cuore fermo che il suo destino si compisse. Quanto piu si avvicinava il momento dello scontro finale con gli sbirri, tanto piu egli appariva spavaldo e temerario, a volte persino tracotante, quasi che una smania rabbiosa lo spingesse a cercare quella morte.
Di solito, a perdere i briganti sono le donne. Attratte dapprima, come l'amante di Gramigna, dall'«ammirazione bruta della forza»91, risvegliano poi gl'istintipiu malvagi della femminilità offesa per tradire i loro compagni. (Cosi almeno tramandano le cronache paesane, nutrite di saggezza popolare.) Cajozzo, che non sfuggirà nemmeno lui allo strumento femmineo del destino, ammonisce i picciotti: Omini tutti l'aviti sgarratu / c'a li buiani amuri ci miltili (str. 71, vv. 7-8). Al primo dei briganti catturati, Vallone, 'na fimmina ci fici l'attimpuni (str. 68, v. 6). E pure uno dei suoi fratelli pati lo stesso tradimento: Me frati si garzau cu 'na buiana: /l'appiru abbarittatu li 'nfamuna. / Calava a lu paisi ogni simana, / e ni 'na fimminazza chiu lurduna. / Dda sira si inchiu 'na strata sana, / e fu pigghiatu pi malafurtuna, / e lu quasanti fu l'Ariagglziana (str. 70, vv. 2-8).
90 L. CUIDERA, Vivai criminali, p. 34. Il sociologo sostiene pure che la piu matura coscienza civile contribui ad isolare i banditi, verso i quali anzi il popolo mostrava ormai netta avversione, «quantunque in fondo l'anima sua batta all'unisono con un certo sistema di cavalleria primitiva». Dopo l'età eroica del brigantaggio, sopravvenne «una forma degenerata» di esso, «che non ha smesso l'antica fierezza, ma dalla quale è del tutto scomparso l'antico sentimento di cavalleria. A disorganizzarlo, oltre la repressione, contribuirono la suddivisione della proprietà, la ferrovia, l'emulazione stessa, o meglio l'imitazione, la quale, penetrando in soggetti volgari, ha contribuito a spegnere ogni sentimento eroico, COSI caro alle popolazioni. Invero, mentre prima molti briganti erano venuti su dalla classe piu sana, piu coraggiosa, e le passioni piu potenti, come l'amore tradito o la persecuzione ingiusta od anche l'orrore per la leva, cui non si era abituati in Sicilia, erano le cause piu frequenti, che spingevano l'uomo a ribellarsi alla società, oggi è un pullulare di gente volgare e corrotta, che non possiede se non il coraggio grossolano e feroce, quando pure esso non tentenni e scompaia, dinanzi all'uniforme del carabiniere» (ivi, pp. 33-34).
91 G. VERGA, L'amante di Gramigna. in Tutte le novelle, I, Milano 1940, pp. 203-209.
Cagione forse piu supposta che reale. Lu quasanti, cioè la causa delle disgrazie capitate al fratello col suo arresto, qui riecheggia, coi toni malèdici dello scandalo di paese, certe superstizioni di origine medievale sul potere malefico della donna. Eppure, scorrendo le pagine delle istruttorie, si rimane colpiti dall'atteggiamento mostrato dalle piccole donne dei briganti di fronte agli uomini della legge; come esse sappiano sopportare il rigore delle inchieste, serrate in un diniego ostile eppur dolente.
Secondo una tale tradizione, non poteva mancare nemmeno per il capobrigante l'attimpuni di una donna. Non pare comunque che questa volta la fine di Turriciano sia imputabile all'insidia femminina. La donna che vi si trovò implicata (Maria Mistretta, moglie di Camillo Cajozzo) forni a Turriciano un nascondiglio in casa sua, e per questo fu processata e condannata dal tribunale92. La non lieve condanna subita per tale complicità farebbe intanto escludere una sua delazione. E inoltre una ricerca casuale condotta tra i processi della Corte d'Assise di Trapani mi ha permesso di rintracciare le prove di un'altra delazione ben piu significativa, finora rimasta ignota alla memoria paesana.
Nino Buffa inteso chiovo, murifabbro, ben noto alla polizia per i suoi trascorsi, uccise in un agguato, nel '68, il giovane Nardo Curatolo. Questi non mori subito, e perciò fu richiesto dal giudice istruttore di fare i nomi dei suoi nemici; ma negò di averne mai avuti. «L'Ufficio fa rilevare - annotava comunque il giudice - che il ferito Curato lo si mostrava cosi ostinato a rispondere alle sue interrogazioni che dava a divedere chiaro ch'egli conosceva benissimo chi era stato il suo feritore, ed intanto lo taceva per i soliti principii di mafia, e per vendicarsi forse dell'offesa ricevuta, se rimanesse in vita»93. Nei due giorni successivi all'agguato, e mentre Nardo era ancora in vita, si cercò di scoprire gli autori del fatto criminoso.
92 Maria Mistretta fu Francesco (n. a Castellammare il lo maggio 1845), moglie di Camillo Cajozzo e sorella di un altro brigante, era già stata ammonita il 2 dicembre 1869 come ricettatrice della banda Turriciano. I suoi connotati: statura m 1,52; capelli castagni, fronte piccola, occhi corvini, naso piccolo, mento ovale, faccia rotonda, corporatura chinotta (AST, Corte d'Assise, Processi penali, b. 5, fase. 105-106).
93 Ivi, b. 16 (1868), fase. Buffa Antonino e figli. Nota aggiunta del pretore di Castellammare al verbale d'interrogatorio di Leonardo Curatolo, II gennaio 1868. Antonino Buffa, 47 anni, era stato condannato nel 1853 a 25 anni di ferri per furto, ma era evaso dal bagno di S. Giacomo (Favignana) nel 1860. Implicati con lui nel processo furono i due figli Giuseppe e Antonio.
Inutilmente, però. Le persone chiamate a testimoniare non avevano né visto né saputo nulla. Il comandante dei militi Fundarò dichiarò persino di essersi precipitato in casa di Buffa non appena udi gli spari (ma non disse quale segreto impulso l'avesse spinto lì) e di averlo trovato «seduto al desco» (all'una di notte). A bere e a mangiare con lui c'era pure Peppi Pipa (Giuseppe Gioia), un milite che tutti conoscevano in paese per il suo impegno nella lotta contro il brigantaggio. La circostanza poteva facilmente riscontrarsi, a beneficio della verità. Era dunque da escludere una partecipazione di Buffa al delitto.
Quando però si vide prossimo alla morte, Curato lo si decise a rivelare tutto, non senza riservarsi, come estrema risorsa di onorabilità, il diritto di ripagare in questo modo l'altrui 'nfamità («Giacché i miei nemici non si sono condotti da uomini, io voglio manifestare la verità»). Tra Buffa e Curatolo c'era stato sempre malanimo, che si era cercato di revocare combinando un comparatico94. Ma una sera Nino Buffa, con due dei suoi figli, aspettò il giovane compare fuori della sua bottega e lo colpi con una fucilata: «Ed io gridai: "nfami, chi beddu cumpari chi mi vinni ad ammazzari a trarimentu!,,»95. Durante il processo, l'imputato chiamò mezzo paese in sua discolpa, e molti notabili ne attestarono la condotta «regolare»96. Il motivo di una cosi massiccia solidarietà è da ricercare nel ruolo di «guardaspalle» che Antonino Buffa, insieme coi suoi fratelli, aveva svolto negli eventi politici e sociali succedutisi a Castellammare dal 1848 al 1866. Nella rivolta del '62, come ricordano varie fonti, i Buffa si adoperarono per assicurare l'incolumità dei galantuomini e preservare i loro beni.
Il tribunale, però, sulla base delle prove raccolte condannò il murifabbro, insieme coi suoi figli, alla pena di morte mediante decapitazione97.
94 Si stabili tra i due di «dover divenire con Giuseppe Buffa del fu Giuseppe compadre di S. Giovanni alla prima opportunità» (ivi, interrogatorio di Leonardo Curatolo del 12 gennaio 1868).
95 Ivi. Il delitto avvenne in Castellammare nella notte dal IO all'11 gennaio 1868. Implacabile accusatrice contro i Buffa fu la madre dell'ucciso, Vincenza Galioto.
96 Ivi. Attestati di moralità a firma degli amministratori comunali Ignazio Scandariato (doc. del 28 luglio 1868) e Vito Vasile (doc. del 27 luglio 1869). Tra i testimoni a discarico, oltre al comandante dei militi Fundarò, i sacerdoti Barone e Zangara, il dr. Giuseppe Calandra e l'ex sindaco Giuseppe Marcantonio.
97 AST, Corte d'Assise, Sentenze, 1869, voI. 7, n. 65.
Fu allora che Buffa perse quel residuo di onuri che ancora gli restava. Si fece collocare nella cella dove erano stati rinchiusi i briganti arrestati nell'autunno del '69, onde raccogliere le loro confidenze e trasmetterle ai carabinieri: i quali cosi seppero dove esattamente si nascondeva il capobrigante. Per questi «servizi» che egli stesso rivendicò subito dopo in una lettera indirizzata al procuratore generale del re in Palermo, gli fu risparmiata in appello la massima pena. I giudici non ebbero difficoltà a trovare a sua discolpa tutte le possibili attenuanti per condannarlo, nel '72, a soli diciotto anni di lavori forzati98.
Il nuovo comandante dei militi, Mancuso, che diresse l'ultima operazione antibanditesca avrebbe confermato in un suo rapporto di aver saputo «per riserbate informazioni» del luogo in cui Turriciano si era rifugiato99. Quando la notte del lO marzo 1870 arrivò in casa di Maria Mistretta con una ventina di uomini, tentò di convincere il brigante, che sapeva rinchiuso in un sotterraneo della casa, a consegnarsi alla Giustizia. Non ebbe all'inizio alcuna risposta. Poi improvvisamente Pasquale saltò fuori sparando contro le guardie per sfuggire al loro assedio e raggiungere la strada, finché cadde crivellato di colpi 100.
98 Ivi. La supplica con cui Antonino Buffa chiese al procuratore della Corte d'Appello di Palermo di essere ricompensato per i «servizi prestati» è del 23 luglio 1870. La nuova sentenza della Corte d'Appello di Palermo è del 30 agosto 1872.
99 AST, Corte d'Assise, Processi penali, b. 5, fasc. 105-106. Salvatore Mancuso aveva sostituito da poco Gaspare Fundarò nel comando dei militi a cavallo del circondario di Alcamo (v. in ASP, Pref, Gab., b. 18, cat. 20, fasc. 12, Brigantaggio. 1866-1870; nota del prefetto di Trapani al prefetto di Palermo dell'8 settembre 1869).
100 Tra i resoconti del conflitto a fuoco di via Ferrantelli apparsi sulla stampa locale quello de «L'Imparziale» è riportato in appendice tra i Documenti (N. 17). Una cronaca piuttosto dettagliata dell'avvenimento apparve pure sull'«Esopo» del 12 marzo 1870 (n. 9 dell'a. I). «Il capitan d'armi Mancuso - riferiva il giornale - ricevuta l'amminnicolata denunzia, recato si in Castellammare, e precisamente nella casa del Delegato estraordinario signor Lentini Vittoriano, che trovò affetto di forte febbre, gli dettagliava la denunzia, e poco dopo la mezzanotte il Mancuso, insieme a sei guardie di p.s., due Carabinieri, e tredici Militi a cavallo, andava a chiamare la suocera del Lamia, murifabbro, sco no scendo la di costui abitazione, a solo scopo d'indicargliela, come fece. Sicché seco portando quest'ultimo, andò con pochi della forza nella casa della Mistretta Maria, ove essa pernottava, per farsi condurre nella di lei abitazione. Ma prima, com'è naturale, perquisi superficialmente quella della madre. Indi costrinse la Mistretta a seco recarsi nella vicina sua abitazione, dove arri vata, aprendo la porta, emette un respiro, tanto che il Mancuso entrando con soli cinque della forza disse alla Mistretta: "questo è il primo segno che il Torregiani è in tua casa"; poi invitavala ad additargli il sotterraneo, con la promessa di scamparle la galera, ma essa però fu sempre negativa. Allora il Mancuso soggiunse: "Ma se ti facessi vedere il costruttore del sotterraneo, me lo indicheresti tu?". Ed ecco che fa entrare il murifabbro Lamia. A quale vista, sorpresasi un poco la Mistretta, proruppe dicendo: si iddu lu fici, lu stissu lu scopri. Ma mostrandosi negativo il Lamia, il signor Mancuso facea scavare in sei punti la stanza, quando uno della forza arrivato a scovrire lo sportello del sotterraneo, la Mistretta chiamò il Mancuso in un angolo della medesima stanza dicendogli: Pasquali vieni a prisi ... e prima che finisse di proferire la parola, s'intese una esplosione d'arma da fuoco, proveniente dal sotterraneo, che spense i lumi, e feriva il Lamia al braccio. Istantaneamente il Torregiani tirava altro colpo, col quale rendeva cadavere d'innanzi la porta una Guardia, e fuggiva. A questo il signor Mancuso gridando: affirratilu si scagliavano su Torregiani dei colpi, senza però ferirlo mortalmente, ma uno della forza che trovavasi accanto la stessa porta, lo afferra, e cominciò a dibattersi per un tantino col ripetuto forbandito, quando arrivati altri della forza lo distendono sul suolo corpo morto».
|
|

|





