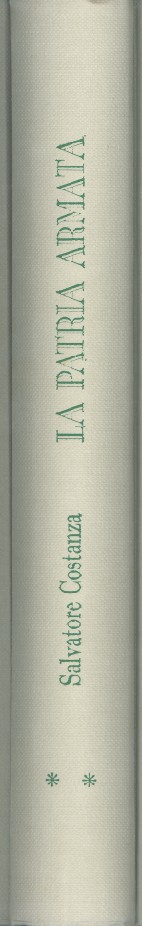Salvatore Costanza

la copertina
© Copyright 1989
Arti Grafiche Corrao
via Valenza, 31
Trapani
Finito di stampare
nel settembre 1989
Ringrazio l'amico
Vito Accardo
per avermi portato
alla conoscenza
di questo libro
Questa ricerca storica riproduce, con ampliamenti e integrazioni, l'omonimo studio pubblicato nel fascicolo speciale dei «Nuovi quaderni del meridione» dedicato alla rivoluzione palermitana del settembre 1866 (n. 16, ottobre/dicembre 1966, pp. 419-38).
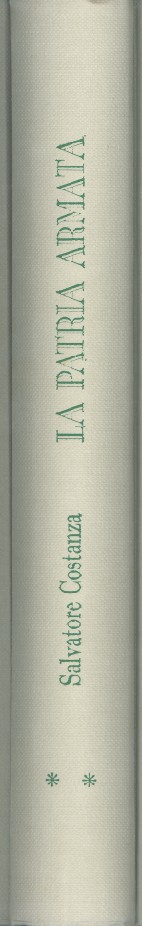
|

|
|
Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
|
LA PATRIA ARMATA di Salvatore Costanza
|
LA RIVOLTA CONTRO I «CUTRARA»
(Castellammare del Golfo, 1/3 gennaio 1862)
4. Genesi e fisiologia della «mafia»
L'avidità della borghesia locale nel pretendere per sé appalti e uffici remunerativi costituiva il fondamento della lotta tra le fazioni. Naturalmente ciascuna delle due fazioni reclutava i suoi adepti in una ristretta cerchia d'individui legati dal vincolo della parentela. Ciò che riusciva, quindi, a formare la necessaria aggregazione tra i membri dello stesso «partito» era quella attitudine, tipicamente feudale, a perseguire gl'interessi esclusivi del proprio gruppo familiare, che le autorità del tempo credevano d'individuare in un negativo «spirito di famiglia». Spirito di sopraffazione, piuttosto che di solidarietà, generato dalla necessità di far valere contro gli altri l'utile dei parenti e dei compari in una continua lotta per poter dominare nel paese e assicurarsi le fonti di sfruttamento della roba. Di qui l'ethos caratteristico di individui dominati dalla costante preoccupazione di sovrapporre all'interesse comune o collettivo, esercitato dalla legge, quello della propria famiglia76.
Non siamo comunque in quella fase del «familismo amorale», presente nelle comunità meridionali, che Banfield teorizzava trent'anni fa77. Invece di chiudersi in se stessa, la famiglia siciliana, in questo periodo, cerca piuttosto di sfruttare a proprio vantaggio i benefici materiali derivanti dall'avvio di un processo, sia pur debole e lento, di enucleazione borghese, favorito dalle nuove possibilità di accedere alla proprietà delle terre demaniali ed ex baronali. Lo «spirito di famiglia», che sopravviveva come prodotto di antichi sentimenti feudali, si riconosceva solo in parte nello «spirito di mafia», che era intanto il modo particolare di affermare nella società le proprie aspirazioni al miglioramento individuale.
76 Esaminando lo stesso fenomeno nel 1876, Leopoldo Franchetti notava che le possibilità offerte dal regime unitario ai gruppi dominanti favorivano lo sfruttamento delle amministrazioni locali a fini personali: «Quella persona o quel gruppo di persone cui venga affidato un interesse collettivo non può evidentemente intendere da sé l'indole ed il fine dell'ufficio ricevuto, e quando non sia guidato passo per passo dal controllo di un'autorità sociale superiore, non potrà non considerare, non solo come diritto, ma anche come dovere l'impiegare il potere che ha in mano, a vantaggio proprio e dei suoi aderenti personali. Accadrà dunque quasi inevitabilmente che questo potere sia adoperato nell'interesse esclusivo, non diciamo della classe sociale cui è stato affidato, ma di una parte di essa, di quelle persone cioè alle quali è venuto in mano, e di coloro che sono legati ad esse. Ora, la legislazione italiana, in generale, e quella specialmente sulle amministrazioni locali, ed il modo in cui viene applicata sono tali che da un lato la classe proletaria viene per ogni verso data in assoluta baHa alla classe abbiente, e dall'altro una porzione di quest'ultima, ed anche la minore, può impadronirsi dell'autorità in modo da signoreggiare senza controllo alcuno» (cfr. L. FRANCHETTI, Condizioni politiche e amministrative della Sicilia, Firenze 1877, pp. 343-44).
77 E.C. BANFIELD, The moral basis of a backward society, Glencoe 1958 (trad. it. Bologna 1976). L'atteggiamento che il sociologo americano individua nel «culturallag» di una comunità lucana, scelta a modello del sistema di valori del mondo rurale sud-italiano, presuppone l'indifferenza e l'ostilità dei «familisti» di fronte alla cosa pubblica. Analogo atteggiamento aveva rilevato Carlo Levi (Cristo si è fermato a Eboli, Roma 1945), osservando «l'immobile civiltà» dei contadini di Gagliano; ma anche nei piccoli paesi lucani i galantuomini avevano trasformato «la propria delusione e la propria noia mortale in un furore generico, in un odio senza soste, in un perenne risorgere di sentimenti antichi, e in una lotta continua per affermare, contro tutti, il loro potere nel piccolo angolo di terra dove erano costretti a vivere» (p. 25).
Tra le «gare le piu accanite dello spirito di famiglia», quella che tendeva ad accaparrarsi gli uffici preposti all'ordine pubblico era sempre la piu aspra. Numerosi documenti del periodo qui preso in esame provano l'esistenza di contrasti del genere (magari nell'ambito della stessa fazione), poiché per quella via si rendeva ormai facile potersi imporre su un certo ambiente, mettendosi al riparo dal «braccio della giustizia», Sulle ambizioni rivolte al fine di ottenere il controllo della guardia urbana riferiva una nota informativa del giudice regio di Castellammare, che denunziava le velleità di comando di alcuni galantuomini: «L'ufficio di Capo o Vicecapo nelle mani di «Giovan Battista» Sangiorgio diventa uno strumento di private vendette, un adito a lorde speculazioni, una chiave che mena a nuove scissure di partiti e di fazioni»; ma anche chi era già a quel posto si mostrava apertamente «poco avverso alle persone di ambigua condotta»78, E, d'altro canto, come appariva dai rapporti periodici trasmessi all'intendente dalle autorità periferiche, l'esercizio della giustizia e la vigilanza sull'ordine pubblico nel distretto di Alcamo si svolgevano in modo tutt'altro che regolare. Alle connivenze piu o meno colpevoli con la «classe de' ladri», di cui si rendevano responsabili giudici regi, capi urbani e capitan d'armi, si aggiungeva spesso l'inettitudine dei funzionari, o la loro palese ignoranza delle leggi79.
78 Cfr. il rapporto già cit. del giudice regio di Castellammare del 4 settembre 1850, in AST, FI, Polizia, Corrispondenza (1849-53), fase. Castellammare, doc. 7.
79 «I giudici supplenti di Gibellina, Castellammare ed Alcamo sono tanto digiuni di leggi che debbono segretamente farsi decidere da altri le cause» (cfr. rapporto del s.int. di Alcamo del 27 novembre 1849 all'intendente di Trapani, ivi. Affari generali (1849-51), fase. Spirito pubblico). Sul conto del giudice regio di Castellammare, poi, «immense doglianze si sentono « ... » per scrocheria, abbusi ed ingiustizie» (ivi, 3 aprile 1851).
La condotta delle compagnie d'armi (composte di «parecchi ribaldi, che chiudono gli occhi sui ladri») costituiva poi una fonte di continue apprensioni per gl'intendenti borbonici, i quali comunque ne riconoscevano l'utilità contingente, almeno per assicurare nelle campagne la parvenza dell'ordine e della tranquillità: «Le compagnie d'armi - scriveva l'intendente barone di Rigilifi - sono state in tutti i tempi in parte composte da individui la cui antecedente condotta ha dato molto a sospettare, ma è pure vero che per aversi conoscenze del personale de' malfattori è qualche volta dura necessità avvalersi di taluno degli elementi che compongono quella triste genia. Se ciò era utile nella prima instituzione delle compagnie d'armi si rende in questo tempo inevitabile per le conoscenze che sono necessarie della classe de' ladri di molto accresciuta durante la rivolta. Pure si va facendo qualche rettifica la quale può ridursi completa quando la tranquillità delle campagne sarà del tutto assicurata, e le autorità locali preposte a vigilarla avranno acquistate maggiori conoscenze pel personale della trista gente e si spoglieranno dell'inopportuna ritrosia che si hanno, per la qual cosa sono sinanco renitenti a riferire la verità de' fatti, non che a dare la biografia de' piti facinorosi»80.
80 Cfr. il rapporto riservato sullo spirito pubblico per il mese di ottobre 1849 inviato al luogotenente generale in Palermo, ivi. Scriveva poi il s.int. di Alcamo che il capitan d'armi del suo distretto era imparentato con le «famiglie prepotenti Ferro, Polizzi e Guarrasi» (ivi, 27 novembre 1849).
L'isolamento in cui si trovava il comune di Castellammare rendeva piti gravi le condizioni d'insicurezza dei suoi abitanti, favorendo la tendenza a ricorrere all'opera mediatrice di quanti ormai usavano la violenza per accrescere il proprio «rispetto». E usavano il rispetto per comporre - entro la gerarchia del potere mafioso - i conflitti che potessero insorgere tra ladri e derubati. Da qui le pressioni esercitate sui funzionari del luogo per impedire che si scoprissero i frequenti reati contro la proprietà81; nonché le resistenze interposte per differire il pagamento dei tributi, tanto che gli esattori erano sempre in arretrato sulla riscossione, per p.s., della fondiaria82.
81 Il s.int. di Alcamo informava l'intendente di Trapani che, dal 15 maggio al 20 giugno 1849, erano avvenuti nel suo distretto 57 reati contro le persone e la proprietà. Si trattava, comunque, dei soli reati per i quali «le parti offese hanno inoltrato querela innanzi la giustizia, ma bisogna sapersi che mancano « ... » gli altri non pochi successi a danno di tal une persone, che temendo nuovi attentati, se parlassero, hanno fatto il sagrificio di tenere occultati i danni sofferti, e le scroccherie, come tra essi sarebbero i nominati Vincenzo Cammara, Salvatore La Rocca, Giuseppe Stellino, don Melchiorre Giancontieri, ed altri, ed altri». «Un altro genere di timore - aggiungeva il funzionario - impedisce a' derubati nelle campagne, e nelle pubbliche strade, di querelarsi presso la giustizia, ed è quello, che a' medesimi incutono i soldati d'armi responsabili della indennizzazione de' furti» (ivi, riserbata del 30 giugno 1849). In poco piu di un anno, dal 12 gennaio 1848 al 14 maggio 1849, si erano avuti a Castellammare, su un totale di 116 reati contro le persone e la proprietà 55 furti qualificati e 23 abigeati. Inoltre erano state uccise nello stesso periodo 27 persone e ferite altre nove (v. Stato indicante i fatti criminosi già cit).
82 ASP, Pref. Gab., 1861-62, b. 2; rapporto del s. pref. di Alcamo al luogotenente generale in Palermo, 7 maggio 1861. La rendita imponibile delle proprietà fondiarie ubicate nel Comune di Castellammare ascendeva, in quegli anni, a lire 186 642,73.
Si preparavano in questo modo le circostanze perché un certo potere informale predisponesse i piu forti ad usare la violenza mafiosa come il solo mezzo efficace per assicurarsi il diritto alla promozione sociale, e i piu deboli a subirla per non farsi sopprimere. Del resto, l'impotenza delle istituzioni dello Stato, se non proprio la loro connivenza piu o meno strumentale con i trasgressori della legge, assoggettava quest'ultima all'interesse di chi sapeva servirsene, o ne poteva neutralizzare i possibili inconvenienti. E poiché la legge, per avvalorare le proprie funzioni, doveva esercitarsi su qualcuno, un tale esercizio lo pativano soltanto coloro che erano esclusi dal potere (formale o extralegale). Era quindi l'aleatorietà della Giustizia, il sospetto che un rito oscuro ne propiziasse l'inefficienza di fronte ai potenti, a produrre la necessità dell'autogiustizia. Ne conseguiva che, in funzione dell'acquisto della roba, l'autogiustizia potesse meglio sperimentare le sue attitudini delittuose all'interno di un sistema regolato da rapporti di soggezione e di connivenza, e perciò tendente a coinvolgere in esso il maggior numero d'individui.
Pertanto riusciva impossibile acquistare al di fuori di un tale rapporto funzionale il profitto materiale; e per esso si configuravano precise modalità di esecuzione. Nella scala dei valori mafiosi, l'abigeato, compiuto a vantaggio proprio o di altri, rappresentava una specie di apprendistato del giovane malvivente, e qualificava la sua vocazione e abilità. Cosi nella carriera dei piu noti mafiosi di Castellammare (lo si vedrà in seguito per i Ferrantelli) il furto di bestiame si riconosceva, all'origine, come un segno indiscutibile di mafiosità83. Quando poi l'ascesa sociale dell'ex abigeatario egiuvini d'onuri aveva raggiunto le posizioni della rispettabilità borghese, era la compenetrazione con gli organi giuridici dello Stato che ne affermava integralmente il prestigio: l'investitura formale del potere, dopo il riconoscimento della sua qualità di mafioso da parte del pubblico. Lo «stile di vita» dell'uomo di rispetto è tutto in questa sua capacità di adattare alle situazioni del momento il proprio bisogno di arricchimento, o almeno di salvaguardia dei beni acquisiti. Quanto piti egli si rendeva partecipe di una certa gestione del potere legale, o gli era anche solo possibile praticare la mediazione con esso, tanto piti crescevano gli accorgimenti mimetici della sua condotta. Diminuiva l'uso della violenza, dell'autogiustizia, sostituita dalla forza coercitiva della Giustizia codificata, ormai disposta alla complicità e all'arbitrio in suo favore.
83 Un elenco di abigeatari e «sospetti ladri», approntato nel settembre 1849 dalle autorità borboniche, comprendeva già gli elementi del futuro quadro mafioso del paese. L'elenco contiene trenta nomi di sospetti, proposti per il domicilio forzo so (vi si trovano anche alcuni che saranno in seguito imputati per i fatti accaduti a Castellammare nel gennaio del 1862): Vincenzo Coco di Giuseppe, Mariano Mione di Nicolò, Ignazio, Bernardo e Giuseppe Mattareila di Giacomo, Giuseppe Bologna di Filippo, m.ro Damiano, m.ro Camillo e m.ro Pietro Buffa di Antonio, Domenico Russo di Salvatore, Giuseppe Buffa fu Gaetano, Gioacchino Valente di MeIchiorre, Pietro Galante di Giacomo, Nicolò Canzo neri di Leonardo, Croce Gargagliano di Filippo, Leonardo Quagliata di Giacomo, MeIchiorre Valenti di Gioacchino, Pietro Ingoglia di Isidoro, Nicolò e Giuseppe Vario di Carlo, Rosario Mortillaro di Giuliano, Carlo Carollo (alias caruso) di Francesco, Francesco Ferrantelli di Francesco, MeIchiorre, Vito e Ambrogio Sottile di Vincenzo, Gaetano Ancona Pullo di Girolamo, Pasquale Cannella di Giuseppe, Giuseppe La Franca di Giuseppe, Antonino Burgarello di Giuseppe (cfr. Notamento di tutti gl'individui del Comune di Castellammare che se ne sono allontanati e che non saprebbero giustificarne la cagione, in AST, FI, Polizia, Corrispondenza (1849-53), fase. Castellammare, doc. 5; v. anche lo Stato nominativo di tutti gli arrestati per misure di Polizia lungo il periodo del mese di Maggio 1849 sino a Dicembre 1850, ivi, doc. 9).
Può riuscire addirittura esemplare, in tal senso, ricostruire sulla traccia dei documenti d'archivio la carriera mafiosa di Gioacchino Ferrantelli e della sua famiglia. I Ferrantelli erano considerati dalle autorità di polizia «villici, armiggeri, e ladri di abigeato e di componenta». La posizione di rispetto, già acquisita per avere essi «moltissima influenza ne' contadini e nel popolo», trovò negli avvenimenti del 1848-49 le condizioni piti adatte al suo esplicarsi, anche nel senso della legittimazione da parte del potere costituito. Gioacchino Ferrantelli si mise a capo degl'insorti e, «quantunque inalfabeta», pervenne presto alla carica di comandante della guardia nazionale. Valendosi del suo ascendente sul pubblico, «ebbe l'avvedutezza proteggere i furti che si commettevano fuori il Comune, che lo han reso mediocremente comodo; impedire quelli che si volevano tentare nel paese stesso, e divenne interpositore della violenza del Comitato, e potere civico, e delle vendette private, che finir di esercitare si volevano», prendendo sotto la sua protezione il notaio Di Blasi, sul quale piu di ogni altro pesavano antichi rancori dei Castellammaresi.
«Il paese si dichiarava obbligato al Ferrantelli». Ristabilita l'autorità del regime borbonico, molti sottoscrissero in suo favore un attestato di benemerenza, che il comandante della colonna m0bile trasmise al principe di Satriano, non nascondendo però la vera identità del «benemerito»84. Frattanto l'autorità militare incontrava seri ostacoli nelle operazioni per il disarmo. Né riusciva a catturare il piu pericoloso dei latitanti, Melchiorre Valente, assassino di don Gioacchino Marcantonio. I Ferrantelli si mostrarono allora disposti a rendere «utili servizi» alla Giustizia: «Presentatisi a me i Ferrantelli, e consegnate le armi che tenevano con patente di Urbani, freddamente li ho ingiunto a partire a domicilio forzoso per tre mesi in Ustica; mostratisi ubbidienti, han dichiarato che pentiti, e convinti de' di loro mancamenti commessi, avrebbero voluto rendere de' Servizj, purché si fossero presi in considerazione, e sono si offerti. Primo: Arrestare Melchiorre Valente, che sarebbero i soli, che potrebbero piu facilmente conseguirlo, sia per la conoscenza de' luoghi, che per la fiducia che quegli dovrebbe tenere in essi, ma han chiesto impunità, che se dovesse avverarsi conflitto non rispondeme se lo ammazzassero, ed io vi ho convenuto perché perdere Valente, od uno de' Ferrantelli è sempre ottima cosa « ... » Secondo: i Ferrantelli si compromettono girare essi per tutti quegli che conoscono tenere le armi conservate, e persuaderli a disotterrarle e consegnarle al Comune in silenzio, minacciandoli in inadempimento di denunziarli; ho accettato anche questa seconda parte con darle 48 ore di tempo in cui tacitamente permetterò che si portassero al Comune armi di qualunque natura esse siano, ed avendo riarmati provvisoriamente i Ferrantelli»85.
84 Cfr. il cito rapporto del com.te la colonna mobile in Castellammare al principe di Satriano, N. 374 del 13 settembre 1849 (ivi).
85 Cfr. il rapporto del com.te la colonna mobile in Castellammare al principe di Satriano, N. 375 del 13 settembre 1849 (ivi).
L'impunità richiesta per la possibile eliminazione di Melchiorre Valente avrebbe dovuto convincere l'ufficiale borbonico che essa equivaleva, piu semplicemente, al proposito di ucciderlo in ogni modo, per ridurre al silenzio chi poteva essere depositario imbarazzante di certi segreti. Nel delitto Marcantonio, Valente era stato un semplice esecutore del1a volontà del notaio Di Blasi. E ciò affermarono i giudici del1a Gran Corte Criminale che istruirono il processo contro gli assassini e i loro complici, ma non poterono piu dimostrare dopo che lo stesso Valente fu ucciso in oscure circostanze86.
Il permesso accordato ai Ferrantel1i di girare armati per il paese rappresentava poi un atto di assenso al1a loro posizione di rispetto, tanto piti grave in quanto veniva a legittimarla pubblicamente. Poiché, in ogni caso, si rendeva possibile esercitare una certa «protezione» sui cittadini, in forme extralegali, o entro le norme del potere costituito, il prestigio mafioso ne risultava cosi notevolmente accresciuto. A Gioacchino Ferrantelli non sarà perciò difficile riconquistare man mano le posizioni perdute. E, intanto, nel luglio del '51 gli fu rilasciato dal giudice regio un «foglio d'elezione di custode de' fondi» appartenenti a ventuno proprietari del1a contrada Fraginesi, che per lui, e per Gaspare Ganci, avevano inoltrato al1e autorità locali una richiesta in tal senso87. Per il campiere Gioacchino Ferrantel1i doveva trattarsi, comunque, solo di riaffermare prestigio e influenza con l'aiuto dei ventuno proprietari, quasi tutti notabili che contavano nel paese (come l'arciprete Galante e il dr. Francesco Borruso), i quali cosi manifestavano pubblicamente il loro legame di devozione o, almeno, di solidarietà con lui. Poco dopo, infatti, egli lasciava quella guardiania per dedicarsi a proficui affari d'intermediazione e, successivamente, a mirate speculazioni fondiarie, attraverso cui gli sarebbe stato possibile costituire su basi piti sicure la propria posizione economica.
86 [vi, rapporto ci!. n. 374.
87 Nota de' proprietari delle contrade della Piana, Castellaccio, ed Acqua della Vite i quali vogliono custoditi i frutti delle rispettive proprietà da' Signori Gioachino Ferrantelli del fu Francesco e Gaspare Ganci fu Salvadore, in AST, FI, Polizia, Affari diversi (1851). La documentazione raccolta nel fascicolo è frutto di una manifesta manipolazione delle autorità locali. In un primo tempo, il giudice regio di Castellammare aveva indicato esattamente in Gioacchino Ferrantelli di Antonio, nato nel 1807, il campiere richiesto dai ventuno proprietari (tra i quali erano l'arciprete Girolamo Galante, i sacerdoti Antonio Romano, Francesco Barone, Antonino Galante e Tommaso Sceusa, i civili Leonardo Zangara, Vincenzo Cajozzo e Francesco Borruso). Però l'intendente di Trapani, che aveva riscontrato il suo nome tra gli abigeatari (furto di un cavallo commesso a danno di Giuseppe Licata, in contrada Pianello; v. ruolo dei processi criminali, n. 56 del 1850), aveva negato il permesso. Si era perciò reiterata la richiesta (giustificando un errore di omonimia commesso precedentemente dall'ufficio), questa volta sotto il nome di Gioacchino Ferrantelli fu Francesco, di anni 55, di professione «marino», atte stando, inoltre, che lo stesso andava «freggiato di buoni e morali costumi» e che godeva «favorevole opinione presso questo pubblico per la di lui sperimentata condotta sotto tutti i rapporti tenuta» (v. dichiarazioni dell'arciprete Galante e del giudice regio Gullo, 12 luglio 1851, ivi). In realtà, come risulta da testimonianze coeve, il campiere di quelle contrade sarebbe stato Gioacchino Ferrantelli di Antonio. Del resto, può apparire per lo meno strano che un marinaio venisse scelto a custodire quei fondi.
Dietro questo comportamento di Gioacchino c'era l'antico giudizio di usare violenza fisica e servilismo secondo le circostanze e gli umori dei potenti. Del resto, la vicenda degli altri componenti la parentela dei Ferrantelli, che non erano riusciti (e quasi tutti) ad emergere da una condizione di subalternità, dimostrava come fosse difficile abbandonare il proprio stato. Dalla folla dei bracciali e dei pastori che si erano insediati sulle terre del barone era uscito fuori mezzo secolo prima uno solo (Gioacchino) a iscriversi, come censuario, nel ruolo dei possessori di un fondo, in contrada della Piana, esteso una salma e 15 tumoli, su cui gravava, oltre al censo, un'imposta annua di 25 tari88. Ne era discesa numerosa figliolanza, tra cui un Vincenzo, che aveva trovato meglio degli altri la spinta per una piti rapida promozione sociale89, e un Antonio, padre del nostro Gioacchino. Nel contesto parentale, la famiglia di Antonio Ferrantelli avrebbe rappresentato una condizione rurale di ceto medio-basso, posto tra un esiguo gruppo di rent capitalists e la massa anonima e angariata dei piccoli coloni e giornalieri, caprai e guardiani di mandre, che ritroveremo in alcune frange disperate in mezzo ai rivolto si del gennaio 1862.
88 ASME, Tassa alla ragione del quattro per cento sopra il fruttato del territorio di Monte San Giuliano (1808), miscellanea 902. Se ne ricavava un reddito annuale di onze 2l etari 6.
89 Testamento di Vincenzo Ferrantelli del 30 aprile 1857 in noto Vincenzo Galante (AST, 1044, ff. 117r-121r). D. Vincenzo lasciava in parti eguali i suoi beni ai figli Gioacchino, Giacomo, Antonina, Marianna, Domenica, Teresa e Maria; vitalizi alla moglie Giacoma Verderame e alla figlia Giuseppa (suor Maria Vincenza), moniale nel reclusorio di S. Chiara in Alcamo, e 200 onze per messe e beneficenza. L'anno dopo dettava un altro testamento (not. Andrea Di Blasi, 17 marzo 1858: AST, 1024, ff. 675r-679v), in cui, dichiarando di voler lasciare «in anteparte» i suoi beni, metà ai figli maschi e metà alla moglie e alle figliuole, faceva inserire il seguente codicillo: «Dichiaro che da piu anni non esercito verun negozio, e traffico, essendomi anche dismesso della Masseria, e che perciò tutti i generi i quali in atto si trovano, e che nel giorno della mia morte potranno trovarsi nei miei magazini sotto stanti al casamento ove abito, appartengono a mio figlio Don Giacomo che da piu tempo esercita un negozio ed una industria da me separata». Successivamente i due figli Gioacchino e D. Giacomo si dividevano l'eredità paterna (not. Vincenzo Galante, 19 marzo 1861: AST, 1047, ff. 71r-109v). Il quadro dei beni rustici e urbani, che restavano cosi indivisi fino al 1861, comprendeva un patrimonio fondiario di ettari 19,506 distribuiti nelle contrade di Timpone della Pupa, Omomorto e Barone (v. in AST, Catasto provvisorio del Comune di Castellammare, voI. 5, art. 1456).

Si possono ricostruire, intanto, i tempi e le fasi dell'ascesa sociale che porterà i Ferrantelli, prima Vincenzo, poi Gioacchino, ad entrare nel ceto dei galantuomini (borgesi ricchi e civili)90. Negli atti notarili del periodo 1823-35 Vincenzo compare come contraente o disponente in piccoli affari di compravendita, gabelle e subgabelle, cessioni, mutui e obbligazioni che, tuttavia, non configurano ancora una condizione borghese. È però significativo che egli si dedichi presto alla pratica usuraria del soccorso frumentario. In un solo anno (il 1823) dà in prestito a 43 contadini 30 salme e 8 tumoli di grano91. E frattanto prende in fitto con altri borgesi il bosco di Calatafimi per tagliarvi i sògari92. Successivamente la natura intermediaria e capitalistica dei suoi negozi si fa piu distinta. Anzitutto per i numerosi prestiti a cambio marittimo. Nel quinquennio 1836-40, in cui piu frequentemente si trovano tali prestiti, egli impiega qualche migliaio di onze per «tragittarle» sopra sette sciabecchi latini. L'interesse che ne ricava è di due onze e sei tari al mese per ogni cento onze approntate93. Inoltre compra bestiame grosso (specie tra il 1835 e il 1844) e, per allevarlo, costituisce una società col genero Pietro Galante94. Compra pure olio e frumento per rivenderli.
90 Si veda nella tabella riportata nella pagina accanto la genealogia della famiglia Ferrantelli. Il capo stipite Francesco era venuto a Castellammare da Burgio (Girgenti) nella prima metà del '700. Il figlio Gioacchino si era sposato in prime nozze con Maria Cusenza, dalla quale aveva avuto l'unica figlia Maria (n. 1'8 marzo 1763).
91 Atti del 6 gennaio 1823 in not. Domenico Calcara (AST, 1006, ff. 13r-16r). Il soccorso prestato fra ottobre e dicembre viene computato in denaro contante (4 onze a salma peri! grano, 4 onze e 6 tari a salma per l'orzo) da restituire entro il 15 luglio successivo.
92 Atto dello aprile 1825 in not. Rosario Emanuele Plaja (AST, 959, ff. 25r-26v). La società era costituita fra Vincenzo Ferrantelli, Giacomo Verderame, Antonio Piranio, Antonio Domingo e Paolo Foderà per il taglio e la «carricatina» dei sògari del bosco di Calatafimi ad essi venduti da D. Gaetano Stabile.
93 Il primo dei prestiti a cambio marittimo concessi da Ferrantelli a proprietari di navigli è registrato in not. Giuseppe Mangiarotti, 28 febbraio 1836 (AST, 1107, ff. 173r176v). Poiché uno dei contratti (quello stipulato i! 6 aprile 1839 da padron Bernardo Portuesi) non potè essere onorato, né per i! capitale approntato, né per gl'interessi maturati, Vincenzo Ferrantelli si prese la terza parte dello sciabecco su cui erano state «tragittate» le 200 onze del prestito (atto del 5 maggio 1840, ivi: AST, 1110, ff. 205r-208r). Contratti a cambio marittimo e mutui ipotecari (su cui in gran parte si costituisce la proprietà fondiaria di Vincenzo) sono poi registrati specialmente nel decennio '46·'56. A partire dal 25 marzo 1856 prestatori di denaro al 7% figurano i figli Gioacchino e D. Giacomo.
94 Atto di società del 18 febbraio 1842, ivi, tra Vincenzo Ferrantelli e Pietro Galante di Giacomo per conduzione di bestiame grosso alla Gagliardetta. Il suocero Ferrantelli, proprietario della mandra, entra per due/terze parti nella società (AST, 1112, ff. 595r-598r). La società armentizia con Galante viene sciolta quattro anni dopo (atto del 5 settembre 1846 in noto Andrea Di Blasi: AST, 993, ff. 53r-56v). Per gli acquisti di bestiame, v. in not. Giuseppe Mangiarotti, tra gli altri, atti del 24 luglio 1835 (Antonino Navarra vende, per 706 onze e 12 tari, a Vincenzo Ferrantelli 44 vacche, 2 tori, 26 vitelli e 190 capre), 30 settembre 1838 (società armentizia in terza parte con Nicolò Giordano) e 21 febbraio 1844 (il borgese Mariano Cascio gli vende per 125 onze 21 bovini). Vincenzo divideva poi il suo bestiame col figlio Gioacchino, al quale toccavano oltre 200 capi tra bovi, vacche e giovenchi (atto del 5 novembre 1850 in not. Vito Parisi: AST, 1190, fI. 59r-6Ir). Successivamente divideva ancora con Gioacchino e con l'altro figlio Giacomo il bestiame nel frattempo acquistato, per un valore stimato in IO 761 ducati (atto del 3 marzo 1856 in noto Andrea Di Blasi: AST, 1018, fI. 334r-337v). Vincenzo donava pure ai figli gli attrezzi di mandra, con aratri, gioghi e carri, che si trovavano nell'ex feudo d'lnici («mezza montagna» e latifondo di salme 62 della corda locale), da tempo affittato per la sua attività armentizia.
Il suo patrimonio fondiario, non molto esteso, ma abbastanza redditizio per essere destinato alle colture della vite e dell'olivo, si forma quasi tutto tra il '35 e il '55: gli anni, cioè, in cui egli può accumulare i piu alti guadagni mediante i cambi marittimi, il traffico armentizio e quello frumentario. Ha le sue terre nelle contrade vicino al paese (Dàgala, Barone, Timpone della Pupa), pochi tumoli all'inizio, ma in seguito accorpate con avveduti acquisti in unità poderali di media dimensione95.
95 Si può seguire il processo costitutivo della proprietà fondiaria dei Ferrantelli attraverso gli atti notarili. Generalmente l'interesse di Vincenzo si concentrò sui fondi vignati dei Fraginesi. Per il pascolo degli animali egli preferi prendere in fitto l'ex feudo d'lnici e, di rado, ingabellò (o subgabellò) terre da concedere a coloni per seminarle ad orzo e a frumento. La tenuta di Timpone della Pupa era originariamente formata da pochi tumoli (atto del 14 settembre 1823 in not. Domenico Calcara: AST, 1006, ff. 427r-432v). Vi si aggiunsero nel tempo altri sei fondi piu o meno estesi, fino a raggiungere trent'anni dopo una estensione di ettari 14,526, coperti per i tre/quarti da vigneto e stimati dai consoli di campagna per un valore di 1828 onze. Cfr. la concessione a perpetua enfiteusi per un canone annuo di 275 ducati ai figli Gioacchino e Giacomo (atto del 3 marzo 1856 in noto Andrea Di Blasi: AST, 1018, fI. 338r-365v). Alcuni di questi fondi pervennero a Ferrantelli in risarcimento di prestiti usurari non soddisfatti. Uno dovuto dal fratello Camillo, al quale Vincenzo aveva prestato 400 onze (not. Rosario Emanuele Plaja, 7 giugno 1825: AST, 959, fI. 85r-91 v). Altri dovuti da contadini e, anche, da civili che avevano i loro fondi finitimi a quelli di Vincenzo Ferrantelli, come, ad es., Sebastiano Magaddino e i suoi familiari (not. Giuseppe Mangiarotti, 2 febbraio 1840: AST, 1110, ff. 17r-38r; not. Andrea Di Blasi, lo gennaio 1847: AST, 995, fI. 23r-28r; ivi, lo giugno 1851: AST, 1004, fI. 739r-742v; ivi, 6 gennaio e 21 marzo 1855: AST, 1017, fI. 43r-56v, 61Ir-616r; ivi, 15 agosto 1856: AST, 1019, ff. 147r- 150v). Dal 1851 al '56 è il periodo di maggiore attività dei Ferrantelli nell'acquisizione di piccole tenute ai Fraginesi, mentre negli stessi anni Vincenzo dona «in anteparte» i propri beni ai figli.
I vigneti, coltivati in proprio, li «dona all'acconcio», spendendo un'onza e sei tari per ogni migliaio di viti96; gli altri terreni li dà a colonia parziaria per farvi seminare grano ed orzo97. Vincenzo muore nel '58; ma nel frattempo le sue figliole si sono sposate bene e i maschi, Gioacchino e Giacomo, ereditano molto denaro contante che consente di affrontare con forza il mercato dei grandi affitti, tra cui certo il piu lucroso è quello della niviera d'lnici che essi assumono già nel '5698.
96 Atto del 15 novembre 1837 in not. Giuseppe Mangiarotti (AST, 1108, fI.613r618v) per acconcio delle vigne alla Gagliardetta (zona detta Ferriato) e ai Fraginesi. V. pure ivi, atto del 28 novembre 1839 per i fondi Dàgala, Barone e Timpone della Pupa.
97 Atto del 29 giugno 1836, ivi (AST, 1107, fI. 399r-404r). Successivamente in noto Andrea Di Blasi, 15 agosto 1847: AST, 996, ff. 638r-644r.
98 Gioacchino e D. Giacomo Ferrantelli, insieme con Salvatore Domingo, contraggono società per l'affitto della niviera d'lnici per quattro anni, concordando col proprietario, il marchese Antonio Cardillo, un annuo estaglio di ducati 255 (atto del 23 marzo 1856, ivi: AST, IO 18, ff. 424r-435v). Si veda il contratto di società riportato in appendice; v. pure il primo rendiconto economico della gestione societaria, ivi, 6 febbraio 1859 (AST, 1028, ff. 211 r-218v). Vent'anni dopo la niviera d'lnici era ancora gestita dalla famiglia Ferrantelli (ivi, 19 marzo 1875).
La migliore posizione raggiunta da Vincenzo Ferrantelli e dai suoi figli costituisce, dunque, per i parenti meno fortunati, forse piu che un traguardo economico cui tendere, un modello della qualità borghese da acquisire, per la sperimentata capacità d'inserirsi in una certa rete speculativa, amministrando con oculatezza denaro e interessi multimediari. I figli di don Vincenzo sapranno distaccarsi meglio dal puro esercizio dello sfruttamento contadino per tentare, con un certo successo, nuove vie alla percezione della rendita. A legittimare la loro presenza nei li velli superiori della società verranno pure i matrimoni con elementi del ceto civile piu radicato nel paese99.
99 Convenzione fatta al regime dotale, con dotazione e donazione di beni del valore di onze 1300 (pari a lire 29 361,70), oltre alla quota dell'eredità del sacerdote Antonio Barone, per il matrimonio tra Girolama Riggio, figlia del dr. Simone, e D. Giacomo Ferrantelli (atto del 30 aprile 1861, ivi: AST, 1033, ff. 1199r-1204r). Gioacchino sposò la figlia di un ricco borgese. Le figliole di don Vincenzo si accasarono con civili piu o meno danarosi (Anna Maria e Domenica coi figli di D. Antonino Navarra) o con massarioti benestanti (Marianna e Maria Teresa coi figli di Giacomo Galante). Maria Antonina, infine, sposò il dr. Giovanni Marcantonio.
Invece la massa indifferenziata di villici e caprai che fòrmal'estesa parentela dei Ferrantelli ha avuto fino a quel momento ben scarse possibilità di ritagliare qualche striscia di terra dal latifondo ex baronaIe. Nel catasto degli anni '40, successivamente integrato con le nuove acquisizioni immobiliari, i possessori di fondi rustici, sia pure minuscoli, sono davvero pochi: sei in tutto, che si dividono ettari 4,994 di proprietà100. Il tentativo di varcare il limite dell'impossidenza agisce, entro la stessa parentela, come uno stimolo a confrontarsi e a superarsi. Quindi a poter cogliere le occasioni della mobilità sociale che ora sembrano presentarsi piu numerose e reali, ma che poi vengono negate dalle rigide difese del potere proprietario, o almeno dalle ferree leggi del mercato.
100 AST, Catasto provvisorio, cit., voI. 5 (Camillo, Francesco, Gioacchino di Francesco, Giuseppe, Natale e Sebastiano Ferrantelli).
Per il contadino la terra, prima che un'aspirazione, è una promessa. Ogni ostacolo che si presenta a impedire la realizzazione di un ideale tanto coinvolgente acquista per lui il significato di una sfida e, insieme, di una beffa, che attendono i tempi inesorabili della rivalsa. E intanto la spietata separatezza dal ceto civile fa aumentare i contrasti di mentalità, entro cui tuttavia non si saldano gl'interessi di classe, su un fondamento comune dei bisogni e delle aspirazioni. Se è comune il convincimento di trovarsi segnati da uno stesso destino di fatica e di miseria, è invece individuale il desiderio di distaccarsene per intraprendere ciascuno quel processo di crescita che dovrà portarlo a divenire borgese e massaro. Si deve poi ricordare che le 'nGiurie, ossia i soprannomi che distinguono un gruppo familiare da un altro entro la stessa parentela, riducono l'identità degl'individui alle funzioni esercitate o ai tratti peculiari della fisionomia e del carattere; e perciò denunciano nella stessa opinione del pubblico un grado d'ignobilità rispetto a chi ha potuto essere ammesso nel ceto civile e acquisire qualifica professionale, potere e autonoma redditività: cioè un vero nome e cognome. I Ferrantelli, ad es., sono indicati con soprannomi diversi: libbrinu (leporino), scarpetta, sona ca ti pagu. In quest'ultimo caso l'uso della metafora si riferisce all'attività secondaria del campiere Francesco Ferrantelli di Francesco (musico popolare o, forse, esecutore materiale di giustizia mafiosa?).
Il ramo della famiglia che sarebbe disceso da Antonio (1781-1877) poteva considerarsi comunque avviato verso una faticosa, ma promettente, auto sufficienza economica. Antonio possedeva all'inizio soltanto un piccolo fondo (pervenutogli in eredità dal padre) di poco pili di due tumoli, su cui gravava un censo enfiteutico. In seguito, aveva potuto acquistare un altro fondo di quasi due salme, pur esso gravato di censo101. Nessun'altra acquisizione di beni rustici pare piu interessarlo, se all'epoca del catasto formato nel 1842/44 le sue proprietà erano ancora quelle di trent'anni prima, con una rendita netta pressoché eguale, calcolata nel 1865 in lire 114,96 annue102. In effetti, Antonio non seguirà il fratello Vincenzo nei suoi tanti affari d'intermediazione. Una mentalità troppo legata ai cicli perenni del mondo agro-pastorale lo estraniava dall'alea infida del rapporto interpersonale di puro risarcimento economico. Ciò che in Vincenzo era affanno e gioia nella ricerca dei mezzi atti a procurare la rendita feneratizia non poteva interessare il capraro Antonio Ferrantelli, il cui orizzonte rimaneva pur sempre chiuso entro i màrcati della Gagliardetta.
101 Atti del 5 marzo 1815, 3" ind., in noto Gaetano Maria Di Blasi (AST, 1032, fI 88v-92r) relativi alla vendita di un luogo di vigne e terre seminerie in contrada Castellazzo. Antonio Ferrantelli fu Gioacchino vi è indicato come capraro. Oltre a questo fondo da cui ricavava un reddito annuo di 12 onze e 15 tari, egli rivelava al fisco i due tumoli di terra di contrada della Piana ereditati dal padre, con un reddito annuo di un'onza e 21 tari. Sui due fondi gravavano onze 4 e tari 13 di censo (AST, Commissione per la rettifica dei riveli. Comune di Monte S. Giuliano, Riveli del 1816, val. 19, n. 1638).
102 AST, Catasto provvisorio, cit., vol. 5, art. 1438, Antonio Ferrantelli fu Gioachino.
Erano iscritti in catasto i terreni di Castellaccio e Costa del Romito (ettari 1,257 di vigneto, 3,349 di seminerio e 838 millesimi di ettaro metà rampanti e metà coperti da olivi), un palmento e un magazzino. Le originarie misure agrarie espresse in salme e tumoli furono ridotte in ettari nella copia del catasto, da me consultata, eseguita a cura della Prefettura di Trapani nel 1865.
Cosi può dirsi che la sua attività di contadino/borgese resta esclusivamente vincolata agli affari di gabella che egli poté concludere fin dagli anni '20. Il 31 luglio 1821 (noL Domenico Calcara) Antonio stipulava un contratto di società con mastro Vito Messina, affittuario dell'ex feudo valle di Celsa e rampanti della Concia (di proprietà del duca della Ferla), per condurvi greggi e armenti. Scioltasi di comune accordo l'associazione dopo un solo anno, Antonio restava subaffittuario dell'ex feudo, pagando l'annuo estaglio di onze 92 e tari 15, oltre ai camaggi (50 rotoli di tomazzi)103. Ma egli era ancora debitore, nel '27, della maggior parte della somma concordata per il fitto di tre anni (1823-26), pur riuscendo a farsi rinnovare alla scadenza il contratto di subgabella104. Lo troviamo in seguito affittuario dell'ex feudo d'Inici, di proprietà del marchese Cardillo. È il salto verso la condizione del massarioto, che può disporre di una grande azienda agro-pastorale per distribuire le tipologie colturali (rotazioni agrarie) e di allevamento secondo criteri di produttività ottimale, s'intende nel contesto dell'economia del latifondo. Antonio, perciò, subaffitta per sei anni 33 salme dell'ex feudo - e precisamente la parte detta della Pecoreria al fratello Vincenzo e ad Antonino Navarra (estaglio concordato 140 onze e 24 tari l'anno)105, i quali, poi, le subconcedono ad altri piccoli borgesi 106.
103 Atto del 14 settembre 1823 in noto Domenico Ca1cara (AST, 1006, Cf. 433r-436r).
104 Not. Gaetano Maria Di Blasi, 20 maggio 1827 (AST, 1041, Cf. 218r-224r).
105 Contratto del 29 maggio 1836 in not. Giuseppe Mangiarotti (AST, 1107, Cf. 341r-347v). Vincenzo Ferrantelli paga al fratello Antonio l'intera somma che gli spetta per la gabella di Pecoreria, Noce e Fontanelle in ex feudo d'lnici (ivi, 1112, dichiarazione dell'11 dicembre 1842, Cf. 696r-699r).
106 Atto di subconcessione del 29 giugno 1836 (ivi, 1107, ff. 399r-404r).
È il cerchio stringente dello sfruttamento contadino basato sugli affitti di seconda e di terza mano (fino a raggiungere ai livelli piu bassi dell'affittanza terraggieri e coloni), in cui Antonio riesce ad entrare nella posizione privilegiata dell'intermediario e dell'imprenditore. Tre anni dopo si associa il fratello Vincenzo e il figlio Gioacchino nell'affitto d'lnici, probabilmente per la necessità di attingere a maggiori risorse di denaro onde regolare i conti dell'azienda e acquistare altro bestiame. L'affitto dell'ex feudo d'lnici, con la Noce e Pecoreria, era stato già pagato fino ad agosto '39 da Antonio. Ora il patto di società aveva la durata di due anni e conteneva le clausole per la gestione della masseria onde «goderne il lucro e soffrirne la perdita» eventuale in tre parti eguali e distinte. Si stabiliva anche che chi voleva far pascolare nelle terre dell'ex feudo un numero di capi di bestiame superiore a quello concordato dovesse pagare la fida secondo i prezzi del mercato locale: tre onze per ogni vacca, due per ogni giovenco e diciotto per centinaio di capre. È anche probabile che nella divisione dei compiti all'interno dell'azienda agro-pastorale toccasse a Vincenzo Ferrantelli di sovrintendere ai lavori di semina e di raccolta del frumento, per i quali si chiedeva di poter «godere la spesa del pane e vino giusta l'usanza»107. Però la piu forte posizione economica di Vincenzo non avrebbe consentito alla società di durare a lungo. A metà degli anni , 40, infatti, i contratti di colonia parziaria e quelli di fida per la montagna d'lnici e per le terre della Noce e di Pecoreria sono registrati a nome del solo Vincenzo, cui in seguito si associano i figli Gioacchino e Giacomo108. Antonio forma un'altra società armentizia col figlio Gioacchino e col cognato can. D. Leonardo Palermo, che scade nell'agosto del '46. Frattanto egli si ammala cosi gravemente da pensare di dover chiudere per sempre la sua attività di borgese: «essendo infermo di corpo», detta perciò il suo testamento (27 febbraio 1845) che, tuttavia, non sarà pubblicato se non trent'anni dopo, quando egli morirà in età molto avanzata109.
107 Atto di società tra li signori Antonio. Vincenzo e Gioachino Ferrantelli, 28 agosto 1839 (ivi, 1109, ff. 311r-315v).
108 Dall'8 settembre 1845 don Vincenzo e i suoi figli subentreranno nell'affitto d'lnici ad Antonio e a Gioacchino Ferrantelli (atto in not. Andrea Di Blasi: AST, 990, ff. 95r-I01r). Gioacchino di Vincenzo dividerà in seguito la montagna d'lnici con lo zio Francesco Maria Verderame (atto del I o novembre 1848 in not. Gaetano Mangiarotti: ANT, 2313, ff. 918r-923r). I Verderame, borgesi e negozianti, agivano, come Vincenzo Ferrantelli, oltre che sul mercato della terra, su quello della intermediazione finanziaria. La loro ascesa sociale apparirà rinforzata, in seguito, attraverso le parentele strette fuori del paese con famiglie dell'alta borghesia agraria.
109 Testamento per atto pubblico del 27 febbraio 1845 in not. Giuseppe Mangiarotti (AST, 1117, ff. 308r-313r). Antonio avrebbe lasciato 20 onze per messe all'arciprete Galante e 25 onze al culto di Maria Santissima Immacolata nella chiesa di Sant'Antonio di Padova. E inoltre pensava di offrire una giovenca alla chiesa matrice di Castellammare. I beni immobili e gli animali li avrebbe voluti dare in parti eguali a tutti i figli; ma ai due maschi minori, a quell'epoca ancora celibi, la tenuta di terre che possedeva alla Gagliardetta. Successivamente egli modificava in qualche parte le sue volontà (testamenti del 7 e del 23 febbraio 1871 in not. Vito Mattarella: ANT, 4026, ff. 7r-IOr, 47r-50v; e del 31 dicembre 1872 in not. Salvatore Briguccia, ivi, 3304, ff. 255r-256v), con lasciare al solo Gioacchino il fondo rustico della Gagliardetta (con 11500 viti), che gli aveva già dato in fitto il l° dicembre 1868 (atto in not. Vito Mattarella: ANT, 4022, ff. 1037r-1038v), gl'immobili urbani ai nipoti e al figlio Francesco. La donazione fatta alla figlia Antonina e ai nipoti di alcuni ber.i immobili sarebbe stata poi annullata da Antonio per inadempienza degli obblighi derivanti da un vitalizio istituito a suo favore (atto del 22 maggio 1875 in not. Salvatore Briguccia: ANT, 3305, ff. 548r- 551 v).
Non ostante il suo ingresso nel ceto dei borgesi, non si può dire che Antonio abbia cambiato status. Lo conferma, oltre che la sua radicata mentalità, la ristretta genealogia contadina entro cui la sua famiglia acquisisce, attraverso maritaggi e comparaggi, le nuove parentele11O. E, del resto, le stesse associazioni d'affari che egli promuove per l'affittanza dei terreni e per il pascolo restano sempre nell'ambito dei legami familiari.
Gioacchino Ferrantelli di Antonio (1807-1885) dimostra fin dalla sua piu giovane età di possedere un certo gusto del rischio e l'ambizione giusta per emergere dal chiuso mondo delle subalternità contadine. Intanto, appena diciottenne, sposa Caterina Galante, figlia di un raisi di marina. La dote è quella strettamente necessaria: cinquanta onze di giogali d'oro e argento, «come volgarmente dicesi ad uso di dote», e cento onze di corredo (materassi «a fiamma», cottonine di mussolino avvelato, piomazzi e biancheria cucita da Benedetta Greco). Il suocero gli promette pure 250 onze in denaro contante che resteranno, però, solo nelle buone intenzioni del donatore111. Raisi Galante dona inoltre alla figlia un piccolo tenimento di case nel quartiere di Sant'Antonio Abate. Quello che, invece, Antonio trasmette in dote al figlio è già abbastanza per avviarlo a una discreta rimunerazione. Cioè due fondi rustici, a suo tempo assunti a censo dal principe d'Aragona: uno di 12 tumoli, con vigne, olivi, canneto, pioppi e beveratoio, sito alla Gagliardetta; l'altro di 13 tumoli, piantato pure a vigna, nella contrada detta di Firriato. Segue un elenco di mule, giumente e capre, che hanno nel nome un valore domestico e affettivo («Tre giumente chiamate una la catalanotta di pelo morello con seguace mulaccione pure di pelo morello, altra chiamata la Piccirilla di pelo morello con altra morella, e la terza chiamata la chirchia di pelo merrino con seguace mulaccione di pelo bajo. Piu due mule, una, quella baja, di servizio, e l'altra quella novella tra loro ben sapute. Piu numero centocinquanta capre con suoi mascoli e ciaravelle secondo l'usanza»). Aggiunge sei salme di frumento, quattro di orzo e due «stipe nostrali piene di musto». Gioacchino, infine, costituisce a favore della giovanissima moglie un dotario di cinql:lanta onze per «dritto di verginità»112.
110 Anche i matrimoni dei figli rispecchiano lo scarto sociale che sussiste nei confronti della famiglia formata dal fratello Vincenzo. Le nuove parentele sono acquisite nell'ambito del ceto contadino/borgese. Gioacchino, però, sposa la figlia di un raisi di marina, non certo danaroso se, almeno in una occasione, egli dovrà fornire al suocero, Nicolò Galante, il proprio sostegno attraverso l'ipoteca su un fondo vignato alla Piana, in garanzia di 200 onze prestategli dal sac. D. Michele Palermo per cambio marittimo (atto del 6 settembre 1840 in noto Gaetano Maria Di Blasi: AST, 1054, ff. 497r-499v). Le femmine sposano tutte contadini che possiedono qualche tumolo di terra assunto a censo e gli animali da lavoro. Solo Antonina può sposare, prima un mastro ferraro (atto dotale dell'11 settembre 1832 in not. Rosario Emanuele Plaja: AST, 966, ff. 259r-264v), poi, rimasta vedova, padron Giuseppe Sarcona (ivi, 4 settembre 1839: AST, 973, ff. 321 r-325v).
111 Solo alla morte di Nicolò Galante (v. testamento in noto Andrea Di Blasi, 3 novembre 1854) i nipoti riceveranno 375 ducati come antico dotario della madre Caterina, che morirà qualche anno dopo.
112 Atto dotale dell'11 settembre 1825 in not. Giuseppe Mangiarotti (AST, 1096, fI. 253r-267v).
Subito dopo il matrimonio, Leonardo Palermo associa il nipote nella gestione della tonnara grande di Castellammare. Due «brevetti» registrati nel repertorio del not. Giuseppe Mangiarotti (5 marzo e 7 maggio 1826) ce lo indicano, anzi, tra i fittaioli della tonnara per la pesca di quell'anno. È probabilmente solo un'esperienza senza seguito, perché non troveremo piu Gioacchino versato in simili occupazioni marinaresche. Egli penserà piuttosto a dare un migliore assetto alle sue proprietà e ad aumentarle per quanto possibile. Nel '32 permuta il suo fondo alla Gagliardetta con un altro, sito nella contrada Collo della Bolognal13. Tre anni dopo mastro Vito Messina vende a lui e al padre per 5 onze la «medietà» di un tumolo di terra alla Gagliardetta (capreria) per uso di mandra114. Il 28 agosto 1839 entra col padre e con lo zio Vincenzo nella società per l'affitto e la gestione dell'ex feudo d'lnici. Nel '43 vende per 9 onze un piccolo fondo rustico ai Fraginesi115; ma compra nel'47, per 192 onze, un fondo rustico a Piano dello Spagnolo esteso una decina di tumoli dell'antica corda (due ettari circa)116. Nello stesso anno, assume in enfiteusi dal barone Tasca una tenuta di terre nell'ex feudo Baida estesa una salma, 8 tumoli e tre mondelli (5 ettari circa), per la quale s'impegna a pagare un canone annuo di due onze e 20 tari117. Frattanto provvede con acquisti e permute ad ampliare il suo casamento in via Màcina, comprando anche stanze terrane e piano solerato di un palazzetto nella via maestral18. Quando muore la madre, Rosa Palermo, eredita le case d'abitazione (nella stessa via maestra) a lui spettanti in terza parte con i fratelli Antonino e Francesco, che un giorno donerà ai figli Giuseppe, Anna e Rosalla, ma riservandosene l'usufrutto e vincolando la donazione con la promessa che i figli lo tengano con sè fino alla morte119.
113 Atto del 12 settembre 1832 in noto Rosario Emanuele Plaja (AST, 966, fI. 265v268v). Il 26 dicembre dello stesso anno viene eletto D. Francesco Nicotri come perito per la misurazione dei due fondi permutati (atto in not. Francesco Maria Gervasi Calcara: AST, 846, fI. 617v-619v).
114 Atto del 31 marzo 1835 in noto Giuseppe Mangiarotti (AST, 1106, fI. 215r-219r).
115 Atto del 7 maggio 1843, ivi (AST, 1113, ff. 657r-662r).
116 Atto del 24 novembre 1847 in not. Andrea Di Blasi (AST, 997, ff. 543r-547r). Il fondo, vendutogli dal cognato Isidoro Galante, era coperto da 4633 viti e da alcuni alberi d'olivo.
117 Atti d'obbligo per enfiteusi a favore del sacerdote D. Saverio e del barone D. Lucio Mastrogiovanni Tasca, eredi del duca della Ferla, ivi, 8 e 12 dicembre 1847 (AST, 997, ff.81Ir-836r).
118 Atti in not. Gaetano Maria Di Blasi, 18 aprile 1841 (AST, 1055, ff. 277r-283r); not. Giuseppe Mangiarotti, 18 dicembre 1842 (AST, 1112, ff. 716r-719v) e 15 febbraio 1843 (AST, 1113, ff. 247r-250r). In seguito Gaspare Ganci gli venderà una casa contigua alla sua in via Màcina (atto del 22 marzo 1859 in not. Andrea Di Blasi: AST, 1028, ff. 645r-650r).
119 Atto di donazione del 15 maggio 1873, ivi (AST, 1036, ff. 317r-320r). Gioacchino Ferrantelli donava ai figli entrambi i casamenti della via maestra, disposti ciascuno su due piani, con 15 stanze, due magazzini e una stalla. Il testamento di Rosa Palermo è in noto Mariano Lombardo, 5 novembre 1858 (ANT, 3410, ff. 729r-730v).
Oltre venti anni di ansiosa ricerca del risarcimento della roba, non privi di amarezze e difficoltà. Qualche volta ha dovuto cercare l'aiuto interessato dello zio Vincenzo, che gli ha prestato denaro al sette per cento120. E qualche peso ipotecario gli è riuscito davvero molesto, se ha voluto persino consegnare in un atto notarile la sua ferma (ma certo irrituale) protesta contro un usuraio, dichiarando che, seppure aveva sottoscritto otto anni prima un'ipoteca sul suo. fondo vignato della Piana, per un prestito concesso al suocero dal sac. D. Michele Palermo, non voleva però essere «molestato e perturbato» per il «non fatto o ritardato pagamento». (In quell'affare egli «non vi ha avuto, nè vi ha alcun participio, commodo, incommodo, né interesse, ma il solo e semplice nome, avendo divenito il detto Ferrantelli ad obbligarsi in solido con detto di lui suocero Raisi Nicolò Galante nell'atto indicato a di lui preghiere per facilitargli lo sborzo delle sopradette onze duecento in denaro che gli furono necessarie»121.)
120 Negli anni fra il '33 e il '34, e poi il 25 ottobre 1838 (v. brevetti in not. Giuseppe Mangiarotti).
121 Dichiarazione/conservazione infavor del Signor Gioachino Ferrantelli con Raisi Nicolò Galante di lui suocero, in noto Gaetano Maria Di Blasi, 6 settembre 1839 (AST, 1054, ff. 497r-499v).
Fin qui Gioacchino - che poteva considerarsi solo «mediocremente comodo», come sosteneva nel suo rapporto del 13 settembre 1849 il comandante Almeida - non si era gran che allontanato dagl'interessi coltivati dal padre (pascolo e gabelle). La rivoluzione del '48 lo spingeva verso il potere per la «moltissima influenza» che era riuscito a conquistarsi «ne' contadini e nel popolo»: comandante della guardia nazionale, oltre che membro del consiglio civico, insieme col fratello Antonino122. È facile pensare che l'assunzione di responsabilità civili gli venisse dal ruolo d'intermediazione esercitato nel periodo precedente, che, come vedremo, aveva drammaticamente rivelato il vuoto lasciato dal potere baronale e, quindi, la necessità della giustizia privata. L'efficacia di un tale ruolo è dimostrata, poi, dalle credenziali di benemerenza (e dalla gratificazione) che i Castellammaresi gli vollero piu o meno spontaneamente rilasciare al rientro, nel '49, delle truppe del generale Satriano. Dalle autorità borboniche i Ferrantelli furono perciò considerati «sospettissimi», anche perché, all'inizio, non mostrarono «alcun segno di ravvedimento»123. Non ebbero piu né incarichi pubblici, né tanto meno rappresentanze nel decurionato. Probabilmente adombrarono velate simpatie verso i «novatori», ma si tennero prudentemente in disparte. Invece D. Vincenzo Ferrantelli e i suoi figli, cospicui per censo, erano schierati tra i legittimisti. Troveremo, infatti, D. Gioacchino di Vincenzo, durante i moti dell'aprile 1860, tra i custodi dell'ordine pubblico minacciato dalle turbolenze dei popolani124.
122 Quadro dei componenti il Consiglio civico di Castellammare (17 giugno 1848), in AST, FI, Commissariato del Potere Esecutivo del Valle di Trapani (1848-49), fase. unico.
123 [vi, Polizia. Affari diversi (1850-51); rapporto riservato del s. int. di Alcamo all'intendente di Trapani, 17 agosto 1850.
124 ASP, ML, Polizia, Affari diversi. Alcamo, b. 1505, filza 48; rapporto del giudice regio di Castellammare al direttore del dipartimento di polizia in Palermo, 20 aprile 1860. Altri documenti coevi ce lo segnalano a capo della guardia urbana, sollecito ad assicurare la «salvezza del paese», ma pure solidale col giubilo dei «buoni» per la calma che era sopravvenuta con la reazione militare: «Ed a queste espressioni vere e leali - informava una nota del sindaco - fu ammirevole sopra tutti il Capo urbano D. Gioachino Ferrantelli, che compreso della stessa gioia immantinenti volle colle sue proprie mani inalberare la bandiera regia nella casa comunale a sempreppiu ribadire l'ordine, la sicurezza e la tranquillità che in questa ammirevolmente sono stati mantenuti» (cfr. in AST, FI, Polizia, Corrispondenza (1859-60); nota del sindaco di Castellammare A. Cataldo all'intendente di Trapani, 14 aprile 1860). Egli stesso firmò un rapporto su quei fatti per manifestare il suo «zelo» e la sua «fedeltà al Real Governo», denunciando i piu turbolenti e pericolosi tra i partecipanti (v. documento conservato tra le carte Coppola della Società Siciliana per la Storia Patria e riportato da G. MISTRETTA DI PAOLA, I fratelli Sant'Anna, p. 163). Anche se non è indicato il patronimico di Gioacchino Ferrantelli, presumo che si tratti del figlio di D. Vincenzo, il cui nome era accompagnato dal don nei documenti ufficiali.
Può avere, inoltre, un significato non fortuito l'incarico di «commessionario» che Gioacchino Ferrantelli riesce ad ottenere negli anni '48-'49 dalla duchessa Laura Naselli. Gioacchino ha la sua fiducia per contrattare affitti e risoluzioni di patti, acquisti e vendite nell'interesse degli ex feudatari di Castellammare. (Per esempio, il 13 agosto 1848 scioglie il contratto di affittanza a suo tempo stipulato con D. Giuseppe Marcantonio Coniglio per la montagna Gagliardetta, concedendo la stessa a D. Procopio Carollo per l'annuo estaglio di 310 onze. Il 3 marzo del '49 dà in fitto a due borgesi «il taglio di tutto il legno atto a carbonizzarsi» che si trova nelle contrade del Monaco, di Bartolazzo, Macchia dello Schiavo e Vallone di Avellara125.) In tempi cosi insicuri per le velleità democratiche delle masse, la nobiltà preferisce affidare la tutela dei propri interessi a uomini d'indiscusso prestigio sociale e di provata energia, anche se, probabilmente, pagando per questo elevati prezzi materiali.
È ancora una ricerca seriale negli atti notarili che può rivelarci volume e tipologia degli affari condotti da Gioacchino Ferrantelli nel decennio precedente l'Unità, caratterizzati da attivismo di traffici intermediari nel settore della compravendita degli animali (muli e cavalli), cui si associano il fratello Antonino e il figlio Antonio, e in quello dei prestiti frumentari. I Ferrantelli sono comunque gli unici a comparire davanti ai notai per l'acquisto e, ancor piÙ, per la vendita degli animali. Si deve quindi pensare che, a Castellammare, essi non abbiano concorrenti. È pure significativo che questa loro attività, iniziata nell'autunno del '49 e terminata dieci anni dopo126, si svolga in un arco di tempo in cui sono prevalenti gl'interessi legati alla pratica abigeataria che, del resto, è resa possibile entro la rete di violenze e connivenze predisposta dallo stesso Gioacchino. Pare, invece, che sia marginale il reddito che i Ferrantelli ritraggono ora dal pascolo, che non conducono piti da soli. Gioacchino, infatti, è associato ad altri quattro pastori nell'affitto della montagna Gagliardetta, dove farà pascolare 154 capre. L'annuo estaglio che egli paga, insieme ai soci, a D. Gaetano D'Anna è di 60 ducati per ogni centinaio di capre, e 81 ne paga il figlio Antonio allo stesso D'Anna per l'affitto di Lisciandrini127. Sono terre classificate tra quelle rampanti, con poca e magra erba, ma adatte per la loro estensione alla pastorizia vagante. Sono pure terre molto richieste dai forestieri, ma ai Ferrantelli viene sempre praticato un fitto notevolmente basso128.
125 Atti in noto Gaetano Mangiarotti (ANT, 2313, fI. 484r-49I r; 2314, fI. 313r-318 v).
126 Quietanze e brevetti per la compravendita di animali si trovano in noto Andrea Di Blasi (dal 4 novembre 1849 allo novembre 1859), in noto Vito Parisi (dal 7 giugno 1851 al 23 settembre 1855) e in noto Vincenzo Galante (dal 16 ottobre 1859 al 3 febbraio 1860).
127 Brevetti nel repertorio del noto Andrea Di B1asi, I3 ottobre 1853 (AST, 1040, f. 548) e 14 ottobre 1855 (AST, 1041, ff. 636-637).
128 I contratti di fida di questi anni saranno esaminati piu avanti. Si può comunque affermare sin d'ora che di rado l'affitto era inferiore a ducati 87/90 per centinaio di capre.
Il traffico frumentario annovera Gioacchino tra i piti grossi mercanti del paese. Da una statistica del 1855, preparata dalle autorità per conoscere, comune per comune, il fabbisogno di grano della popolazione, si può ricavare la consistenza dei suoi magazzini: duecento salme, quante ne conserva l'omonimo cugino (ma altre duecento sono calcolate a nome del padre, D. Vincenzo), meno comunque dell'onnipresente sacerdote D. Ignazio Galante che incetta ogni anno circa 600 salme di frumento129. Gli atti notarili registrati a partire dal '51 ci fanno conoscere sia i quantitativi del grano venduto, il prezzo, le modalità e i tempi del pagamento, sia la natura dei contratti, che riguardano spesso anticipi praticati ai contadini per la seminal30. La funzione che, perciò, era esercitata dai Ferrantelli, come dagli altri mercanti (Galante, Verderame, Buccellato), rispondeva, oltre che alla necessità di sopperire al fabbisogno locale di farine, ad esigenze di prestamo, col ricavarne naturalmente un piu alto profitto per gli elevati interessi che i contadini dovevano pagare al momento della mietitura.
129 «Stato dei frumenti esistenti nella Provincia in rapporto ai bisogni della popolazione, sino al venturo raccolto 1856», in AST, FI, Affari diversi (1853-55), fase. Frumenti e civaje. Anche Antonino Ferrantelli di Antonio, che pratica con molto impegno l'usura, si dedica in questo periodo alla compravendita dei cereali, oltre che degli animali. Il 27 agosto 1849 vende a D. Francesco Saverio Borruso IO bovi, una giumenta di pelo morello e 100 salme di frumento per onze 424 e 20 tari (atto in noto Gaetano Mangiarotti: ANT, 2314, ff. 90 I r- 905v); e l'anno dopo vende altre 60 salme di frumento a Giovanni Asaro e Giuseppe Borruso (atto del 7 luglio 1850, ivi, 2315, ff. 595r- 597v).
130 I mutui per soccorso frumentario sono registrati nei repertori notarili a partire dal 12 ottobre 1851. Ad es., l'8 gennaio 1856 Gioacchino Ferrantelli presta a tre contadini 40 tumoli di grano pagabili a 15 luglio prossimo, dopo il raccolto (brevetto in noto Vito Parisi). Soccorsi frumentari sono pure praticati dal figlio Antonio negli stessi anni.
Fino a questo momento Gioacchino non ha molte terre al sole, ma ha mantenuto ed esteso la sua influenza sui ceti subalterni della campagna, che in lui riconoscono un provveditore di «soccorsi», un utile mediatore di affari e, infine, un efficace protettore. Ufficio, quest'ultimo, che è tanto piu accettato e richiesto dal pubblico quanto piu crescono l'arroganza e lo strapotere dei galantuomini. Se la sua vocazione è quella del massaro ricco, la sua attuale condizione non lo mette ancora in aperto contrasto con la classe contadina. È questa impronta borghese (sua e degli altri mercanti di campagna) a conferire un certo dinamismo a una comunità rurale che è ormai regolata dall'interesse del ceto proprietario a restringere alla propria classe le possibilità di movimento del mercato fondiario, fidando anche sulle leve del potere politico-amministrativo. Il nuovo ceto borgese può solo affermarsi sulla via di una tendenziale conquista della terra esercitando i ruoli di mediazione e le attività speculative (usura e soccorsi frumentari, traffico di animali, sòccide e subaffitti) che sono connaturati nei modi di percezione della rendita fondiaria e di sfruttamento del lavoro contadino, usando anche la violenza fisica e i modelli di comportamento della mafiosità come strumenti di resistenza e di pressione.
Nel '59, finalmente, i Ferrantelli (padre e figli) prendono in fitto l'ex feudo Celso, esteso 268 ettari, organizzandovi una masseria in cui lavoro e produzione sono distribuiti secondo i criteri ormai in uso nell'azienda latifondistica: compascolo di capre e contratti di colonia per i terraggieri, oltre che impiego di salariati nei fondi condotti direttamente dagli affittuari131. I Ferrantelli risiedono ora per gran parte dell'anno nel baglio di Celso, centro polifunzionale delle attività che si svolgono nella masseria. Da qui potranno meglio controllare, non solo i loro interessi, ma anche quella rete di complicità e mediazioni che si va costituendo nell'agro castellammarese attorno ai poteri informali della mafia. I documenti d'archivio ci confermano la presenza dei Ferrantelli in molti fatti giudiziari, con ruoli di copertura, oppure di connivepza con abigeatari, manutengoli e briganti. Ne usciranno sempre bene, ma l'impressione che la loro ingerenza in certi affari «sommersi» sia attiva e reale è abbastanza netta.
131 L'ex feudo Celso era appartenuto fino allO marzo 1859 (atto in noto Francesco Anelli di Palermo) a D. Salvatore Morroy Barlotta. Era costituito da 174,165 ettari di seminerio e 93,781 ettari di terreno rampante (v. in AST, Catasto provvisorio, cit., voI. 8, art. 2490). I contratti a colonia parziaria si trovano in noto Andrea Di Blasi, 25 dicembre 1859 e lo aprile 1860. Nel '75, Antonio e Leonardo Ferrantelli di Gioacchino avrebbero preso in fitto anche l'ex feudo di Abbatello in territorio di Calatafimi (ivi, 22 giugno 1875).
Dopo la breve euforia garibaldina e la pro dittatura, essi si preoccupano, da un lato, di consolidare la loro posizione economica e, dall'altro, di praticare il patrocinio nei confronti di civili e popolani, campi eri e borgesi coinvolti in episodi di violenza privata o collettiva. Nelle cronache giudiziarie di quel tempo - che fu tempo di sommosse antiborghesi, brigantaggio e repressioni piu o meno legalizzate dall'intervento dello Stato - il loro nome ricorrerà spesso (come si vedrà in seguito) tra i testimoni compiacenti e i «guardaspalle». Il consenso del pubblico non doveva perciò mancare a Gioacchino Ferrantelli di Antonio quando pensò giunto il momento di farsi eleggere al Consiglio comunale onde riaffermare, appunto, la sua influenza sull'ambiente. Vi entrò il 12 luglio 1866, portato ai primi posti della graduatoria elettorale dal voto di 120 Castellammaresi, piu di quanti votarono i nomi dei notabili piu in vista del paese132. E forse la stessa legittimazione politica avrebbe consentito, a lui e al figlio Antonio, di potere accedere al nuovo mercato fondiario aperto in quegli anni dalla vendita forzosa delle terre ex ecclesiastiche. Tra il '69 e l'89, il movimento di «carico» dei fondi registrati a loro nome nel catasto di Castellammare fa aumentare la consistenza patrimoniale fino a 26,934 ettari di seminerio e vigneto; ma 14,939 ettari di tale patrimonio essi hanno acquistato dal demanio dello Stato133.
132 Stato degl'Individui componenti l'Amministrazione Comunale di Castellammare pell'anno 1866, in Asce, Carte diverse, fase. unico. Soltanto il sacerdote Antonino Zangara ebbe piu voti (126). Giuseppe Borruso, figlio di Francesco Saveno, ucciso dalla folla nella rivolta del '62, riportò lo stesso numero di voti di Gioacchino Ferrantelli di Antonio; meno il dr. Simone Riggio e il sacerdote Ignazio Galante (58). AI cugino omonimo, figlio di D. Vincenzo, andarono solo cinque voti.
133 AST, Catasto provvisorio, cit., vol. 5, artt. 1438-1439.
Dunque, una vicenda sociale, e perciò umana, che fu comune a molti individui che acquisirono con affanno e contrasti la dignità della roba. Non ostante tutto, Gioacchino non potè essere pienamente cooptato nel ceto civile; né lo furono i figli (il solo Giuseppe riusci ad entrarvi per avere ottenuto un impiego municipale). Cresciuti in molti, maschi e femmine abitarono tutti assieme, prima nella «casa sotto canale» di via Màcina, poi nel palazzetto sito nella «strada mastra», segno di raggiunto decoro borghese. Contrassero matrimoni con eredi piu o meno mediocri del borgesato locale; ma Antonina sposò, nel '52, un massarioto, il figlio di Domenico Gennacil34, che le autorità di polizia del regno sabaudo avrebbero indicato come influente «adepto alla mafia» al tempo della guerriglia rurale organizzata a sostegno degl'insorti di Palermo del settembre 1866135. Non era certo la qualificazione civile ottenuta dai figli di D. Vincenzo Ferrantelli, ma era pur sempre un aggancio importante col mondo dei massari ricchi.
134 Atto dotale dell'Il settembre 1852 in noto Andrea Di Blasi (AST, 1007, ff. 337r-349v).
135 AST, Corte d'Assise, Processi penali, b. 2, fase. 42. Sui Ferrantelli, nello stesso fondo, b. l, fase. 13; b. 2, fase. 36.
Ce n'era voluto di carattere volitivo e pertinace per sfuggire al destino, antico e comune, dei Ferrantelli di spingere le capre alla Gagliardetta. Gioacchino si era piegato qualche volta agli eventi contrari (il figlio Leonardo sarebbe stato ucciso, nel '76, ai Fraginesi 136); oppure li aveva raddrizzati con l'autorità del suo nome e il rispetto che aveva saputo conquistare nel pubblico. Di altri mezzi usati non possiamo dire, perché la Giustizia non si occupò mai di lui se non come testimone nei processi criminali o come «adepto alla mafia», lasciandolo immune da macchie di provata reità.
Già, quindi, nei caratteri che via via andrà assumendo la borghesua terriera locale, attraverso l'acquisizione di elementi mafiosi ad essa legati da organici interessi di classe, è da individuare una delle cause del sostanziale immobilismo che si attua nelle campagne a danno dei contadini piu poveri. Il conservatorismo sociale, su cui Renato Composto ha scritto significative pagine137, d'ora in poi poggerà sulla mafia onde infrenare l'endemico ribellismo delle masse. Non dovrà pertanto meravigliare che, per es., Calandra accordi benemerenze liberali ai Ferrantelli, pur essendo abbastanza noti i loro equivoci trascorsi138.
136 Nota trasmessa dal pretore di Castellammare, in AST, Registro degli atti di morte, 20 aprile 1876, voI. 55, N. 5, parte II. Leonardo Ferrantelli aveva sposato Maddalena Pilara, già vedova di Santi Asaro (atto dotai e del 4 luglio 1870 in not. Vito Mattarella) e nipote della moglie di Pasquale Calvi. Rimasta nuovamente vedova, Maddalena Pilara sposerà l'anno dopo il cognato Giuseppe Ferrantelli.
137 R. COMPOSTO, Conservatorismo e fermenti sociali nella Sicilia preunitaria, Palermo 1964.
138 G. CALANDRA, l casi, p. 15.
Non può dirsi, peraltro, che l'attitudine a compenetrarsi con lo «spirito di mafia» fosse limitata a quanti svolgevano una semplice funzione di copertura degl'interessi agrari. Da qualcuno, è vero, si distinguevano «la gerarchia tecnica e i fatti sanguinosi e ributtanti che formavano l'essenza dell'associazione nelle carceri e nel volgo» dalla «sfumatura di mafia» che permeava certi atteggiamenti delle classi superiori139; ma ad ogni modo si deve pure ammettere che, piu spesso, un comune sistema di rapporti sociali, fondato sulla violenza del singolo e sulla acquiescenza degli organi statali nei suoi confronti, vincolava a una medesima carriera gl'individui che volevano trarre dall'esercizio di certe funzioni di dominio il massimo profitto materiale. Nei livelli piu alti della dignità sociale restava, appunto, una «sfumatura di mafia» a conferire il rispetto dovuto a chi aveva saputo elevarsi fino alla condizione del galantuomo.
139 «La mafia regnava sovrana in tutte le classi sociali « ... » Non parlo della società tenebrosa che prese pi1i generalmente il nome di camorra. La mafia ebbe, credo, origine politica, come la frammassoneria, come la carboneria. A parte la gerarchia tecnica e i fatti sanguinosi e ributtanti, che formano, o formavano, l'essenza dell'associazione nelle carceri e nel volgo, essere ardito, segreto, avverso al governo borbonico, puntiglioso fino alla morte nei bisticci individuali, insofferente di prepotenza, pronto a sostenere in tutti i modi le proprie ragioni, significava, allora, esser mafioso. Nella generalità dei ceti una sfumatura di mafia, intesa come dissi, non guastava» (cfr. G. FAZIO, Memorie giovanili della rivoluzione siciliana e della guerra del 1860, Spezia 1901, pp. 12-13).
Alcuni testimoni e minori agonisti del Risorgimento locale hanno riconosciuto che la mafia prestò il suo appoggio alle azioni dei patrioti e, in genere, al moto di opposizione antiborbonica. Se ne giustificava il consenso, o la concreta solidarietà, con la fierezza e l'indipendenza di giudizio che caratterizzavano i singoli mafiosi: «Questi uomini d'alta maffia - scriveva, per esempio, nelle sue Memorie Laureato Alestra - con noi liberali quando li adibiamo erano fedeli e disimpegnavano l'incarico ricevuto», ricordando due uomini «di tutta brusca e di altissima maffia»: don Pipitone, abitante in Trapani, e il castellammare se D. Filippo Sottile140. Giacomo Fazio pensava addirittura ad una opposizione di principio dei mafiosi contro il regime borbonico: «La mafia d'allora va considerata come un eccesso dell'odio profondo contro i Borboni, allargato e sostenuto dal carattere fiero e puntiglioso dei Siciliani»141. Sta di fatto che il quadro mafioso del tempo partecipò in modo piu o meno diretto agli eventi rivoluzionari. Per Castellammare, risulta dagli elenchi degli arrestati «per misure di polizia» dal maggio 1849 al dicembre 1850 (eccetto quelli «per affari politici») che, su 48 nomi forniti dalle autorità locali, almeno sette presero parte attiva al moto dell'aprile/maggio 1860. Sono Vincenzo e Giuseppe Coco (il primo fu a capo di una squadra di picciotti), i possidenti D. Andrea Asaro di Giovanni e D. Antonio Plaja fu Diego, Pietro Galante di Giacomo e i «fabricieri» Buffa. Lo stesso Fazio ricorda tra gli esponenti delliberalismo militante in Alcamo un tale Guarrasi, assai noto negli ambienti di mafia, dove si reclutarono gran parte dei picciotti di Sant'Anna. («I mafiosi erano capitanati da Francesco Guarrasi, giovine d'assai buona famiglia, prode della persona, risoluto ed animoso. Era ritenuto il piu valente schermitore ad arma corta»142.) La famiglia Guarrasi era, del resto, definita dal sottintendente di Alcamo «prepotente» e armigeral43.
140 L. ALESTRA, Memorie, ms. presso gli eredi in Erice. Su questo patriota, v. F. DE STEFANO, L. A., in «Il Popolo di Trapani», 14 aprile 1934.
141 G. FAZIO, Memorie giovanili, p. 15.L'alcamese Giacomo Fazio (1841-1924) partecipò alla campagna garibaldina del '60 e fu in seguito colonnelIo dell'esercito regolare.
142 Ivi, p. 31.
143 AST, FI, Polizia, Affari generali (1849-51), fase. Spirito pubblico; rapporto del s. int. di Alcamo del 27 novembre 1849 all'intendente di Trapani.
Sottratto, però, all'aureola patriottica e pseudocavalleresca, destinata a durare nelle enunciazioni di un certo sicilianismo di maniera, il fenomeno mafioso dovrebbe essere ricondotto alla sua fondamentale e inequivocabile essenza criminogena, spinta in funzione di un'anomala mobilità dei gruppi subalterni e di quelli intermedi del mondo rurale. Chi per primo ne rivelò con esatta e acuta diagnosi le originarie valenze sociali fu, come è noto, il procuratore generale del re Pietro Calà Ulloa, mandato nel 1838 dal ministro Parisio a Trapanil44. Di Ulloa si conoscevano già i rapporti inviati al ministro di grazia e giustizia in Napoli e pubblicati da Ernesto Pontieri145. Nella lucida testimonianza del magistrato napoletano, la costituzione dei partiti della mafia nella Sicilia occidentale era motivata come effetto di una carenza strutturale dello Stato, che non aveva saputo, o potuto, fondare la propria legalità formale nel contesto della società postfeudale onde integrare quel vuoto di potere che era stato lasciato dal baronaggio. «Questa generale corruzione - scriveva infatti Ulloa, riferendosi al livello preoccupante della degradazione morale e sociale dell'ambiente - ha fatto ricorrere il popolo a metodi oltremodo strani e pericolosi. Vi ha in molti paesi delle unioni o fratellanze, specie di sette, che dicono partiti, senza colore o scopo politico, senza riunione, senza altro legame che quello della dipendenza da un capo, che qui è un possidente, là un arciprete. Una cassa comune sovviene ai bisogni ora di far esonerare un funzionario, ora di difenderlo, ora di proteggere un imputato, ora d'incolpare un innocente. Sono tante specie di piccoli Governi nel Governo. La mancanza della forza pubblica ha fatto moltiplicare il numero dei reati! Il popolo è venuto a tacita convenzione coi rei. Cosi come accadono i furti escono i mediatori ad offrire transazione pel ricuperamento degli oggetti involati. Il numero di tali accordi è infinito. Molti possidenti perciò han creduto meglio divenire oppressori che oppressi, e s'inscrivon nei partiti. Molti alti funzionari li coprivan di un'egida impenetrabile»146.
144 Su Pietro Calà Ulloa (Napoli, 1801-1879), v. il profilo redatto da A. SCIROCCO per il Dizionario Biografico degli Itàliani, 16, Roma 1973, pp. 469-72. Ulloa fu nominato, il 31 dicembre 1837, giudice criminale con le funzioni di procuratore generale presso la Gran Corte Criminale di Trapani. Il 30 gennaio 1840 era promosso giudice di Gran Corte Civile in missione di procuratore generale presso la stessa Gran Corte Civile di Trapani; e in seguito trasferito (I2 dicembre 1844) alla Gran Corte Civile di Messina, sempre con le funzioni di procuratore generale (ivi, p. 470). Sul magistrato napoletano, v. anche v. TITONE, P. C. U. e la rivoluzione del 1848, in «Rassegna storica del Risorgimento», Roma, a. XL (I953), fase. III (luglio-settembre), pp. 411-18, a proposito dello scritto Coup d'oei/ sur la situation de la Sici/e en 1847 et sur la marche de sa révolution (Genève 1850).
145 E. PONTIERI, Ferdinando II di Borbone e la Sicilia: momenti di politica riformatrice. in Il riformismo borbonico nella Sicilia del Sette e dell'Ottocento. Saggi storici, Napoli 1961. La prima relazione Sulle condizioni della magistratura in Sicilia (pp. 228-31) fu spedita il 25 aprile 1838; la seconda, intitolata Considerazioni sullo stato economico e politico della Sicilia (pp. 232-42), reca la data del 3 agosto s.a.
146 [vi, p. 235.
La fraternità mafiosa, che costituiva il nucleo forte del partito (ma un poeta arcadico di sicuri agganci popolari, Giovanni Meli, usava già l'espressione amiciuni di fu sò partitu, forse per antica risonanza di costumi protomafiosil47), fondava probabilmente anche allora la sua capacità di aggregazione e di consenso su onore e credito o rispetto: l'uno inteso come ossequio a feudali norme di comportamento; l'altro come legittimazione da parte del pubblico del ruolo intermediario spettante a chi, a sua volta, aveva rispettato quelle norme. Il sentimento dell'autogiustizia presupponeva, in tutti i casi, una mafiosità latente negli «oppressori» e negli «oppressi»; e cioè una mentalità variamente ad essa atteggiata148.
147 G. MELI, Favuli morali, in Opere poetiche, ed. E. Alfano, Palermo 1915, p. 10.
148 Paolo Pezzi no ha interpretato estensivamente il fenomeno delle «fratellanze» cui accennava Ulloa, individuandone le valenze politiche nel contesto della «crescita della società civile siciliana» e, cioè, come «uno strumento complementare, ma dopo il 1837 con peso crescente, dell'ascesa di quei ceti medio-bassi che si erano affacciati alle soglie dell'area del potere negli anni '30, e di quei civili che, già da tempo cooptati a livello dirigenziale periferico, andavano dimostrando una forza crescente e per i ceti dominanti preoccupante, nella misura in cui avessero sviluppato la capacità d'innalzarsi a forme di rappresentanza autonome» (cfr. Stato violenza società. Nascita e sviluppo del paradigma mafioso, in La Sicilia, a cura di M. Aymard e G. Giarrizzo, p. 911).
Se è abbastanza nota l'inchiesta di Ulloa sulle iniziali articolazioni della extralegalità mafiosa, non si conoscono, invece, i quattro discorsi da lui tenuti alla procura generale di Trapani per l'inaugurazione degli anni giudiziari 1839-42, dove si contengono, pur nel riserbo imposto dal rito ufficiale dei rendiconti, alcune pregnanti osservazioni sulla condotta degli abitanti di questa parte dell'isola di fronte ad una cosi fitta rete di arbitri e protezioni149.
Egli confessa, intanto, di essere venuto a Trapani «non vinto da scoramento» per la «frequenza de' tristi e de' malifizi»150. L'alta densità dei fatti criminosi che ha' riscontrato nella sua circoscrizione giudiziaria - un condannato ogni 615 abitanti, rispetto alla media siciliana (uno ogni 1593 abitanti)151 - rivela l'esistenza di uno stato patologico dell'ordine pubblico, al limite dell'emergenza sociale. Ciò che tuttavia lo preoccupa maggiormente è il rifiuto degli offesi a ricorrere alla Giustizia e a partecipare alle sue inchieste, quando, addirittura, non ne impediscono la formale costituzione.
149 P. CALÀ ULLOA, Degli ujJìzj del magistrato e dell'amministrazione della giustizia penale nella provincia di Trapani. Discorso letto nell'udienza de' 2 gennajo 1839, Trapani 1839, 29 pp.; Dell'uso di talune dottrine ne' giudizj penali e dell'amministrazione della giustizia nella provincia di Trapani. Discorso letto nell'udienza de' 2 gennajo 1840, Trapani 1840, 34 pp.; Della necessità delle conoscenze economiche negli studi legislativi, e della utilità delle statistiche ne' giudizi penali. Discorso letto nell'udienza de' 2 gennajo 1841, Trapani 1841,37 pp.; De' giudizj ne' progressi della scienza penale e ne' miglioramenti delle opinioni e della amministrazione della giustizia nella provincia di Trapani. Discorso letto nell'udienza de' 3 gennajo 1842, Trapani 1842,34 pp. Si conservano nella Biblioteca Fardelliana di Trapani (miscellanea C. 68-69, 71-72).
150 P. CALÀ ULLOA, Della necessità delle conoscenze economiche, p. 3.
151 P. CALÀ ULLOA, Degli uffizi del magistrato, pp. 15-16. Le cause per misfatti, che erano state 990 nel 1835, erano diminuite di poco negli anni successivi (895 e 824), ma erano ancora aumentate di molto nel 1838 (1346). In venti anni, dal 1819, 85 individui erano stati condannati a morte (ivi). Abbastanza esemplificativa del grado di pericolosità raggiunto dal «costume» a delinquere è la statistica che lo stesso Ulloa fornisce in un altro suo discorso (cfr. De' giudizj ne' progressi della scienza penale, p. 22):
Il pur elevato numero di delitti su cui può esercitarsi il giudizio della magistratura rappresenta, quindi, solo una parte della vasta fenomenologia criminale che interessa la provincia. Ancor piu la parte «alta e montagnosa» di essa, dove gli abitanti «per arra de' futuri mali si piegano facilmente a perdonar le offese» 152. Preoccupante è, allora, il fenomeno delle reticenze, dal quale si evince «quanto scarso è il numero di coloro che adempiono volenti ero si al santo uffizio di giovare alla giustizia». «Grave dunque n'è il numero - ribadisce Ulloa -, epperò ascriver si vuole alla natura de' luoghi, la piu parte incolti, lungi dalle città abitate, e ne' quali non veggonsi disseminate né case né capanne. Ma pure aggiunger si deve che allo scopri mento de' rei grandemente si oppongono i costumi, che fan ravvisare, cessato il primo sdegno, in ogni reo uno sventurato. Ed a ben chiarire questa saldissima verità che le leggi debbono essere ajutate dai costumi de' popoli, valga il considerar dappresso come, o la ripugnanza a manifestare i rei li lascia impuniti, o le false testimonianze intristiscono i giudizi»153. Perfino i «possidenti», «che piu presso al popolo vivono, anch'essi s'indugiano; non che impietosissero, si bene perché, avvenuto appena loro un furto, si travagli ano a scoprir il reo per venir con lui ad un turpe componimentO»154.

152 Ivi, p. 24. Castellammare, con una popolazione molto inferiore a quella di Trapani o Alcamo, registrava un numero assai maggiore di «rinunzie» e accomodamenti (v. Della necessità delle conoscenze economiche, p. 29).
153 Ivi, pp. 23-25. L'autore notava anche che la reticenza non era diffusa solo «ne' rustici» e che nel triennio 1838/1840, su 34 214 testimoni, ben 1277 erano stati assoggettati «allo esperimento del carcere».
154 P. CALÀ ULLOA, De' giudizj ne' progressi della scienza penale, pp. 19-20. Il ricorso pili frequ,ente alla pratica delle componende fece progressivamente diminuire le denunzie di abigei. Anche Ulloa poneva tra le cause che avevano favorito l'abigeato, oltre alla mancanza di strade consolari, la nessuna garanzia «che a tali reati doveano gli agenti della forza pubblica». Nel periodo tra il 1830 e il 1838 la media annuale degli abigei nella provincia di Trapani era stata di 218, ma da! 1839 in poi essa si era sensibilmente ridotta (v. Dell'uso di talune dottrine ne' giudizj penali, pp. 24-25). Frattanto si era avuto col RD 14 ottobre 1837 lo scioglimento delle compagnie d'armi e la loro riorganizzazione nella Gendarmeria reale.
Le cifre fornite dallo stesso Dlloa sul numero (davvero ingente) dei testimoni reticenti e dei delitti rimasti impuniti corredano l'osservazione di fondo: che la Giustizia è impraticabile là dove manca la volontà di assecondarla, o si ritiene piu conveniente farsene una privata e disposta ad equivoche transazioni. Ciò che nasce, anzitutto, dalla preoccupazione di ricuperare in ogni modo il danno materiale, mentre, magari, si dimenticano spesso le offese di sangue: «E poiché le ire cessano e si perdona piu facilmente a siffatti reati, che non ai furti, alle frodi, ai guasti che ingenerano danno permanente, cosi diremo che la piu parte delle percosse e delle ferite rimangono impunite»155. Li uomini sdimenticano piu presto la morte del padre che la perdita del patrimonio, sentenziava Machiavelli; ma nella concezione totalitaria ed esclusiva della roba che dominava i rapporti etico-sociali nel mondo rurale siciliano la perdita di un bene materiale, anche piccolo, assumeva quasi un valore esistenziale.
155 P. CAIÀ ULLOA, Della necessità delle conoscenze economiche, p. 29.
L'opinione del magistrato napoletano è che a favorire la criminalità siano, in egual misura, la miseria e l'i'gnoranza. Secondo il «linguaggio severo e invincibile» delle statistiche giudiziarie, «la classe piu inchinevole ai misfatti» è quella dei contadini. («La condizione economica di queste terre ed una rilasciatezza in fatto di giustizia può solo far pullulare fra loro molti colpevoli e generare opere di scellerate libidini»156.) Ma risulta altre si che le recenti crisi annonarie e le epidemie coleriche abbiano contribuito ad esasperare l'indigenza, fino a procurare in forme criminali l'esplodere dei conflitti tra poveri e «possidenti». «Siccome è chiaro dalle mercuriali - egli osserva -, il prezzo del grano sali strabocchevolmente in quegli anni, appunto, in cui si ebbe maggior numero di furti, come nel 1832, 1833 e 1838.
156 P. CAIÀ ULLOA, Degli uffizj del magistrato, pp. 17-18. Tra i fatti piu eclatanti, il magistrato ricordava una scorribanda di alcuni «filibustieri» di Castellammare, i quali «gittatisi su piccolo naviglio, affidavano alle onde il trionfo della nequizia e correvano ad afferrar le sponde che avean meditato d'insanguinare» (ivi). Ulloa aveva accennato allo stesso episodio nella relazione inviata al ministro Parisio il 3 agosto 1838 («scesero, ad esempio, vcnti malgavi a Castellammare, s'impadronirono di una barca e fecero vela per andare a sorprendere un paese a dieci miglia discosto»; cfr. in E. PONTIERI, Il rijormismo borbonico, p. 235).
Il che aggiunto all'osservazione che i furti consistono per lo piu in comestibili, e si avrà aperta la causa de' misfatti di tal natura. Né manco avrà sfuggito la vostra osservazione che i furti crescessero a dismisura negli anni 1832, 1833 e 1838, che successero immediatamente ad anni per epidemie tristissimi. Il che chiaramente dà a di videre che non è già ne' tempi calamitosi che si accrescono i misfatti, si ben in quelli che loro immediatamente succedono»157.
Cause, dunque, contingenti, che, però, si sono sommate a quelle piu lontane prodotte dal secolare abbandono della Sicilia, dai «disordini economici» e, infine, dalla carenza di giustizia pubblica durante il viceregno spagnolo. Non certo dovute a inferiorità etnica o atavismo disperato. Contro questi pregiudizi, anzi, Ulloa leva alta la sua voce, animato da un forte senso della storia e convinto, illuministicamente, della tendenza di ogni popolo all'incivilimento. Da questa fiducia nel progresso della civiltà discende la sua ragionata perorazione a favore di una riforma del sistema carcerario tesa a «migliorare anziché corrompere» i condannati, costretti a vivere in luoghi dove può solo rafforzarsi ed estendersi l'organizzazione malavitosa. Poiché la «vera sorgente de' misfatti spesso non è una scelleranza riflessiva, bensi la deficienza de' principi», ne consegue che «crudele ed ingiusto è il castigo onde la società condanna i delitti che essa stessa ha preparati»158.
157 P. CALÀ ULLOA, De' giudizj ne' progressi della scienza penale, p. 23.
158 P. CALÀ ULLOA, Degli uffizj del magistrato, pp. 24-26.
Gli anni in cui Ulloa amministrò giustizia nell'isola (prima a Trapani, poi a Messina) furono certamente tra i piu difficili per l'ordine pubblico, che risentiva ancora di un lungo periodo di transizione dall'autorità baronale, di cui tuttavia rimanevano ben salde mentalità e costumanze, a una piu diretta responsabilità dello Stato negli affari di giustizia. La relativa evoluzione delle condizioni della sicurezza nelle campagne, che ebbe a riscontrarsi successivamente al periodo rivoluzionario '48-'49 attraverso un sensibile calo dei giudizi penali per reati contro la proprietà159, non pare che possa essere spiegata con una migliore organizzazione della forza pubblica di repressione, ma, piuttosto, con una piti estesa e strutturata presenza nella società rurale dei poteri informali della extralegalità mafiosa, le cui possibilità di mediazione si erano anzi accresciute col ripristinato servizio delle compagnie d'armi160. Perciò erano via via quasi scomparsi dalle statistiche giudiziarie gli abigeati, mentre era cresciuta la schiera di quanti venivano processati per asportazione e detenzione di armi. Fenomeno, questo, già notato col solito acume da Ulloa, che sottolineava anche l'inefficienza delle estreme misure repressi ve di fronte a un bisogno quasi fisiologico della nuova criminalità: «Il porto d'armi è si frequente che in un decennio quasi, dal 1833 al 1841, vi ebbe 334 imputati, 132 condannati. E ciò che è degno di considerazione è che nella prima epoca, dal 1833 alla metà del 1837, in cui la pena fu temporanea, si contarono altrettanti colpevoli che nella seconda, nella quale per piti tempo la pena fu dell'estremo supplizio. Gli anni in cui vi ebbe maggior numero di rei furono il 1837 e il 1838, tempi di disordini civili»161.
159 R. PAXIUTA, Discorso inaugurale pronunziato dal Procuratore generale del Re presso la Gran Corte Criminale di Trapani, Palermo 1853; idem, 1854; idem, 1857. Notizie e statistiche nei periodici rendiconti degli Intendenti al Consiglio provinciale (v. «Giornale della Intendenza di Trapani», 1849-59).
160 Le compagnie d'armi furono istituite con RD del 16 dicembre 1813 (vedine il testo in E. D'ALESSANDRO, Brigantaggio e mafia in Sicilia, Messina-Firenze 1959, pp. 30-32) e, piu volte, abolite o riformate. Subito dopo il ripristino del regime borbonico, nel maggio/ giugno 1849, il principe di Satriano ne approvava i nuovi regolamenti, specie per quanto riguardava la indennizzazione dei furti (v. nota 42 infra).
161 P. CAIÀ ULLOA, De' giudizj ne' progressi della scienza penale, p. 27.
Restano a tutt'oggi (per carenza di sistematiche ricerche) gl'interrogativi piti importanti sul ruolo che gli stessi poteri informali ebbero nel sostenere la conflittualità latente tra lo Stato riformatore e centralizzatore, da una parte, e dall'altra le classi protoborghesi e semifeudali che rivendicavano la persistenza delle proprie legittimazioni sociali e politiche; ma non v'è dubbio che la mafia, comunque denominata e classificata, avesse già assunto in questo periodo concrete strutturazioni. Un documento da me rinvenuto tra le carte della polizia borbonica, che giudico rivelatore, ci trasmette un biglietto spedito da una non meglio precisata società a un capomafialcamorrista temporaneamente rinchiuso nel carcere di Favignana. Il biglietto, che il latore (un soprastante di Salaparuta) si rifiutò di decifrare esattamente, rivela l'esistenza di un certo aggregato mafioso, saldato al rito della fraternità e del rispetto162. L'esistenza di simili «società di rispetto» ci induce a pensare che già allora si sia formato nella Sicilia occidentale un certo legame tra elementi del ceto rurale medio-basso che cercavano di co'stituirsi di fronte al pubblico coi ruoli di autorità derivanti sia dalla violenza fisica sia dal formale ossequio alla morale tradizionale, e quindi alle regole di una convivenza di tipo feudale che il dispotismo illuminato del governo borbonico intendeva, invece, delegittimare. Se l'azione del riformismo napoletano riusci comunque a «liberare» dal contesto del feudo gl'individui piti spregiudicati, o meglio garantiti dalle posizioni amministrative acquisite (il ceto dei civili e quello dei gabelloti e mercanti di campagna), di riflesso convinse i nuovi ceti intermedi ad organizzarsi per il controllo sociale della massa contadina onde arginarne le ricorrenti spinte eversive. D'altro canto, le strutture periferiche dello Stato non furono mai in grado di tutelare i diritti individuali e collettivi dei ceti inferiori, né, tanto meno, di promuoverne gl'interessi a livello di auto sufficienza economica, com'era nei voti della politica riformatrice dei Borboni.
162 AST, FI, Polizia, Affari diversi (1850-51), fasc. Sorpresa di una lettera. Il testo della missiva è il seguente: «Caro Amico Con il Sig. Francesco Lombardo vi rimetto tt. 2,12 che vi spettano da codesta, e non piu per ultimo vi rispetto, e sono il vostro sempre amico Girolamo d'Angelo. Prigione di Trapani li 19 Febjo 1850». In basso un'aggiunta di altra mano: «Vi rispettano tutta la società vi posso dire che le notizie sono certi ... ». La lettera è indirizzata Alle propie mani delle Sigr Vincenzo Panfaluni nelle peni di Favignana. Il giudice che fece eseguire la perquisizione nella cella di Panfalone per rinvenirvi la lettera era convinto che si trattasse di una corrispondenza fra «antichi» camorristi (ivi, lettera del 22 febbraio 1850 all'intendente di Trapani). Vincenzo Panfalone, originario di Calatafimi, aveva preso parte alle vicende del '48 tra gli armati della Guardia nazionale.
È proprio durante la vicenda che fu chiamata del Risorgimento che i poteri informali della mafiosità, collaborando con le istituzioni locali allo scopo di frenare la violenza anarchica, cioè non sottoposta ai codici di comportamento mafioso, dei popolani piti diseredati, si assumono le funzioni di forza ausiliaria per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Gli appelli delle autorità borboniche rivolti ai proprietari terrieri perché provvedano da sé stessi alla difesa dei loro interessi finiscono cosi col far accettare, e riconoscere pubblicamente, il ruolo insostituibile delle «squadre» private. Da Palermo, nei giorni della vigilia rivoluzionaria del '60, si raccomanda agl'intendenti provinciali di far capire ai proprietari «che la guerra si fa dagli insorti piti alle loro sostanze che alle autorità»163. Procurino, perciò, i possidenti di reclutare una forza di presidio alle loro proprietà, senza attendersi l'aiuto del Governo. L'appello, del resto, viene accolto un po' ovunque: «I proprietari tutti sono nella massima agitazione, accompagnati da uomini di loro fiducia», scrive per es. da Canalotti il capitan d'armi del distretto ericinol64. Le campagne restano insicure anche dopo il temporaneo ripristino dell'ordine seguito alla repressione del moto palermitano del 4 aprile '60. Il giudice regio di Salemi riferisce che «i proprietarii e possessori di terre in questo territorio, sapendo che taluni delle bande armate che pria voleano aggredire le Reali Truppe percorrono le campagne portando il devastamento e rubando quanto è rubabile, si sono riuniti per formare una squadra di eccellenti uomini che guardassero le campagne del territorio di Salemi e le altre campagne che, benché non appartenenti al territorio suddetto, pure si posseggono da naturali di Salemi»165. Accanto alle «squadre» pri vate al servizio dei proprietari terrieri si organizzano nell' Alto Trapanese le bande di picciotti reclutate per la guerriglia antiborbonica da due esponenti della piccola nobiltà locale, il càvaliere Coppola e il barone Sant'Anna. Si ha quindi nello stesso luogo una duplice struttura armata, la cui presenza rende ancor piu fragile e fittizio il potere formale dello Stato, aggravando il vuoto politico, oltre che militare, in cui precipita il regime assolutistico.
163 Circolare N. 554 deLluogotenente generale principe di Castelcicala agl'intendenti dell'isola (Palermo, II aprile 1860), in AST, FI, Polizia, Corrispondenza (1860), fase. Spirito pubblico.
164 Ivi, «officiale» del 9 aprile 1860. L'invito ai proprietari ad organizzarsi autonomamente per la difesa dei loro beni segue di poco il manifestarsi della guerriglia nelle campagne: «È tempo che ogni cittadino deve prestarsi e personalmente e con i suoi mezzi per la conservazione dell'ordine. Ella quindi potrà rivolgersi a' ricchi proprietari di cotesta Comune - scrive l'intendente al sindaco di Monte S. Giuliano - per la spesa necessaria da lei rimostrata per l'assoldamento delle persone da aggiungersi alla Guardia Urbana, salvo in tempi normali a risolversi se la Comune possa concorrere a questa spesa» (ivi, minuta di lettera del 7 aprile 1860). Per la difesa dell'ordine, in tutti i Comuni rurali si erano mobilitati «gentiluomini, proprietari e persone influenti», coadiuvando la guardia urbana.
165 Ivi, rapporto del 19 aprile 1860. Il giorno stesso dello sbarco garibaldino, l'intendente rifiutava ancora una volta il presidio di una forza regolare, facendo appello ai proprietari terrieri perché si coadiuvassero da soli «per la garentigia de' propri fondi e per lo mantenimento dell'ordine pubblico e della tranquillità» (ivi, minuta di lettera al giudice regio di Salemi, 11 maggio 1860).
Si deve far risalire a questa latitanza dei poteri dello Stato nei momenti piu alti dello scontro sociale tra «oppressi» e «oppressori» (per usare le parole di Ulloa) la causa principale del crollo di autorità del regime borbonico, nel riconoscimento della cui delegittimazione di fronte alle masse il ruolo delle mafie (cioè delle coalizioni della violenza organizzata a difesa degl'interessi della borghesia agraria) non fu certo indifferente. Garibaldi trovò sulla sua strada la solidarietà dei contadini siciliani, i quali speravano nell'abolizione della tassa sul macinato e nella divisione delle terre demaniali, reintegrando cosi i diritti usurpati dai civili; ma poté sfruttare egualmente il concorso di congiunture politiche assai favorevoli, prima fra tutte l'impossibilità da parte dello Stato delle due Sicilie di esercitare «il monopolio della legittima coercizione fisica» e, di conseguenza, la trasmissione di tale apparato coercitivo ai poteri informali degli uomini di rispetto166.
166 L'impressione piuttosto negativa che gl'intellettuali garibaldini al seguito della spedizione ricavarono dall'ambigua presenza delle «squadre» («solo qualche banda di semibriganti, che qui chiamano squadre, avevano battuto e ancora battevano qualche provincia dell'interno con molta indifferenza del governo e qualche paura dei proprietari», scriveva per es. Ippolito Nievo a Bice Golzio Melzi il 28 maggio 1860) è stata contestata con vivaci messe a punto dalla storiografia locale, che ha amplificato e deformato in senso sicilianista o nazional/sabaudista il ruolo dei picciotti (v. per tutti G. FALZONE, li volontarismo siciliano, in Atti del XXXIX Congresso di Storia del Risorgimento Italiano (PalermoNapoli, 17-23 ottobre 1960), Roma 1961, pp. 147-74). Si è però trascurato, in genere, di valutare le condizioni oggettive dell'isolamento del regime borbonico nell'isola, che derivava da lontana e mai risolta conflittualità tra azione del riformismo assolutistico e coalizione degl'interessi semifeudali in funzione conservatrice. Che poi gli stessi intellettuali mostrassero incomprensioni e disagio di fronte alla realtà contadina di Sicilia, dolente e misera, in quanto contrastava in modo stridente col mito del «popolo di campagna» coltivato nella luce trasfigurante degl'ideali romantici, è un'altra questione da considerare sul piano delle contraddizioni insite nell'azione democratica. Lo stesso Nievo aveva però riconosciuto nel Frammento della Rivoluzione Nazionale la funzione spettante alle plebi rurali nel moto unitario, solo se la condotta politica del Partito d'Azione fosse stata tale da superare astratte finalità educatrici per accogliere, invece, bisogni e aspirazioni delle masse (v. F. DELLA PERUTA,1. N. e il problema dei contadini, in «Rinascita», Roma, a. VIII (1952),6 (giugno), pp. 354-56). In un noto passo delle Confessioni, aveva pure avvertito l'illusorietà d'una impostazione che avesse fondato i suoi presupposti sul semplice principio della libertà, mentre occorreva tener conto del «grado diverso di coltura» delle plebi di campagna e dei loro specifici interessi: «La libertà è preziosa, ma pel popolo bracciante anche la sicurezza del lavoro, anche la pace e l'abbondanza non sono cose da buttarsi via» (cfr. in Opere, a cura di S. Romagnoli, Milano-Napoli 1962, p. 1081). Cioè, in fondo, il medesimo rimprovero mosso da padre Carmelo alla illimitata fiducia dei patrioti garibaldini nella forza degl'ideali unitari: il popolo, «solo o diviso, se soffre, soffre «...» perché la libertà non è pane, e la scuola nemmeno» (cfr. G.C. ABBA, Da Quarto al Volturno, in Memorialisti dell'Ottocento, a cura di G. Trombatore, I, Milano-Napoli 1953, pp. 801-2).
Se da questa situazione scaturi un atteggiamento di formale concordia tra le diverse componenti della società isolana nella mobilitazione politica per l'Unità (e, di fatto, per il ripristino della legittimità dei poteri comunque intesi), tuttavia il fronte patriottico avrebbe manifestato assai presto le sue latenti scissure, che durante il periodo della dittatura garibaldina poterono essere smorzate attraverso l'accorta mediazione del Segretario di Stato Francesco Crispi, artefice del coevo riordinamento amministrativo e garante del compromesso sociale e istituzionale auspicato dai ceti possidenti. Crispi si preoccupò, fra l'altro, di «liberarsi» subito delle squadre (come scrisse il 25 maggio '60 a Vincenzo Orsini) e organizzare alloro posto un corpo di milizie regolari onde fronteggiare le crescenti inquietudini popolari167. Rapporti inviati dalle provincie non mancarono allora, e in seguito, di informare le autorità centrali sui sentimenti che agitavano i ceti inferiori: «Come reprimere in ciascun comune la plebe in docile invasa dal triste pensiero che il popolo è padrone di far tutto a suo modo, e chi si oppone al mal volere dei tristi è ingiuriato col vile nome di sorcio?», si chiedeva allarmato il principe di Granatelli, chiamato a reggere la questura mazarese. Né era gradito l'apporto dei civili per il mantenimento dell'ordine, giacché «le altre classi poco ajutano i civili, odiando invece in essi coloro che impediscono sfrenarsi in idee delle quali sono dominate le masse»168.
167 F. BRANCATO, La dittatura garibaldina nel Mezzogiorno e in Sicilia, Trapani 1965, pp. 131-34.
168 Cfr. il rapporto del 19 agosto 1860 inviato dal questore di Mazara al direttore della pubblica sicurezza in Sicilia, in ASP, ML, Polizia, Affari diversi, b. 1517, filza 47. Qualche giorno prima, pure da Mazara, erano arrivati segnali allarmanti sul disordine rurale. Il governatore del distretto, Alberto Maria Mistretta, pubblicava un'ordinanza «onde darsi un freno alla classe dei «custodi de' campi», e a' tristi de' quali non manca la società, specialmente negli attuali tempi in cui si ha la credenza che la libertà consista nella ruba, e nello sfogo delle private vendette» (ivi, filza 45; ordinanza del 6 agosto e lettera del 7 agosto 1860 al Segretario di Stato per la sicurezza pubblica).
La presenza di forze soggiogate allo «spirito di mafia» in un contesto dominato dalle logiche del capitalismo della rendita - e in tempi in cui (come affermava nell'agosto del '60 un governatore distrettuale) si deve pur reagire alla «credenza» diffusa tra i ceti subaltemi «che la libertà consista nella ruba, e nello sfogo delle private vendette» - indica il grado di manipolazione delle regole sociali raggiunto dal nuovo sistema borghese. Tracciando ora uno schema del background storico su cui si genera e si sviluppa il fenomeno mafioso, cercheremo di sintetizzare il processo attraverso cui è stato possibile abilitare le mafie alla funzione organica di struttura compensativa e di controllo delle tensioni di fondo della società siciliana nel periodo di transizione dalla fine dell'ordinamento feudale alla formazione dello Stato unitario.
Tra le tante opinioni che governano l'idea di mafia una almeno sembra incontrovertibile: «La mafia, come tale, è una ed ha sempre avuto gli stessi fondamentali caratteri» (F. Brancato), perseguendo volta a volta gli stessi fini: l'arricchimento e la prevaricazione. La variante antropologica di una simile opinione ne assegna persistenza e uniformità a quel «sistema di valori» che qualificherebbe l'agire subculturale di gran parte dei Siciliani 169.
169 Sulla genesi e sui caratteri originari della mafia (o, più precisamente, delle mafie), non ostante l'abbondante bibliografia prodotta a partire dagli anni '60 coevi all'inchiesta parlamentare antimafia, non si hanno ancora sicuri approdi storiografici. Il limite di una tale produzione consiste, oltre che nella ripetitività ed estemporaneità di molti giudizi, nella intrusione di paradigmi sociologici e antropologici spesso fuorvianti. La mafia, avulsa dal contesto delle dinamiche sociali, degl'interessi economici, dei rapporti con le classi dirigenti locali, finisce inevitabilmente col caricarsi di modelli culturali metastorici. Nel migliore dei casi, la storia del fenomeno si esaurisce in una rassegna di «opinioni», piu o meno pregnanti, che non possono però surrogare la mancanza di riscontri archivistici e, anche. prosopografici, che dovrebbero permettere uno studio diacronico del microcosmo sociale in cui le mafie si sono elaborate. Le opinioni espresse nel corso di un secolo sono state raccolte nella Bibliografia della mafia, a cura di D. Novacco, in «Nuovi quaderni del meridione», II (I 964), n. 5 (gennaio-marzo), pp. 188-239, e nella rassegna di F. BRANCATO, La mafia nell'opinione pubblica e nelle inchieste dall'Unità d'Italia al fascismo, in SENATO DELLA REPUBBLICA, Atti Parlamentari, leg. V, doc. XXIII, n. 2-septies: COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA, Relazione sui lavori svolti e sullo stato del fenomeno mafioso al termine della V legislatura, 1972, pp. 161-277. Gli studi piu recenti sono ora discussi da R. SPAMPINATO, Per una storia della mafia. Interpretazioni e questioni controverse, in La Sicilia, a cura di M. Aymard e G. Giarrizzo, pp. 883-902.
Avviene cosi che il fenomeno della extralegalità mafiosa perda i suoi connotati storici per ridursi a «comportamento», valore e simbolo di sicilianità deviata (ma non troppo), sentimento ata vico di violenza. La storia, semmai, è quel continuum di fatti che legano le fasi della «evoluzione» della mafia e ne esplicitano l'identità, nonostante le variazioni accidentali del suo manifestarsi. La mafia può mantenere intatta la sua forza occulta anche di fronte alle repressioni poliziesche piti dure, mimetizzandosi perfino col colore stesso dei regim.i politici. Caduto il fascismo, che aveva operato con estrema determinazione per annientarla, si è potuta ricostituire sul fondamento della sua stessa informalità (coesione dei poteri occulti e strutture del consenso). Poi è «passata» dalla campagna alla città, trasferendo uomini e metodi nei grandi affari della speculazione edilizia.
Purtroppo il processo che genera questo tipo di criminalità non è cosi semplice come di solito si tende a rappresentare. La continuità uniforme, o anche l'atavicità subculturale, in cui il fenomeno mafioso sembra connaturarsi non ne spiega le infinite modulazioni storiche; mentre, nei riflessi dell'intervento coercitivo dello Stato, le troppe reticenze politiche (anch'esse originate da concrete situazioni storiche) lo rendono praticamente invulnerabile. Senza voler assumere criteri generali di periodizzazione, e di valutazione sistematica, ci limitiamo qui a riepilogare quanto è emerso dall'indagine sui mafiosi di Castellammare e quanto svilupperemo successivamente nel capitolo dedicato alla mobilità sociale del ceto borghese/agrario.
Non si può intanto negare che atteggiamenti e mentalità assimilabili al tipico comportamento mafioso sono presenti già prima della nascita, per cosi dire, istituzionale della mafia. Gli «amici», il «partito», il rispetto dovuto e imposto sono tutti gradi di aggregazione e di riconoscimento di cui è traccia nelle testimonianze demologiche, oltre che nella casistica criminale degli anni del declinante dominio baronale. Ed è altrettanto innegabile che gli uomini di rispetto ricevano legittimità dall'ambiente nello spirito di quella mafiosità latente che eredita gli elementi sovrastrutturali del sistema feudale (sacralità della violenza, sentimento arcaico e rimuneratorio della giustizia, vincolo di dipendenza personale).
Può darsi che le unioni o fratellanze segrete, di cui parla Ulloa, abbiano risposto al fine di volgere «l'interclassismo» dei nuovi ceti a favore della classe media rurale, come sostengono alcuni studiosi; ma è vero altresi che esse, animate in fondo da rozzo spirito corporativo (un po' sull'esempio delle confraternite e associazioni giurate delle città), siano state chiamate a svolgere un ruolo di supplenza dei poteri di controllo sociale, fidando sull'uso della violenza fisica e sui sentimenti comuni di feudale servigio, nel momento in cui lo Stato svuotava di significato e di forza il patrocinio del barone. Ma la legittimazione delle mafie nel contesto della società civile e, quindi, la pubblicizzazione della figura del mafioso, assunto a funzioni di sempre maggiore autorità e prestigio, si sono avute allorché la dissoluzione dei rapporti feudali apriva le possibilità di sfruttamento della ricchezza e delle risorse locali non solo a quanti (civili o galantuomini) erano già inseriti nelle nuove articolazioni del potere, ma anche agli uomini piu violenti del basso ceto rurale, capaci tanto di usare la forza coercitiva, quanto di sfruttare a vantaggio proprio o altrui il sistema delle «mediazioni».
Non si può comprendere, tuttavia, l'entità di questo processo di «pubblicizzazione» del mafioso senza considerare il coevo fenomeno dell'insorgere e mobilitarsi delle fazioni municipali ai fini dell'accrescimento dei patrimoni personali e della piena disponibilità delle leve del potere locale, come le sole opportunità che si offrivano al nuovo ceto borghese di assicurarsi il controllo degl'interessi emergenti. Nello stesso tempo il mafioso poteva agire nella duplice funzione di «guardaspalle» al servizio della borghesia agraria e d'intermediario dei poteri legali ed extralegali; ma anche avvalersi del «rispetto» acquistato ai fini di una sua promozione di status, convinto ormai della «necessità della mafia per riuscire nella vita» (che è la perspicua espressione usata da Cammareri Scurti).
L'intervento delle mafie a prendere su di sé le responsabilità dell'ordine pubblico, durante i moti antiborbonici nei Comuni rurali, deve essere considerato come un diretto coinvolgimento nella lotta tra le fazioni municipali, con ruoli sempre piu distinti di salvaguardia degl'interessi agrari costituiti. Da qui il crescente prestigio della «mafia», cui si riconosceva la capacità, che mancava agli organi dello Stato, di mantenere l'ordine e la sicurezza. Questa dimensione del potere extralegale si è resa tuttavia possibile in un contesto economico in cui i processi di «accumulazione originaria del capitale» avvenivano nei soli modi della intermediazione parassitaria, e quindi la «mafia» fini con l'essere funzionale al sistema della rendita. Mediante il sostegno armato alle fazioni in lotta per la supremazia nei Comuni, i gruppi mafiosi poterono realizzare quel collegamento con le istituzioni e con la politica che si sarebbe presto trasformato in rapporto d'interdipendenza, consentendo cosi ad essi di superare lo stadio puramente difensivo della giustizia rimuneratoria esercitata all'interno delle fratellanze per inserirsi, invece, nelle dinamiche stesse dello sviluppo borghese/agrario.
È con questa eredità mafiosa che lo Stato unitario dovrà fare i conti, non certo con l'apparato normativo tradizionale degli «uomini di rispetto». Il crescente prestigio del mafioso nella società isolana postunitaria deve porsi in relazione allo sviluppo di un'economia rurale che sempre piu si reggeva sulla rendita derivante dalla intermediazione parassitaria e dallo sfruttamento del lavoro contadino, per il cui esercizio lo stesso mafioso garantiva inizialmente il patrocinio e le regole di condotta (basti pensare alle figure del «commessionario» e del campiere o «guardaspalle») fino a sostituirsi, in seguito, nella gestione «mercantile» della terra al proprietario/civile, che tale gestione aveva potuto assumere nel contesto dei processi di privatizzazione del feudo.
La sua legittimazione avviene, quindi, non soltanto a livello di valore, attraverso gli atti, piu o meno vistosi, del comportamento mafioso, ma soprattutto a livello difunzione, per le forme della mediazione adoperata al fine di assicurare la massima convenienza economica al sistema speculati vo dei semplici percettori di rendita.
A voler definire la natura e le tecniche di penetrazione nella realtà sociale di un tale meccanismo di «competizione controllata» gioverà solo accennare ai rapporti d'interdipendenza tra logica delle pressioni mafiose e paradigmi del potere locale. Se l'uso sistematico della violenza privata fa pensare al grado iniziale del curriculum intrapreso dall'uomo di rispetto, non bisogna nemmeno dimenticare che la tendenza piu marcata e diffusa dei singoli mafiosi è rivolta ad occupare spazi e ruoli istituzionali nei vari ambiti di controllo della sicurezza interna (guardia urbana o nazionale, compagnie d'armi o militi a cavallo). Ciò si manifesta in quella congiuntura di transizione che è segnata dalla fine dell'antico regime (e dal conseguente tentativo dei Borboni di organizzare una struttura moderna dello Stato) e dall'embrionale assetto politico-amministrativo dell'Italia unita. Al riconoscimento del ruolo «pubblico» informale del mafioso contribuisce non soltanto la posizione di comando, o quanto meno di mediazione e prestigio, raggiunta entro la rete di controllo dell'ordine interno, ma anche la possibilità di collegarsi con le sfere del potere locale. Il sistema di manipolazione della rappresentanza politica attuato dalle fazioni municipali sulla base del familismo clientelare (fenomeno indicato dalle autorità del tempo come «spirito di famiglia») escludeva la massa contadina; ma a mantenere la «passività» del contadino era pure indispensabile l'accettazione generalizzata dei codici culturali della mafiosità garantiti dagli uomini di rispetto. La mobilità sociale del mafioso era perciò correlata a un duplice radicamento di mentalità e di logica delle connivenze: l'isolamento, anzitutto, dei ceti subalterni dai processi d'integrazione nella comunità nazionale (anche il rifiuto della leva si faceva rientrare da alcuni funzionari del governo nelle suggestioni mafiose dell'ambiente), o almeno la loro indifferenza nei confronti dello Stato; e poi le pressioni esercitate sugli organi del potere locale e sulle istituzioni giudiziarie per avvalorarne di fronte alle masse l'inefficienza pragmatica.
Del resto, nei rapporti tra «centro» e «periferia» le strategie mafiose di omologazione .0 di reiezione della realtà unitaria, a livello di mediazione politica e di prassi sociale, avrebbero configurato una formalizzazione del potere locale abbastanza duttile per potersi piegare ai nuovi equilibri istituzionali dello Stato liberale.
|
|

|