
Salvatore Costanza

la copertina
© Copyright 1989
Arti Grafiche Corrao
via Valenza, 31
Trapani
Finito di stampare
nel settembre 1989
Ringrazio l'amico
Vito Accardo
per avermi portato
alla conoscenza
di questo libro
Questa ricerca storica riproduce, con ampliamenti e integrazioni, l'omonimo studio pubblicato nel fascicolo speciale dei «Nuovi quaderni del meridione» dedicato alla rivoluzione palermitana del settembre 1866 (n. 16, ottobre/dicembre 1966, pp. 419-38).
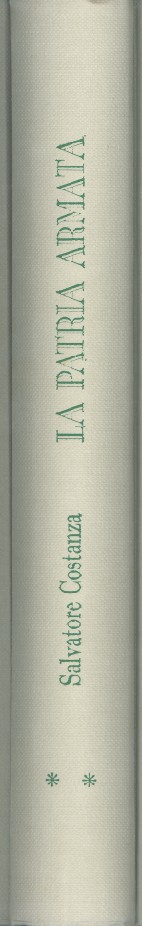
|

|
|
Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
|
LA PATRIA ARMATA di Salvatore Costanza
|
LA RIVOLTA CONTRO I «CUTRARA»
(Castellammare del Golfo, 1/3 gennaio 1862)
3. Le fazioni municipali e lo «spirito di famiglia»
«Esistono in Castellammare da oltre il 1848 due opposti partiti:
il liberale ed il borbonico. In entrambi si ebbero a lamentare danni nelle persone e nelle sostanze: cosi nel 1848 era di pieno giorno aggredito ed ucciso Gioacchino Marcantonio membro del Comitato liberale, ed al Di Blasi Andrea, capo della parte borbonica, veniva distrutta con le fiamme la casa. L'una e l'altra di queste due parti a vicenda prese il sopravvento nel Comune a seconda degli eventi politici. Nel 1861 la parte liberale avendo riuniti in sé tutti gli impieghi comunali, e Francesco Borruso liberale, avendo nella carica di Segretario comunale soppiantato il fratello Gioacchino borbonico, il rancore dei retrivi fatto piu vivo che mai non peritavasi di mostrare che aspettava, sperando, tempo opportuno ai tenebrosi disegni. E giunse purtroppo il tempo in cui i borbonici a tirare a sé la volgare turba ebbero favorevole la legge, da essi posta a colpa dei liberali, sulla leva qui tradizionalmente avversata a detrimento della militare fama della Sicilia.
Onde è che invano a guardia dei decreti per la leva affissi in Castellammare fu messa la forza: questa, non potente per numero a frenare il disordine, dovette cedere alla moltitudine irrompente, e quei decreti furono lacerati; e per siffatta lacerazione si istituiva allora contro d'alcuni, fra cui il figliuolo di Gioacchino Borruso, criminale procedimento»57.
57 Cfr. resoconto del processo per i fatti di Castellammare in «Diritto e Dovere», suppl. al n. 23 del 20 giugno 1864. Il capo dei liberali, Borruso, era nato a Castellammare 1'8 ottobre 1802 (v. in AMC, Liber bapt., 1802, f. 109r).
Era la ricostruzione degli antecedenti della rivolta scatenatasi nei primi tre giorni del '62 compiuta dal giudice istruttore, preoccupato di stabilire un legame tra le lotte di fazione e l'esplosione antileva, che non rendeva onore alle tradizioni militari dell'isola. In realtà, nelle alterne fasi della vicenda risorgimentale, il contrasto tra i «partiti» che si era manifestato su schieramenti di gruppi personalistici aveva trovato ragioni e passioni dalla contesa per le reali, o potenziali, risorse a disposizione della pubblica amministrazione, assumendo solo esteriormente connotati politici: illegittimismo borbonico oppure illiberalismo attinto a vago autonomismo o il democraticismo unitario, perfino orientato verso il repubblicanesimo, cioè verso quelle «strane e pazze idee di libertà e di eguaglianza» cui si era riferito qualche funzionario borbonico nei suoi rapporti informativi58.
58 Cfr. il rapporto riservatissimo del giudice regio di Castellammare del 4 settembre 1850 all'intendente di Trapani in AST, FI, Polizia, Corrispondenza (1849-53), fasc. Castellammare, doc. 7. Le idee piu spinte di democrazia sociale pare fossero bandite dal dr. Simone Riggio (nato a Burgio il 4 agosto 1809), il quale era, tra i liberali del paese, quello che godeva forse il maggior prestigio intellettuale. Li aveva rappresentati, nel 1848, al Parlamento siciliano, e nel decennio che precedette l'Unità subi la costante sorveglianza delle autorità borboniche, che lo consideravano assai pericoloso per le «strane utopie» da lui professate. Fu arrestato la prima volta il 28 agosto 1850 e rinchiuso per un mese nelle prigioni di Palermo (ivi, Affari diversi (1850-51). Poi ancora nel gennaio del '54, dopo che la polizia aveva rinvenuto nella sua casa stampa clandestina. A Favignana rimase a domicilio forzoso fino al maggio di quell'anno (ivi, Corrispondenza (1854); ASP,ML, Polizia, Affari diversi. Alcamo, b. 1505, filza 48). Su di lui, v. S. COSTANZA, Tradizione e rivoluzione. Dal '48 al '60, Trapani 1963, p. 44.
È evidente, quindi, che la condizione essenziale del successo dell'una o dell'altra fazione poggiava sui legami di clientela, poco sulla credibilità politica che tuttavia veniva invocata a formare il necessario collegamento tra il centro e la periferia. I filoborbonici riconoscevano nel comportamento dei liberali soltanto uno spirito di rivalsa. I liberali, dal canto loro, rivendicavano una propria legittimazione al potere in nome dei nuovi principi, mentre però si adoperavano con atteggiamenti di resipiscenza e di finto lealismo a neutralizzare le accuse degli avversari, in un giuoco della dissimulazione che, in parte, era dettato dalle condizioni in cui erano costretti a muoversi, ma che era pure spinto dalla preoccupazione di non perdere certe lucrose posizioni già acquisite59. Se si considera il grado di compenetrazione con il sistema di sfruttamento delle risorse locali da essi raggiunto, si può forse giudicare quale fosse anche il grado di convinzione politica dei patrioti castellammaresi, alcuni dei quali, già da tempo, costituivano la forza rampante della borghesia medio-alta dei galantuomini.
59 Sono abbastanza numerose le testimonianze, conservate tra le carte dell'Intendenza borbonica, sul comportamento di finto lealismo degl'individui sospettati di appartenere agli oppositori del regime. Per es., Simone Riggio dichiarava «di aver sempre rispettato il Governo, ed il Leggittimo Nostro Sovrano» (cfr. supplica del 13 settembre 1850 inviata al direttore della polizia in Palermo, in AST, FI, Polizia, Affari diversi (1850-51). Francesco Borruso, pur avendo presieduto nel '48 il Consiglio civico castellammare se, affermava da parte sua di essere sempre stato «un buon cittadino». Nell'autunno del '59, in seguito alla scoperta di una cospirazione antiborbonica a Bonagia (Monte S. Giuliano), la polizia aveva operato alcuni arresti anche a Castellammare, mentre si era ordinato il disarmo della popolazione. A Francesco Borruso era stato sequestrato, in quella occasione, il fucile; ma egli aveva protestato la sua lealtà al Governo, chiedendo perciò all'intendente di Trapani che volesse esperire indagini sul suo conto - ma non attraverso il sottintendente di Alcamo, né il sindaco di Castellammare «in dispiacenza con l'esponente per interessi di famiglia» -, onde provare la regolare condotta da lui tenuta (v. supplica del 18 ottobre 1859, ivi, Corrispondenza (1859-60). D'altro canto, il s.int. di Alcamo, Domenico lezzi, aveva confermato al luogotenente generale in Palermo che Borruso, da tempo, aveva «dimesso il di lui spirito demagogico» (nota del 9 ottobre 1859 in ASP, ML, Polizia, Affari diversi. Alcamo, b. 1505, filza 48).
In uno dei rapporti inviati al principe di Satriano, luogotenente del re a Palermo, dal comandante della colonna mobile, che era venuto a Castellammare nel settembre 1849 per il disarmo della popolazione, si trovano le seguenti notizie sulle fazioni che si contendevano il potere locale: «In questo paese il motore principale de' sconcerti, dissubidienza alle leggi, insubordinazione ed assassini, è il voler essere a capo di un'amministrazione comunale, e dispotizzare. Prima dello sconvolgimento della Sicilia reggevano qui la somma delle cose il Cancelliere Comunale, D. Andrea De Blasi, e lo estinto Sotto Capo D. Giuseppe Marcantonio. Il primo Cancelliere, e Notaro, richiamava cosi gli affari tutti a sé, ed il matrimonio non si effettuiva, né si riceveva il favore del Comune, se non pel di lui mezzo. Il Marcantonio lusingava con la di lui attitudine le Autorità, perseguitava quel ladro che non le conveniva, ed intanto Forno pubblico, fabbrica di pasta, gabelle, a sé, e la popolazione dovea mangiare e pagare a di costui talento». Seguaci di questa fazione erano il sacerdote Benedetto Palermo, don Procopio Carollo, don Mariano Di Giorgi, Giuseppe Bologna e i suoi figli, «ladri protetti»60. Il partito avverso, «che reclamava con verità, e con menzogne», era composto da don Giuseppe Marcantonio Plaja, don Francesco Borruso, don Simone Riggio, dai fratelli Galante, dalla famiglia Zangara e dal prete Mangiarotti61.
60 Ne facevano ancora parte altri notabili castellammare si (come il notaio Mariano Lombardo, l'avv. Leopoldo Coniglio, don Pietro Costamante, i proprietari Giuseppe, Gaetano e Niccolò D'Anna, Giovanni e Giovan Battista Sangiorgio). Tra essi era pure don Gioacchino Borruso, genero del notaio Di Blasi e fratello del liberale Francesco Borruso. L'elenco dei tiloborbonici in G. CALANDRA, I casi, pp. 15-16.
61 Il sottintendente di Alcamo confermava da parte sua l'esistenza dei due partiti:
«Un partito si compone di quei che figurarono nella rivolta, fra questi signoreggiano il Sac.te D. Ignazio Galante maestro di scuola secondaria uomo pericoloso per tutti i riguardi, finto, e d'intrigo; il Dr. D. Leonardo Calandra ciarliere di mala fede e meno pericoloso del primo perché meno astuto, Dr. Francesco Borruso uomo timido, e frenato per paura, D. Simone Riggio esaltato, ed incapace di ravvedimento; gli altri non possono considerarsi che come semplici satelliti di questi, facili a frenarli. L'altro partito è formato da quelli che nella rivolta furono bersaglio de' primi, e che cercano nella reazione la loro vendetta. Si additano tra questi un D. Gio. Battista Sangiorgio Ex Capo Urbano uomo poco elevato; D. Santi Carollo giovane imprudente e vendicativo; e D. Andrea Di Blasi attuale Cancelliere Comunale prudente, scaltro molto, ed intelligente, ed occulto fra essi, figurato dall'avvocato D. Leopoldo Coniglio». Cfr. il rapporto del s.int. di Alcamo all'intendente di Trapani, 5 settembre 1850, in AST, FI, Polizia, Corrispondenza (J 849-53), fase. Castellammare, doc. 8.
Gli atti di violenza che alimentavano lo spirito di fazione servivano a raggiungere vantaggi immediati, ma anche a soddisfare un sordo istinto di rappresaglia. «Presentatosi il momento opportuno - scriveva, infatti, l'ufficiale nel suo rapporto di sfogare la di loro vendetta, e trovando la popolazione che già additava come connessori il Cancelliere, ed il Sotto Capo, cosi con la veste di liberale i primi, e l'imputazione di realismo ne' secondi, si commettevano gli eccessi d'incendi e di assassini»62.
62 Cfr. il rapporto del com.te la colonna mobile in Castellammare al principe di Satriano, N. 374 del 13 settembre 1849 (ivi).
Il contrasto che opponeva le due fazioni municipali era sfociato, nel '48, in episodi di violenza criminale. Il notaio Di Blasi (1801-1876), salito da umili condizioni alle piu ambite cariche pubbliche, se ne era servito per colpire il partito avverso e arricchirsi63; ma dopo aver fatto uccidere Gioacchino Marcantonio, che sedeva nel comitato rivoluzionario, dovette nascondersi e, travestito, sfuggire alla vendetta dei suoi nemici. Qualche anno appresso la Corte criminale di Trapani lo rinviò a giudizio, avendolo riconosciuto colpevole di quel delitto. Ciò non ostante per le interferenze dell'alcamese Francesco Mistretta (allora direttore in Sicilia del ministero di grazia e giustizia), che richiamò a sé gli atti del processo, la sentenza non fu mai pronunziata64.
63 G. CAlANDRA, l casi, pp. 4-9. Una ricostruzione piu minuziosa delle vicende che portarono il notaio Di Blasi a «dispotizzare» il Comune si trova nel libello, dello stesso Calandra, L'avvocato ed i parricida; ma anche nelle carte dell'Intendenza borbonica non mancano i rilievi sull'ambigua condotta dello stesso Di Blasi, inteso pitittu (fame) dalla voce popolare per la sua avidità.
64 Di Blasi figura, infatti, insieme con Me\chiorre Valente, Michele Mione, Giuseppe Galante e il cognato Giacomo Grasso, come imputato per l'uccisione di don Gioacchino Marcantonio Plaja (v. Stato indicante ifatti aiminosi di qualunque natura accaduti in questo Comune e suo Circondario durante il periodo della passata rivoluzione dal di 12 gennaio 1848 al I4 maggio 1849, trasmesso dal giudice regio di Castellammare all'intendente di Trapani, in AST, FI, Polizia, Corrispondenza (1849-53), fasc. Castellammare, doc. 4). Gioacchino Marcantonio fu assassinato, all'età di 35 anni, la sera del 17 settembre 1848 ai Fraginesi (v. in AST, Registro degli atti di morte del Comune di Castellammare, 1848, vol. 28, N. 111). Il processo contro gli assassini di Marcantonio si concluse nel 1856 con la condanna a morte di uno dei sicari e l'ergastolo per gli altri due (Valente era stato frattanto ucciso in oscure circostanze). Dal processo venne stra\ciata la posizione del notaio Di Blasi; ma a suo carico nulla poté piu riscontrarsi, dal momento che l'incartamento processuale che lo riguardava fu richiamato a Palermo presso il ministero di grazia e giustizia, dove, in pratica, fu archiviato (v. G. CAlANDRA, L'avvocato ed i parricida, pp. 40-44, 59-60).
Quando l'antico regime fu ripristinato, i filoborbonici avrebbero voluto «vendetta di sangue»: «ma il coraggio, ed il partito, non gli assisteva, quindi scambievolmente voleva ognuno conseguire lo intento col reclamo, con la calunnia, e lo assassinio», concludeva il comandante Almeida65. Non mancarono in seguito di manifestarsi i segni del rancore lungamente covato tra le opposte famiglie, con le gravi manifestazioni d'intolleranza di cui furono protagonisti, nell'estate del '50, i Carollo e i Sangiorgio, sotto l'abile regia del notaio Di Blasi. Tanto che il direttore della polizia Maniscalco non poté fare a meno di prendere contro costoro severi provvedimenti, mandando due di essi a domicilio forzoso in Corleone, e ammonendo lo stesso Di Blasi66. La conflittualità municipalistica era destinata a riaccendersi con l'incalzare degli eventi insurrezionali dell'aprile/maggio 1860. A promuovere il moto popolare nel segno dell'unitarismo sabaudo furono D. Bartolomeo Asaro e D. Francesco Borruso, insieme col figlio di quest'ultimo, Giuseppe, e con Vincenzo Coco, i quali poi tentarono di raggiungere Palermo con due squadre di picciotti67. Il giudice regio di Castellammare cercò, allora, di convincere i proprietari a difendere con le armi l'ordine sociale minacciato dalle turbolenze dei popolani; ma l'occasione per sfogare ancora una volta gli odii privati sembrava dovesse prevalere sugl'interessi di classe: «Il ceto dei proprietari che nutriva ancora gli antichi rancori mi presentava il quadro di una strage cittadina, e quindi grandi ostacoli doveva sormontare per unirlo compatto in armi, e prevenire cosi il turbine che minacciava scoppiare di una conflagrazione di sangue e di rapina»68.
65 Cfr. il cito rapporto del com.te la colonna mobile in Castellammare al principe di Satriano, N. 374 del 13 settembre 1849, in AST, FI, Polizia, Corrispondenza (/849-53), fase. Castellammare, doc. 2.
66 «Non per trascorsi politici, ma per turbolenza di partiti» furono allontanati da Castellammare Santi Carollo e Giambattista Sangiorgio. L'ammonizione fu elevata, oltre che a Di Blasi, all'avvocato Leopoldo Coniglio (v. note del direttore di polizia Maniscalco all'intendente di Trapani, 17 e 26 settembre, 8 ottobre e 30 novembre 1850, ivi, Affari diversi, 1850-51). Accogliendo le proposte del giudice regio di Castellammare, Maniscalco provvedeva pure per l'allontanamento di alcuni «sospetti in materia politica», tra i quali il sac. Ignazio Galante (prima destinato forzosamente a Corleone e poi ad Alc;1mo, e infine prosciolto dalla misura di polizia con ordine del 3 dicembre 1850) e i due medici Leonardo Calandra e Simone Riggio fu Giacinto (ivi).
67 G. MISTRETTA DI PAOLA, I fratelli Santanna nella rivoluzione siciliana del 1860. Esposizione documentaria, Alcamo 1962, pp. 20, 22-23, 26, che utilizza i documenti dell'archivio Coppo la conservati presso la Società siciliana per la storia patria. Sui conati insurrezionali dell'aprile/maggio 1860, e sulla guerriglia che ne scaturi nel Trapanese sotto il comando di Coppola e Sant'Anna, v. i documenti inediti del fondo d'Intendenza da me pubblicati in occasione del centenario della spedizione garibaldina: S. COSTANZA, Fonti per la storia del Risorgimento nell'Archivio di Stato di Trapani, in La Sicilia dal 1849 al 1860 , pp. 111-57.
68 ASP, ML, Polizia 1860, Affari diversi. Alcamo, b. 1505, filza 48; rapporto del giudice regio di Castellammare al direttore della polizia in Palermo, 20 aprile 1860.
L'avvento del partito liberale al potere sull'onda del successo garibaldino era comunque accettato come una logica alternanza delle parti, riservandosi il partito avversario il diritto di preparare con ogni mezzo la propria rivalsa.
Il nuovo gruppo dirigente formatosi con gli esponenti del ceto civile/proprietario che si era contrapposto, piu o meno apertamente, alla fazione borbonica mostrava, intanto, di essere abbastanza omogeneo, perché composto da alcune famiglie ben saldate tra di loro da vincoli di parentela e da rapporti d'interessi. I cutrara - cosi erano chiamati dalla voce pubblica quei notabili che si preparavano a trarre concreti benefici dalla privatizzazione dei beni ecclesiastici e demani ali prevista dagl'indirizzi della politica economica del Governo unitario - avevano ora in mano il paese. Sindaco era, fin dal giugno del '60, Giuseppe Marcantonio Plaja, eletto pure consigliere provinciale insieme con altri due esponenti liberali, Francesco Saverio Borruso e Simone Riggio69. (Quest'ultimo avrebbe ricoperto in seguito l'incarico di vice-pretore.) Tra i nuovi consiglieri e assessori c'erano lo stesso Simone Riggio, il medico Leonardo Calandra70, Bartolomeo Asaro, commissario di leva, i sacerdoti Ignazio Galante71 e Antonino Zangara.
69 Proclamazione de' Consiglieri Provinciali, in «Giornale Officiale del Governo della Provincia di Trapani», n. 4 del marzo 1861, pp. 256-59.
70 Il figlio Giuseppe, nato 1'11 ottobre 1832 (v. in AST, Registro degli atti di nascita del Comune di Castellammare, 1832, voI. 15, N. 181), era l'autore dei Casi di Castellammare.
71 Il sacerdote Ignazio Galante era indicato dal vescovo della diocesi come una vera «pietra dello scandalo» per la sua equivoca condotta morale. «Stanco l'animo mio pastorale - scriveva Antonino Salomone - della inemendabile scandalosa condotta di vita del Sacerdote D. Ignazio Galante, del Comune di Castellammare, non so trovare altro spediente, che rivolgermi a Lei, Sig.r Intendente, con preghiera che un cotale traviato Sacerdote, stato pietra di scandalo ad un intiero comune sotto ogni aspetto, e piu per la illecita tresca in cui ha vissuto e vive tuttora, venisse obbligato a condursi nel Convento dei PP. Cappuccini in Gibilmanna, ed ivi farlo vivere alla totale dipendenza di quel Superiore locale, finché una prova si avesse del di lui rinsavimento che farebbe costare il detto Superiore. Da ultimo la pregherei eziandio, che pel bene della studiosa gioventu venisse al medesimo sottratta l'incombenza di Maestro di Scuola del Liceo di quel Comune, non convenendogli affatto un si geloso uffizio» (cfr. lettera del vescovo di Mazara all'intendente di Trapani, 9 settembre 1850, in AST, FI, Polizia, Corrispondenza (1849-53). Ignazio Galante aveva fatto parte, nel periodo rivoluzionario, del Consiglio civico di Castellammare (v. elenco dei consiglieri trasmesso da Francesco Borruso al presidente del Comitato del Valle di Trapani, il 17 giugno 1848, in AST, FI, Commissariato del Potere Esecutivo del Valle di Trapani (1848-49), fase. unico). Sorvegliato dalla polizia borbonica per le sue manifeste simpatie verso gli oppositori del regime, sarebbe rientrato nel nuovo Consiglio Comunale eletto dopo l'Unità, occupando anche la carica di assessore. Nato a Castellammare il l' agosto 1817, vi mori il13 giugno 1881 (v. in AST, Registro degli atti di morte, 1881, vol. 63, N. 175).
D. Francesco Borruso aveva occupato per qualche tempo l'ufficio di segretario comunale al posto del fratello Gioacchino, schierato con la parte borbonica per essere stato acquisito nella parentela del notaio Di Blasi, avendone sposato una delle figlie. L'ordine pubblico interno era affidato a D. Gaspare Fundarò (delegato di pubblica sicurezza) e, ancora, a Francesco Borruso (comandante della guardia nazionale). A reggere l'ufficio dei «rami e dritti diversi», che aveva tra i suoi compiti quello di amministrare i beni e cespiti demaniali72, rimase lo stesso Borruso, che lo deteneva senza interruzioni sin dal 1853.
72 Raccolta delle leggi. decreti ed istruzioni riguardanti l'amministrazione dei Rami e Diritti diversi in Sicilia, a cura di G. Monforte, Palermo 1859. L'Ufficio per Castellammare era stato ottenuto da Francesco Borruso, prima come ricevitore «sopranumaro», poi come titolare.
Cosi il monopolio del potere locale da parte di pochi notabili fondava la sua legittimazione sulle istituzioni pubbliche, intermediarie col potere statuale: il municipio, da cui derivava il consenso politico delle ristrette clientele e parentele (spesso coincidenti), e gli uffici che esercitavano l'autorità della legge per l'amministrazione della giustizia e per la sicurezza interna del paese; nonché gl'impieghi piti lucrosi del settore finanziario. Francesco Borruso (1802-1862), coi suoi molteplici e ben collocati posti di comando, rappresentava in tale struttura di potere un ruolo chiave,. necessario a coagulare entro i nuovi canali di patronage le spinte borghesi. Le fonti da cui i cutrara potevano trarre i profitti, leciti e illeciti, di un certo sistema di sfruttamento e accumulo della ricchezza erano costituite da quei settori della cosa pubblica in cui con maggiore spregiudicatezza si esercitava il peso delle clientele:
l'amministrazione delle opere pie e gli arrendamenti dei dazi civici e regi, gli appalti delle opere pubbliche, l'affitto dei demani e, perfino, l'usurpo dell'acqua, destinata inizialmente dal municipio all'approvvigionamento idrico della popolazione, ma poi quasi sempre captata dai proprietari dei fondi agricoli ad uso irrigatorio.
Borghesia terriera di massari e proprietari, clero e ceto civile erano ugualmente coinvolti nel furore dei contrasti paesani, saldati ai «partiti» dalla necessità fisiologica di acquistare o mantenere il piccolo potere mediante il quale era consentito acquistare privilegi e distribuire rendite parassitarie. Le sole strade costruite dal municipio erano quelle che raggiungevano i fondi degli amministratori comunali; dazi e gabelle si caricavano con esosa regolarità sui poveri e sui lavoratori; uffici e congreghe al servizio della comunità erano considerati, invece, come fonte di favori da accordare alle proprie clientele. Le note informative sullo spirito pubblico, inviate mensilmente dai sottintendenti di Alcamo alle autorità di Palermo e Trapani73, avevano già formato, in questo senso, un quadro di ripetute e desolate considerazioni sul malgoverno locale, innestato su un sistema di prevaricazioni e abusi ormai radicato e, perfino, incolpevole, una volta accettata dal pubblico, per timore o per connivenza, la liceità di un simile comportamento.
Una logica spietata e spregiudicata, quindi, manteneva fuori di sé la massa contadina, su cui non poteva esercitarsi il beneficio dell'istruzione74. Questa massa rimaneva moralmente e culturalmente estranea alle influenze del ceto civile e del clero, verso i quali anzi riservava un atteggiamento di ostilità e di sospetto, misto a inveterati rancori, per le sopraffazioni subite e gl'intrighi temuti. Il paese si presentava cosi al suo interno stratificato in gruppi familiari e comparaggi, divisi da contrasti di fazione oppure coonestati da acquisizione (e debito) parentale75.
73 ASP, ML, Polizia, Affari diversi. Alcamo. Rapporti e note informative sullo spirito pubblico nel distretto di Alcamo si trovano (per gli anni 1850/1860) nelle buste 646, 696, 759, 771, 862, 958, 1035, 1055, 1149, 1234, 1318, 1365, 1419, 1473-1474, 1505 e 1517.
Essi riguardano le condizioni dell'amministrazione finanziaria e della sicurezza interna, lo stato delle opere pubbliche, il comportamento del clero e dei fedeli, gli umori, qualche volta contrastanti, dell'opinione pubblica. Di solito redatti solo per rispondere ai questionari inviati dalle autorità centrali, contengono notizie schematiche, ma nella loro sequenzialità piuttosto congrue perché ne risulti un quadro sufficientemente veritiero delle condizioni locali. Debbono però essere integrati con i rapporti mensili inviati dai sottintendenti di Alcamo agl'intendenti di Trapani, che si conservano in AST, FI, Polizia, Corrispondenza (dall'ottobre 1849 all'aprile 1860).
74 La percentuale di analfabeti era, a Castellammare, la piu alta della provincia (95%). Secondo una statistica dei primi anni dell'Unità, i fanciulli che non godevano dei benefici dell'istruzione erano, rispettivamente, 515 (m) e 560 (1); fino all'anno scolastico 1867-68 gli alunni frequentanti erano solo 103, meno di quanti se ne contavano dieci anni prima (v. «Giornale della Intendenza di Trapani», n. 5 del maggio 1859). Dati e notizie sull'istruzione pubblica tra il 1860 e il 1870 si trovano nelle relazioni annuali a stampa degli ispettori scolastici Michele Rosa, Ferdinando Cassone e Giuseppe Spallicci (tip. G. Modica Romano). Questi dati, però, debbono essere valutati nel contesto della situazione siciliana, per la quale si rimanda ai lavori di E. VACCINA, L'analfabetismo in Sicilia secondo i censimenti demografici, Palermo 1967, e G. BONETTA, Istruzione e società nella Sicilia dell'Ottocento, Palermo 1981.
75 Sul patronaggio e sul sistema clientelare presenti in Sicilia come il prodotto «di piu relazioni diadiche verticali tra i patroni e i loro clienti», v. gli studi avviati dall'Istituto di Sociologia ed Etnologia dell'Università di Heidelberg: W.E. MOHLMANN e R.l. LLARYORA, Klientschaft, Klientel und Klientelsystem in einer sizi/ianischen Agro-Stadt, Tubinga 1968;
Strummula siciliana, Ehre, Rang und soziale Schichtung in einer sizi/ianischen Agro-Stadt, MeisenheimlGlan 1973. Secondo Mariano Valderrama (Finanzpolitik und Gesellschaft in Sizilien. 1860-1910, Heidelberg 1970), la conflittualizzazione nella società rurale siciliana si manifesta in primo luogo come conflitto tra fazioni, divergenti dai partiti e dai loro programmi, seppure con questi in qualche modo legate. Su patronage e solidarietà «strumentale», v. anche J. BOISSEVAIN, Patronage in Sicily, in «Man», n.s., I (1966), n. I (marzo), pp. 18-33.
|
|

|





