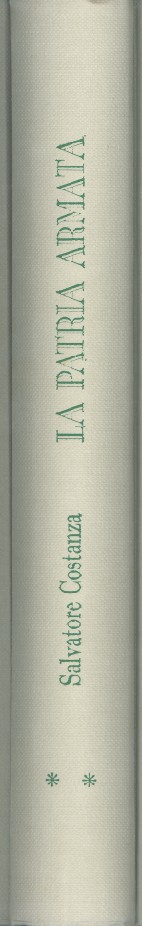Salvatore Costanza

la copertina
© Copyright 1989
Arti Grafiche Corrao
via Valenza, 31
Trapani
Finito di stampare
nel settembre 1989
Ringrazio l'amico
Vito Accardo
per avermi portato
alla conoscenza
di questo libro
Questa ricerca storica riproduce, con ampliamenti e integrazioni, l'omonimo studio pubblicato nel fascicolo speciale dei «Nuovi quaderni del meridione» dedicato alla rivoluzione palermitana del settembre 1866 (n. 16, ottobre/dicembre 1966, pp. 419-38).
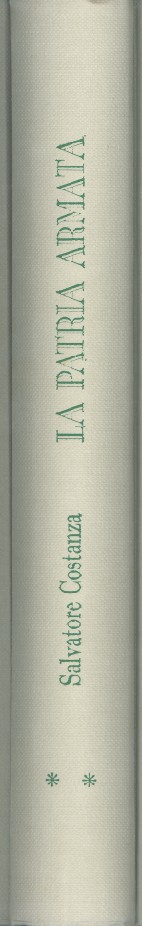
|

|
|
Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
|
LA PATRIA ARMATA di Salvatore Costanza
|
RIBELLI E MAFIOSI NEL TRAMONTO DEL BRIGANTAGGIO SOCIALE
L'argomento del presente lavoro ha costituito oggetto di una relazione al Convegno di studi sul Banditismo nella società moderna organizzato dall'Istituto Gramsci Siciliano sotto la presidenza del Prof. Eric J. Hobsbawm (Palenno, 13/14 marzo 1981).
Trasiti, nun parrati
e nun virili ...
Cu fu chi sparau?
Cu fu c'ammazzau?
Cu fu c'arrubbau?
Turricianu.
A Inici, Scupeddu, li Sarcuna
e la Balata ...
di li sbirri assicutatu,
prisulutu a la campia ...
scappa, scappa e fa scappari;
trema, trema e fa trimari.
Cu fu chi sparau?
Cu fu c'ammazzau?
Cu fu c'arrubbau?
Avi un distinu e un tagghiuni:
Turricianu.
Trasiti, nun parrati
e nun viriti ...
|
Entrate, non parlate
e non vedete ...
Chi è stato a sparare?
Chi è stato ad ammazzare?
Chi è stato a rubare?
Turriciano.
A Inici, Scopello, Sarconi
e Balata ...
dagli sbirri inseguito,
perseguitato nei luoghi piu remoti ...
scappa, scappa e fa scappare;
trema, trema e fa tremare.
Chi è stato a sparare?
chi è stato ad ammazzare?
chi è stato a rubare?
Ha un destino e un taglione:
Turriciano.
Entrate, non parlate
e non vedete ...
|
(Dalla tradizione orale: Anastasia Agnello, Castellammare del Golfo)
1. Tra mito e cronaca
Cu fu fu, fu Turricianu, asserisce un detto popolare ormai entrato a far parte della tradizione paremiografica siciliana1. A Pasquale Turriciano si potevano addossare tutte le responsabilità dei misfatti compiuti nell'Alto Trapanese fra il 1863-64, periodo d'inizio della sua attività di capobrigante, e il giorno della sua morte, avvenuta il 1O marzo del '70 durante un conflitto a fuoco con la forza pubblica2.
1 Il proverbio è riportato da Filippo Majorana in una sua raccolta, solo in parte edita, di canti popolari, feste e credenze, usi e consuetudini dell'agro ericino, che si conserva nella biblioteca comunale di Erice (Carte Majorana).
2 Pasquale Turriciano - cosi è trascritto esattamente il suo nome allo stato civile, e non Torregiani o Turrigiano, come si trova negli atti processuali e nei giornali dell'epoca - nacque a Castellammare del Golfo, in via Capraro (oggi via Madonna di Fatima), il 20 settembre 1841, da Vincenzo, di condizione villico, e da Anna Mancuso (AST, Registro degli atti di nascita del Comune di Castellammare, 1841, voI. 25, atto n. 246). Renitente alla leva del '41, Pasquale si rese latitante fin dai giorni della rivolta del gennaio 1862, organizzando in seguito con altri renitenti e disertori una banda che durò sino alla fine del 1869. Fu ucciso in via Ferrantelli, a Castellammare, nella notte del lo marzo 1870, mentre tentava di sfuggire all'assedio di carabinieri e militi. Su di lui scrissero, tra gli altri, i periodici trapanesi «Esopo», suppl. al n. 9 del 12 marzo 1870, e «L'Imparziale», 6 e 13 marzo 1870. Testimonianze sulla sua vicenda brigantesca riportano G. NICOTRI, Mafia e brigantaggio in Sicilia, in «La Scuola Positiva», Roma, a. X (1900), febbraio, n. 2, pp. 75-76; e L. CUIDERA, Vivai criminali in Sicilia, I, Castellammare del Golfo, Palermo 1903, pp. 31-33.
La morale popolare, cui riusci emblematico il caso di un uomo che non poteva difendersi dalle accuse per il suo stato d'illegalità, non ritenne rilevante per il giudizio di favore espresso nei suoi confronti il riconosceme gli specifici carichi di colpevolezza: al contrario del formalismo giuridico, che si preoccupò di vagliare prove e circostanze dell'attività criminosa del capobrigante, col solo risultato di offrire ora a chi rilegge gli atti delle istruttorie l'occasione di assolvere Turriciano dall'accusa di essere stato un volgare delinquente e di collocarlo, invece, tra gli ultimi briganti/eroi della storia siciliana3.
3 Gli atti del voluminoso processo contro i componenti la banda Turriciano, e i suoi numerosi complici e manutengoli, comprendenti i 160 fascicoli delle istruttorie, si conservano in AST, nel fondo dei Processi penali della Corte d'Assise di Trapani (buste 1/5).
Pasquale era nato il 20 settembre 1841 in una povera casa alla periferia di Castellammare, nel quartiere delle Vignazze, da Vincenzo, enfiteuta di un piccolo appezzamento di terreno e, nello stesso tempo, bracciante a giornata. Aveva rifiutato di farsi arruolare nelle prime leve nei ranghi dell'esercito italiano, unendosi agli altri numerosi giovani che non avevano corrisposto agli obblighi della legge di coscrizione, rendendosi perciò renitenti o disertori. Probabilmente fece anche parte di quella nutrita schiera di rivoltosi che invase l'abitato di Castellammare nei primi tre giorni del '62, partecipando in seguito agli episodi di resistenza armata contro le truppe del generale Govone (giugnosettembre 1863).
Le ragioni sociali della sua protesta spiegano la solidarietà dei contadini. La generosità, il coraggio, lo sprezzo del pericolo suscitarono nel popolo sentimenti di ammirato compiacimento, misti a pietà per la sua sorte; le vaghe risonanze cavalleresche del suo comportamento (senso feudale della giustizia, onore e lealismo) formarono quell'alone leggendario che ne circondò sempre la figura e le imprese.
La cultura locale, poi, che per Castellammare si esplica prevalentemente in abbozzi, piu o meno riusciti, d'indagine sociologica (Cuidera, Nicotri), ha tramandato un'immagine del capo brigante sostanzialmente benevola, seppure non immune da una certa idealizzazione cavalleresca del personaggio. (Nel lavoro di Nicotri i ricordi su Turriciano sono forse piu concreti e veri, sia per lo sfondo storico, di segno marxista, della sua ricostruzione, sia perché i ricordi medesimi furono attinti direttamente dal padre, che era stato, come milite della guardia nazionale, tra i testimoni ed agonisti della lotta contro il brigantaggio.) Comunque, tali testimonianze, riscontrabili quasi alla lettera negli atti del processo, costituiscono di per sé materia di storia, in quanto almeno hanno contribuito a tramandare residui non inerti del mito popolare, esso stesso documento delle idealità e dei sentimenti che vi vono nella storia.
Leonardo Cuidera: «Tratto alla latitanza dall'orrore che i Siciliani ebbero per le prime leve, questo giovane, che fu poi il terrore delle campagne, prese parte alla reazione del 1862, che infieriva nel suo paese nativo. Ma, sedata questa, fu costretto a fuggire, si diede alla montagna, e di qui comincia la lunga serie degli omicidi e delle rapine. La sua anima è degna di studio. Nutri sempre un profondo affetto per la madre e cercava di consolarla quando la rivedeva nelle sue frequenti visite in città, non nascondendosi la sua fine. Rifuggi dai sequestri ed ebbe sempre un tal quale senso di giustizia primitiva, consistente nella pena del taglione. Assieme a pochi compagni, non esitò a sfidare, con coraggio davvero marziale, sino a duecento e piu tra soldati e carabinieri. Mori eroicamente nel marzo 1870. Scovato nel sotterraneo di una casa, dentro l'abitato medesimo, forse tradito da una donna che gli fece da spia, egli, nel pericolo, si diede a tirar colpi di fucile e s'apri un varco tra le numerose guardie e tra i carabinieri. Ma nell'oscurità della notte, agguantato mentre stava per liberarsi dalla forza pubblica, alla quale aveva arrecato gravi perdite, cadde, difendendosi come poteva, fino all'ultimo respiro»4.
4 Cfr. L. CUIDERA, Vivai criminali, pp. 31-32.
Gaspare Nicotri: «Una volta fu snidato da una casa campestre presso il monte Sparagio; uno dei militi a cavallo uccise il manutengolo che era inerme e non avea opposto alcuna resistenza. Dopo pochi giorni il Torregiano si recò da Pasquale Calvi, presidente della Cassazione di Firenze, che trovavasi a villeggiare a Guidaloca presso Castellammare, ed, esposto il caso avvenuto, propone al magistrato il quesito se la forza pubblica potesse sparare ad un libero cittadino, inerme, che non oppone alcuna resistenza. Il Calvi, elettissima mente siciliana, risponde evidentemente no. In un conflitto, avvenuto di li a poco tra Torregiano e circa duecento soldati e un nugolo di carabinieri, dove seppe con Il uomini tener fronte e far ritirare quel numeroso drappello, riusci a prendere prigionieri otto soldati ed un carabiniere. Allora, istruito un processo con rito sommario in compagnia dei suoi, ordina ai soldati di fucilare il carabiniere. Dice poi ai soldati: "Andate e riferite al vostro comandante che Torregiano, all'assassinio di un libero cittadino inerme, risponde con la/ucilazione di un birro" «...». Un'altra volta, avendo saputo che un ricco signore di Castellammare avea abusato della sua amante, per vendicarsi si reca nella campagna di quel ricco signore, ed in mezzo ad un gran numero di persone si piglia una sorella nubile di quel signore, malgrado le offerte copiosissime di denaro pur di lasciare la ragazza. Dopo otto giorni accompagna la ragazza dal fratello, dinanzi a lui la bacia ed esclama: 'Torregiano paga della stessa moneta"»5.
5 Cfr. G. NICOTRI, Mafia e brigantaggio, pp. 75-76.
Le risonanze eroiche del personaggio durarono ben oltre la memoria dei contemporanei, raggiungendo persino le sfere ufficiali dell'apparato statale impegnato in tempi ricorrenti nell'azione contro la mafia e il brigantaggio. Se ne ricordò, per esempio, il prefetto Cesare Mori quando ricostrui per la storia dell'antimafia in periodo fascista le fasi della sua lotta «ai ferri corti» contro la malavita isolana. Per lui, nessuno dei famosi banditi delle Madonie aveva eguagliato le doti di coraggio del brigante Turriciano6. Del resto, i giornali che nel marzo del 1870 avevano dato notizia della sua morte non risparmiarono parole di ammirazione nei riguardi di chi aveva dimostrato «grande acume di mente e non comune ardimento»: «Che se noi seguiamo i suoi passi dal giorno che maligne insinuazioni e forse rispettosa sommissione all'influenza sociale di qualcuno lo indussero a farsi renitente alla leva, fino all'ultimo momento della sua vita, noi non possiamo che compiangere le circostanze che svilupparono un genio il quale, altrimenti applicato, avrebbe potuto grandemente giovare a se stesso ed alla patria»7.
6 «Si ricordava che in altri tempi il bandito Torrigiami, accerchiato dalla forza, si era prima gagliardamente battuto, poi, anziché arrendersi, si era ucciso». Si pensava, quindi, che i briganti siciliani ai quali si dava la caccia nelle frequenti operazioni di polizia organizzate, tra il 1916 e il 1926, da Mori, fossero «della stessa tempra». «Ma è inutile: quanto piu tali uomini sono feroci, tanto piu sono vili» (cfr. C. MORI, Con la mafia ai ferri corti, Verona (A. Mondadori) 1932, pp. 225-26). Christopher Duggan ha di recente ricostruito le fasi dell'operazione Mori in Sicilia (La mafia durante il fascismo, Soveria Mannelli 1986), soffermandosi sulla campagna nelle Madonie, considerata come il banco di prova della credibilità antimafiosa del regime fascista.
7 Cfr. «L'Imparziale», Trapani, 13 marzo 1870.
La figura fisica del capobrigante esce nettamente dagli atti delle istruttorie. Di corporatura piccola e snella (era alto m l,57); la fronte alta; gli occhi cerulei; di color castagno i capelli e la barba sul viso largo e pallido. I testimoni lo descrivono vestito, d'inverno, con uno scapolare di panno color marrone o bleu, e sulla testa una scazzetta «con fiocco nero alla mafiosa». D'estate, vestiva invece «calzonetti di tela bianca con calzette bianche di fuori, camicia pure bianca e cappello di palma selvatica»8. L'agilità, davvero eccezionale, che dimostrava di possedere nei momenti di pericolo è ricordata dalle fonti. Un episodio quasi incredibile di destrezza stupi i militi che credevano di averlo già catturato: «Il brigante, vedutosi perduto del tutto, non trovò altra risorsa che quella di buttarsi dalla montagna in un terreno sottostante, senza mica considerare che trattavasi di un'altezza di circa sedici metri»9. Continuò a fuggire, a voltarsi e a sparare sugli inseguitori.
8 Connotati e testimonianze in AST, Corte d'Assise, Processi penali, b. l, fase. 5, 13; b. 2, fase. 22; b. 3, fase. 46-47, 67, 71; b. 4, fase. 88.
9 [vi, b. 4, fase. 96. Quel tratto fisico era ben figurato nel soprannome di Turriciano: 'u attu (il gatto). Come scrive Ernesto De Martino «i soprannomi contadini condensano nel giro di un'immagine un episodio saliente della biografia personale o un tratto fisico o un aspetto del carattere, e per questa loro risoluzione fantastica dei fatti dell'esistenza sfiorano talora la poesia» (cfr. E. DE MARTINO, Mondo popolare e magia in Lucania, RomaMatera 1975, p. 121). Quasi tutti (imputati e vittime) trovavano cosi vera identità dinanzi alla legge coi loro soprannomi, che accompagnavano dati anagrafi ci spesso persino ignorati dal pubblico.
Il mito del brigante/eroe cosi ritrovava nel giovane contadino renitente alla leva gli antichi valori della protesta sociale e le forme della simbologia popolare. Quel mito, sorto in epoca moderna10, sembrava però avviato al tramonto, mentre ormai si spegneVano gli ultimi riverberi feudali e il mito della roba, propiziato dai riti oscuri della violenza mafiosa, soppiantava il sentimento cavalleresco della giustizia e della carità verso il povero. Il caso del bandito di Castellammare costituisce per ciò stesso una singolare sopravvivenza di mentalità che la formazione e lo sviluppo dei nuovi interessi borghesi mettono ancor piu in risalto. Oltre che per le particolarità eroiche di un tale banditismo, l'episodio appare degno di attenzione per certe relazioni che intercorsero tra l'insurrezione palermitana del settembre 1866 e il tentativo del capobrigante di organizzare nelle campagne la guerriglia in appoggio ai ribelli dell'ex capitale dell'isola. Tuttavia gli aspetti davvero illuminanti delle influenze che i gruppi di mafia esercitarono sul banditismo sociale sono quelli che meglio chiariscono la fase di trapasso dal ribellismo individuale alla pratica mafiosa di sfruttamento economico e di violenza parassitaria.
10 Per l'età moderna, oltre ai ben noti lavori sul banditismo sociale di Eric J. Hobsbawm (Primitive Rebels, 1959; Bandits, 1969), pubblicati in Italia da Einaudi, si vedano per i riferimenti al fenomeno siciliano E. D'ALESSANDRO, Brigantaggio e mafia in Sicilia, Messina-Firenze 1959, e S.F. ROMANO, Storia della mafia, Milano 1963. Recente è la ricostruzione storica del banditismo armato nella Sicilia risorgimentale compiuta da G. FIUME, Le bande armate in Sicilia (1819-1849). Violenza e organizzazione del potere, Palermo 1984.
|
|

|