
Salvatore Costanza

la copertina
© Copyright 1989
Arti Grafiche Corrao
via Valenza, 31
Trapani
Finito di stampare
nel settembre 1989
Ringrazio l'amico
Vito Accardo
per avermi portato
alla conoscenza
di questo libro
Questa ricerca storica riproduce, con ampliamenti e integrazioni, l'omonimo studio pubblicato nel fascicolo speciale dei «Nuovi quaderni del meridione» dedicato alla rivoluzione palermitana del settembre 1866 (n. 16, ottobre/dicembre 1966, pp. 419-38).
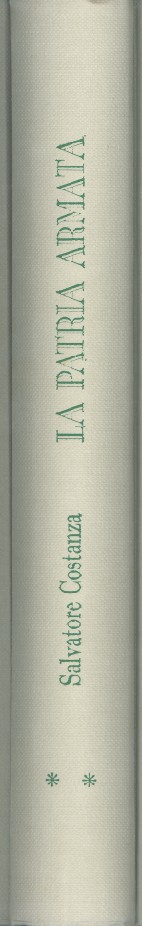
|

|
|
Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
|
LA PATRIA ARMATA di Salvatore Costanza
|
LA RIVOLTA CONTRO I «CUTRARA»
(Castellammare del Golfo, 1/3 gennaio 1862)
10. La repressione. Esercito, Giustizia e «guardaspalle»
Ripristinato l'ordine, si procedette al disarmo della popolazione e all'arresto di quanti erano sospettati di avere partecipato alla sommossa. Il giudice Milone398, che istmi il processo, poté rinviare a giudizio 112 imputati, dei quali 25 erano ancora latitanti nel '64, anno in cui la Corte d'Assise di Trapani ne condannò cinque alla pena di morte, 24 ai lavori forzati a vita ed altri 35 a pene minori, «per avere attentato alla forma del governo, suscitata la guerra civile, portata la devastazione, la strage ed il saccheggio nel Comune di Castellammare contro la classe delle persone liberali»399. Il resto degli accusati venne assolto. Per i condannati a morte, la sentenza non fu mai eseguita, perché la pena fu commutata due anni dopo nei lavori forzati a vita400.
398 Sul giudice istruttore barone Emanuele Milone, i documenti d'archivio forniscono qualche cenno significativo. Giudice regio in Monte S. Giuliano, dal 1843 al 1848, fu tra gli organizzatori dell'insurrezione del' 48, sedendo quindi alla Camera dei Pari. Durante la sua permanenza nell'ufficio di giudice regio «tenne una condotta irregolarissima, se non vuoI dirsi scandalosa su tutte le vedute. Garante di tutti gli assassini, in diverse volte arrivò al segno di cambiare gli oggetti furtivi repertati, per cosi, posti al confronto, far svanire la prova del furto» (cfr. nota informativa trasmessa dal sindaco di Monte S. Giuliano, Salvatore Luppino, all'intendente di Trapani, 31 gennaio 1850, in AST, FI, Polizia, Corrispondenza (1849-53). Piu tardi inviò una supplica al prefetto di polizia in Palermo, chiedendo di essere reintegrato nel suo ufficio (ivi. Affari diversi, nota del 13 gennaio 1855).
399 Il dispositivo della sentenza di rinvio a giudizio dei 112 imputati cosi aveva configurato i gravi reati di sollevazione e strage e, per alcuni, di sobillazione della massa dei rivoltosi: «Attentato allo scopo di cambiare e distruggere la forma del Governo, di suscitare la guerra civile tra regnicoli, e di portare la devastazione, la strage ed il saccheggio in un Comune dello Stato e contro una classe di persone, avendo nei primi tre giorni di gennaio 1862 di concerto e complicità tra loro attaccata la forza pubblica, proceduto a stragi e saccheggi, spodestate le autorità locali di Castellammare, e consumati quegli atti di esecuzione che costituiscono il reato previsto dagli art. 156 e 157 del Codice Penale vigente» (v. in AST, Corte d'Assise, Sentenze, 1864, vol. 2, n. 58).
400 Ivi, n. 58 (IO agosto 1864) e n. 67 (27 agosto 1864). Il dibattimento si svolse in due tempi, perché i 12 imputati latitanti (tra i quali era il notaio Di Blasi) furono giudicati a parte. Si apri il lo giugno del '64 e si concluse dopo quasi tre mesi. Inizialmente il processo fu istruito contro 146 individui, ma 33 di essi furono prosciolti in istruttoria (alcuni popolani e i possidenti Francesco Briguccia, Giovanni Buffa, Pietro Costamante, Gaetano, Giuseppe e Nicolò D'Anna) e uno mori in carcere. La corte d'assise, presieduta da Achille La Manna, mandò assolti altri 42 imputati (tra essi il borgese Gaspare Ganci, due delle tre donne arrestate e i civili Giovanni Gervasi, Francesco Plaja Coniglio e Giovanni Sangiorgio). Gli altri furono condannati a pesanti pene detentive (17 ai lavori forzati a vita). In seguito all'amnistia del 31 gennaio 1867, venti imputati (tra i quali i due Ferrantelli, Francesco e Sebastiano, intesi scarpetta, il notaio Mariano Lombardo e il mascàru Vincenzo Chiofalo) ebbero condonata la pena. Altri condoni vennero coi decreti del 31 agosto 1871 (in favore di Gioacchino Borruso, che fu scarcerato), 8 e 30 giugno 1872 (in favore di Giuseppe Fiordilino e del dr. Giovanni Marcantonio Coniglio). Nel secondo processo, si ebbero altre sette condanne ai lavori forzati a vita e una pena di morte. Per i condannati a morte, la commutazione della pena sopravvenne con DR del 31 ottobre 1866.
Nei confronti di Andrea Di Blasi, il quale era però riuscito a sottrarsi alla cattura, fu avviato un procedimento a parte, che si concluse nell'agosto del '64 con la sua condanna alla pena della decapitazione401. Però otto anni dopo un'altra sentenza della Corte d'Assise di Trapani lo mandava assolto da ogni imputazione402, revocando cosi le basi stesse delle accuse mosse in prima istanza contro gli ex legittimisti.
401 Di Blasi era accusato quale mandante dell'assassinio di Bartolomeo e Girolamo Asaro, oltre che di essere stato «il principale fabbro e motore di quegli atti di esecuzione diretti a distruggere la forma del Governo». Il tribunale pensò anche che lo stesso avesse «preparato e concertato» i fatti che sarebbero accaduti, apprestandone i «mezzi di esecuzione» (cfr. ivi, vol. 2, processo n. 67,-27 agosto 1864).
402 Ivi, vol. lO, processo n. 63 (6 luglio 1872).
Nel corso delle udienze, si rese manifesto su quali influenze la mafia potesse ormai contare per imporsi sull'ambiente. Si approfittò, anzi, del processo per estendere tali influenze sui numerosi giudicabili, in cambio dell'impunità promessa. Figure centrali nelle vicende di quei giorni furono ancora una volta i piti noti capimafia del paese: Gioacchino Ferrantelli, Antonio, Camillo e Damiano Buffa, Stefano Barone, Giuseppe Buccellato, nonché i fratelli Cosmo e Pietro Lombardo, quest'ultimo scelto a garantire il ritorno alla pace sociale. La mafia castellammare se, che, secondo il giornale «Diritto e Dovere», si sarebbe impegnata nella rivolta del '62 coi suoi «piti fidi guardacorpo», si avvalse quindi dei legami da essa stretti col potere costituito per coprire le responsabilità di quanti furono implicati nel processo. I numerosi testimoni (venti di essi dovettero essere arrestati per reticenza)403 cercarono, del resto, di provare gli alibi forniti dagli accusati, «e specialmente Pietro Lombardo, il quale scelto a capo della sollevata plebaglia, non conobbe quasi che i morti e tentò discolpare i vivi che non poté negare di aver conosciuto»404. Cosi anche gli altri testimoni di «rispetto» sono piti o meno esplicitamente indicati dal «Diritto e Dovere» come coloro che provvidero a rilasciare in favore di molti imputati (campieri o semplici villici) le necessarie «garenzie» onde provare la loro estraneità ai fatti405.
403 AST, Corte d'Assise, Verbali, vol. 8 (giugno/agosto 1864).
404 «Diritto e Dovere», n. 29 del 4 agosto 1864. I testimoni ascoltati durante il processo furono 258 a carico e 613 a discolpa. Tra questi ultimi i Buffa (padre e figli), Antonio e Gioacchino Ferrantelli (a favore di 7 imputati), nonché Pietro Lombardo (ivi).
405 «Diritto e Dovere», n. 38 dell'Il ottobre 1864.
Le pressioni e le minacce non bastarono, forse, a convincere tutti.
Qualcuno non volle consentire alla severa consegna omertosa, e si lasciò fuorviare da imprudenti ammissioni di colpevolezza nei confronti di alcuni giudicabili: fu perciò eliminato, poco dopo aver reso la propria testimonianza in tribunale406. Comunque un po' tutti rispettarono la consegna del silenzio, soccorrendolo semmai con quegli adombramenti gestuali, con quelle sfumature di linguaggio - riducibili pur sempre all'essenza di un mondo eternamente sospeso al limite del sospetto - che ora non possono più ritrovarsi nella cifra cancelleresca dei verbali del processo.
In quel periodo, anche le bande di renitenti e disertori che si aggiravano per le campagne si legarono in vari modi alla mafia, a causa dello stato di latitanza in cui quei giovani erano costretti a vivere. Scontri a fuoco tra le bande e la forza pubblica avvennero nel '63, prima dell'inizio della repressione militare del Govone407. Il generale piemontese, che guidò dal giugno al settembre 1863 la spedizione incaricata di reprimere il brigantaggio e la renitenza alla leva in Sicilia, ricorderà in seguito alla Camera l'azione da lui compiuta nel circondario di Alcamo: «Nella provincia di Trapani vi sono due grossi Comuni che erano supremamente infestati: Alcamo, capoluogo di circondario, e Castellammare. A Castellammare dopo la reazione provocata da odii di parte nel 1862 e macchiata di eccidì e di incendi gravissimi, esistevano ancora latitanti da sessanta individui compromessi e sotto mandato di cattura.
406 Luigi Ancona venne strangolato nel carcere; i borgesi Francesco Lo Piccolo e Vito Messina furono uccisi da ignoti nelle campagne di Baida (ivi, n. 25 del 4 luglio 1864; gli atti di morte in AST, Registro cit., alla data del I o luglio 1864: n. 126 per Francesco Lo Piccolo fu Vincenzo, di anni 57, e n. 127 per Vito Messina fu Natale, di anni 36). A questi assassinii (ma limitandone il numero, contro le cifre esagerate che erano state fornite poco prima dal deputato Castagnola) accennò Giuseppe Borruso in un suo intervento alla Camera: «Quanto poi alle vendette che si sono esercitate contro i testimoni a cui accennava l'onorevole Castagnola, è pur vero che qualche vendetta si esercitò, ma la cosa limitossi a pochi casi isolati, sono stati quattro o cinque fatti, e non delle centinaia, come è stato asserito. E questi quattro o cinque fatti furono possibili solo perché dagli avanzi di quella reazione sorse una banda capitanata da un certo Turriciano, che si rese padrone di quasi tutta quella provincia, saccheggiando a suo modo la campagna, o minacciando d'invadere financo i comuni» (cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Sessione del 1874-75, Discussioni, tornata del 13 giugno 1875, p. 4197).
407 Il generale Govone ricordò alla Camera che «a Castellammare una banda di malviventi e renitenti resisté ad una compagnia di truppa, la quale ebbe tre soldati uccisi» (ivi, tornata del 5 dicembre 1863, p. 2117). Sui «reati di ribellione» del 24 gennaio e del 16 giugno 1863, v. i Verbali d'Assise del '64, vol. 8. Notizie su uno scontro tra renitenti e carabinieri, accaduto il 7 agosto 1864, in «Diritto e Dovere», n. 31 del 18 agosto 1864.
Piu un trecento renitenti di Castellammare, Alcamo e Monte San Giuliano, che si annidavano su quelle montagne. Questo comune era causa di frequenti allarmi al Governo. Ricordo parecchi telegrammi spediti da Castellammare al ministro dell'interno, comunicati a quello della guerra e trasmessi a Palermo per segnalare bande di 100 e 200 briganti raccolti sulla montagna che aspettavano altri 300 o 400 compagni, ora da Roma, ora da Malta. Questo comune era insomma in condizioni insopportabili e da due anni i proprietari avevano dovuto abbandonare le loro fertili campagne al contadino. Quando io giunsi a Castellammare venne da me il sindaco e la Giunta e mi dissero di far di loro e del paese ciò ch'io credessi, purché potes~i liberarli una volta da uno stato insoffribile «...» Ho posto un cordone al paese, un cordone di quaranta chilometri in campagna, isolando l'istmo di San Vito, circondando montagne intere. Il medesimo soldato è stato sei giorni e sei notti di sentinella in un pestifero clima, col sole ardente del giorno e coll'umidità della notte, ma è rimasto là perché io voleva assolutamente liberare quel comune. Altri sei giorni furono impiegati a fare perlustrazioni faticosissime in quelle montagne. Non havvi casa che non sia stata perlustrata, non antro, non capanna che non fosse visitata «...» noi abbiamo arrestato un certo numero di malviventi, ma se noi avessimo dovuto arrestarli tutti sarei ancora là»408.
408 Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Sessione del 1863, Discussioni, tornata del 5 dicembre 1863, p. 2119.
Tuttavia nemmeno le misure eccezionali predisposte dal generale Govone valsero in un primo tempo a snidare tutti i fuggiaschi dai loro nascondigli, se fu necessario ricorrere per catturarli all'opera di influenti personalità del luogo. Alla mediazione operata in quella circostanza da Giuseppe Coppola, che fu uno dei piu prestigiosi capisquadra dei picciotti nell'aprile/maggio 1860, si fa riferimento in una sua biografia, redatta con l'ausilio di ricordi familiari e testimonianze d'archivio. «Nel 1862 - scrive, infatti, il biografo di Coppola - una reazione scoppiò in Castellammare del Golfo. I facinorosi, uniti a' renitenti di leva, scorrazzavano per le montagne della provincia di Trapani. Il governo dovette ricorrere a leggi eccezionali. Con numerosa soldatesca, il Generale Govone fu incaricato d'assicurare alla Giustizia que' pericolosi refrattari; ma non vi poté riuscire. Il Prefetto di Trapani chiamò il Cav. Coppola alla presenza del Generale predetto, scongiurandolo di prestare l'opera sua per il bene della Patria, cooperandosi a far presentare i latitanti. Per un momento il Cav. Coppola restò indeciso; assicurato poi dell'impunità de' renitenti, per amore dell'ordine e per servire la Patria, accettò l'incarico. Volle che la truppa si ritirasse da quei luoghi; e con l'autorità che gli veniva dalle imprese compiute, e per la stima che godeva presso quei di Castellammare, dopo pochi giorni ebbe il contento di presentare alla Giustizia facinorosi e renitenti. I quali, accompagnati dalla banda musicale, entrarono nella città di Trapani, non senza meraviglia del Prefetto e del Generale»409.
L'episodio si commenta da sé. C'è tuttavia da osservare che, se Coppola riusciva ad avere tanto prestigio in mezzo a «facinorosi» e renitenti alla leva, ciò non poteva derivare soltanto dalle benemerenze patriottiche acquisite nel corso della sua coerente attività antiborbonica. La considerazione in cui egli era tenuto poteva ben manifestarsi in virtli dei suoi recenti legami coi picciotti delle squadre, ma che pur qualcosa dovevano contare negli ambienti della mafia locale410.
Le operazioni militari per l'arresto di renitenti e disertori furono condotte dal generale Govone con sistemi repressivi, adoperati forse a sostegno del pregiudizio che la Sicilia non fosse ancora uscita «dal ciclo che percorrono tutte le nazioni dalla barbarie alla civiltà», come dichiarò lo stesso Govone alla Camera, giustificando il suo operato411.
409 Cfr. B. LA ROCCA, Giuseppe Coppola, Trapani 1921, p. 15. L'episodio è pure ricordato da V.A. AMICO, Cronistoria ericina dal 1848 al 1860, Palermo 1910, p. 41.
410 Non mi sembra però di poter affermare che «l'autorità indiscussa ed in discutibile» di Giuseppe Coppola fosse generata «dal fatto di essere qualcuno nel classico ambiente della tradizionale mafia». L'osservazione di uno studioso ericino, che si è soffermato sul significato di tale episodio (v. v. ADRAGNA, Spirito pubblico e correnti di opinione in Erice nel primo biennio dell'Unità, in 1862. La prima crisi dello Stato unitario, a cura di G. Di Stefano, Trapani 1966, pp. 12-13), andrebbe quindi corretta nel senso di scorgere nell'intervento del patriota una prova del rapporto organico che si era frattanto stabilito tra la classe dirigente locale e la mafia. Una prova di collusione, che non era necessariamente una prova d'identità.
411 Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Sessione del 1863, Discussioni, tornata del 5 dicembre 1863, p. 2122. Denis Mack Smith (Storia della Sicilia medievale e moderna, Bari 1970, p. 611) afferma che «alcuni siciliani in privato erano disposti ad ammettere che forse egli aveva ragione». Come lo scrittore inglese abbia avuto notizia di tali privati sentimenti non è però detto. Quei siciliani - pare di poter capire -, che pure erano «disposti» a dichiarare la loro solidarietà col generale piemontese, ovviamente non furono mai in grado di farlo, per volontà propria o pressione altrui, in modo esplicito.
Una frase certamente ingiusta, o almeno equivoca, che trovò facile ritorsione nelle parole pronunciate durante il dibattito parlamentare che ne segui da Filippo Cordova, secondo il quale «l'idea di civiltà era un'idea troppo civile per poter essere militare»412.
Il giudizio di Govone provocò ovunque nell'isola vivaci e sdegnate proteste, che coinvolsero un po' tutti i settori dello schieramento politico, prestando nuove occasioni alla polemica degli autonomisti contro il piemontesismo. Si cercò pure di ridurre di fronte all'opinione pubblica nazionale l'entità del fenomeno dei renitenti e disertori. (E, in effetti, per errore erano stati compresi nelle liste molti nomi inesistenti, o di gente impedita da legittimi motivi). Difendendo comunque i sentimenti patriottici e unitari del popolo siciliano, non si chiarivano altresi le cause che avevano provocato la renitenza di massa. Che poi il fenomeno fosse radicato in certi ambienti contadini era dimostrato dal suo riprodursi, in forme endemiche, anche negli anni successivi alla repressione di Govone413.
Fu poi il carattere ambivalente della renitenza di massa - di rottura con gli organi del potere legale, ma al tempo stesso di soggezione a chi era in grado di coprime i movimenti - che consenti in quella occasione alla mafia di accrescere i suoi quadri di manovra. L'intervento di influenti personaggi, come l'ex caposquadra garibaldino Coppola, per la consegna dei renitenti e per la loro impunità rivelava intanto l'accresciuta autorità che poteva essere esercitata su quei giovani414.
412 Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Sessione del 1863, Discussioni, tornata del 9 dicembre 1863, p. 2185.
413 Secondo le cifre fornite dal ministro della guerra, nella provincia di Trapani, alla fine del '63, erano stati arrestati 938 renitenti e disertori, e 379 malviventi, mentre altri 607 individui si erano resi irreperibili (ivi, tornata del 5 dicembre 1865, p. 2114). Due anni dopo, su un totale di 1019 ricercati (646 renitenti, 116 disertori e 257 malviventi), gli arrestati saranno 526, mentre 300 individui risulteranno sconosciuti, o emigrati all'estero (v. «La Concordia», n. 10 del 5 dicembre 1865).
414 Al graduale inserimento dei renitenti e disertori nelle file della malvivenza accenna anche Uberto Govone riportando le testimonianze del padre: «Inoffensivi < ... > da prima e, in parte almeno, forse anche in seguito, essi però già in parte, per forza di cose, giungevano al reato. Ricercati e costretti spesso a gettarsi nella campagna, riuniti in bande, posti a contatto coi veri e propri malfattori, obbligati a sostentarsi come che sia, essi venivano a costituire una specie di riserva per i malviventi. E i fatti denunciati allora dalle autorità e dalla stampa provavano che nessun reato si commetteva ormai senza che vi partecipassero i renitenti. Cominciavano anche da parte loro la caccia al carabiniere, le aggressioni e gli omicidi. Essi stavano insomma discendendo la china dalla renitenza alla latitanza e da questa al delitto» (cfr. u. GOVONE, Il Generale Giuseppe Govone, p. 150).
«L'ostinazione a non aiutare le ricerche della forza pubblica sale qui all'eroismo», scriveva Govone; ma alla «virtu» del silenzio omertoso, come egli stesso definiva il sacrificio reso dai testimoni al timore di dover subire soprusi e vendette, corrispondeva il tornaconto di chi sfruttava le circostanze al fine del profitto personale. Il generale piemontese, del resto, suggeriva al ministro Peruzzi, in un suo rapporto del lO giugno 1863, di deferire ai tribunali militari quei proprietari che avevano alloro servizio i renitenti, «scontando il rischio con fa1cidiare il salario»415.
415 Ivi, p. 155.
Tuttavia gli atti energici usati da Govone conseguirono il risultato di ridurre, almeno per quell'anno, il numero dei latitanti. Effetti contrastanti si ebbero invece sul piano politico-sociale. Se, da un lato, cominciò a penetrare tra i Siciliani una certa favorevole opinione verso l'autorità della Legge, attraverso la credibilità che la forza militare era riuscita in qualche modo a conseguire, dall'altro, però, si accrebbe la forza del nuovo potere informale costituito dalla mafia e dai suoi numerosi tentacoli. Il governo mostrò, infatti, di non avere le idee sufficientemente chiare sulla situazione locale; o almeno di non dar peso alle preoccupazioni manifestate in tal senso dai piu accorti dei suoi funzionari e ufficiali dell'esercito (tra i quali certamente era il generale Govone). La noncuranza di fronte alle cause strutturali del malessere sociale del paese (non perciò riconducibili alla semplice agitazione politica di borbonici e sinistra democratica) fini per coinvolgerlo nelle responsabilità della crescente «opposizione mafiosa», che non manovrava al di fuori delle istituzioni, ma dentro di esse.
L'episodio, cui si è accennato, dell'intervento di un patriota prestigioso, come Coppola, a far da tramite fra il governo legale e quanti erano sfuggiti agli obblighi di leva, coperti dalla solidarietà degli ambienti di mafia, è abbastanza dilucidativo di una realtà sotterranea che si era frattanto formata e che sfuggiva alle logiche desuete della politica. Che il suo fosse «rispetto» dovuto, ovvero prestigio che gli veniva riconosciuto in certi ambienti per la sua popolarità soprattutto tra i contadini, è questione, in fondo, irrilevante. Sta di fatto che egli non si limitò ad esercitare le sue mediazioni soltanto a difesa dello Stato e delle sue leggi, ma pure a vantaggio di personaggi piuttosto equivoci in circostanze nelle quali ci riesce difficile riconoscere un nobile intento patriottico.
Ho trovato tra le carte del canonico Amico conservate nella biblioteca comunale di Erice una lettera di Andrea Di Blasi, indirizzata a Giuseppe Coppola, che attesta il ruolo determinante svolto dallo stesso Coppola in favore del notaro di Castellammare, accusato dai giudici di essere stato a capo della sanguinosa rivolta del gennaio 1862 e in un primo tempo condannato per il reato di sovversione e strage alla pena di morte. La protezione di Coppola nei riguardi di un uomo tanto in viso ai liberali, ricordata nella lettera a memoria di perenne gratitudine, fu tale da farIo mandare assolto nella causa di appello. È da supporre che i legami tra i due si fossero da lungo tempo saldati in virtu d'interessi sostanziali e che la «mistificazione» politica praticata su campi opposti non potesse perciò intaccare le regole del «partito» degli uomini d'onore. Ed ecco la lettera:
Castell.re del Golfo 13 Luglio 1872
Imparagiabile Amico,
Il mio arrivo in questa fu inosservato, conforme io aveva disposto: nessuno incontro, nessuna dimostrazione esterna.
Ciò però non ha potuto impedire che tutti gli amici, tutta la popolazione non avessero espressato tutta la gioja facendo a gara per visitarmi in mia casa: ta1ché per 4 giorni consecutivi non mi han dato tempo a poter uscire dalla mia abitazione.
La luce si è fatta, e, sciolta dalle dense nubi in cui era stata travolta, ha fatto sentire piu graditi i suoi splendori!
lo e la mia famiglia vi siam debitori di tutto; e non possiamo che protestarci grati e riconoscenti per tutta la vita.
Vogliatemi sempre del vostro bene; amatemi quanto io vi amo, e mantenetemi sempre sotto l'egida della vostra possente protezione.
Fate gradire alla vostra Signora i miei sentiti ossequi anche per parte della mia famiglia. Ed abbracciando vi con Mariano, credetemi con inalterabile attaccamento.
Dev.mo oblig.mo Servo ed amico vero
Andrea N.r Di Blasi416
416 ASME, Fondo Can. Amico, miscellanea C. 18. Nato a Castellammare da Gaetano e Ninfa Gervasi il 13 marzo 180 l, Andrea Di Blasi sarebbe morto nella sua abitazione di corso Garibaldi, 151 il 29 ottobre 1876 (v. in AST, Registro degli atti di morte, 1876, vol. 55, N. 324).
Una lettera stringata e ammiccante, come si conveniva allo stile di un uomo di rispetto. Essa costituisce solo un frammento del mosaico di fatti e di segrete compromissioni che stava dietro l'agitata vicenda di quegli anni. Potremmo tentare qualche ipotesi; ma la storia, anche quella della mafia che non usa lasciare traccia di testimonianze, deve confidare sulle certezze documentarie. E quindi si può richiamare soltanto a dilucidazione di quei fatti l'analisi (del resto assai perspicua) del fenomeno mafioso che un giornale trapanese tracciò nell'autunno del '64 quando si era da poco concluso dinanzi alla Corte d'Assise di Trapani il processo contro i ribelli di Castellammare.
Il giornale ospitò una corrispondenza da Alcamo, dove le imprese della camorra (ossia di quelle coalizioni della violenza privata che, ancora, non avevano trovato una propria espressione nel termine mafia) erano riportate all'essenza e alle specifiche causalità di un nuovo potere extralegale, intermesso tra la malavita e il «braccio della giustizia». L'anonimo corrispondente cominciava col ricordare che da quasi un anno la sicurezza interna sembrava ormai rassodata, probabilmente per l'adozione delle misure restrittive disposte dalla legge Piea, «un mezzo piu pratico di tutte le filosofie de' dottrinari a rendere meno audace la bassa forza dell'esercito malandrinesco». Se non che, superata l'emergenza degl'interventi militari con la repressione del '63, si erano manifestati negli ultimi tempi episodi «inquietanti e di sinistro augurio». Ora non serviva piu denunziare semplicemente la recrudescenza dei misfatti al governo che «ha mancato finora di colpire là dove bisognava risolutamente colpire», ma cercare di scoprire ciò che stava alla radice del fenomeno: «Tutti costatano che il male sia la camorra; ma nessuno si cura di farne la diagnosi, di segnalarne la causa. Per salire all'origine di questo male bisogna per un momento riportarci ai luttuosi fatti di Castellammare. Fino da quel tempo gli uomini nuovi dovettero cedere, per motivi che qui non occorre ricordare, agli assalti degli uomini del passato, i quali ben presto invasero il campo e prevalsero: fu una restaurazione, su per giu, ad uso '49. Quindi armeggiare di retrivi e clericali, baldanza di tristi e sbigottimento degli onesti. Quelli poi che viemmargiormente si avvantaggiarono di tale incredibile trasformazione furono i manutengoli e i protettori. A niuno è ignoto che costoro anche sotto i Borboni, tolti i nuovi soci di piu recente data, si dilettavano di aver comunella coi ladri e gli assassini, di mettersi tra essi e il braccio della giustizia, di organizzare le loro imprese, e nasconderli quando perseguitati; di modo che quel governo immorale, prima di promuoverli e affidare nelle loro sperimentate mani la polizia, ad essi rivolgeva le sue dimande per avere consegnato qualche famoso ribaldo, se non avessero voluto essi stessi andare in gattabuia».
I misfatti avvenuti tra l'autunno del '62 e l'autunno del '63 nel circondario di Alcamo avevano già denunciato all'opinione pubblica, per il loro carattere di efferatezza, le cause specifiche del fenomeno criminale che si era manifestato, da imputare alla «fetel}tissima piaga della camorra», organizzata da una «combriccola» forte di «appoggi ed eccitamento» da parte di manutengoli e protettori. Da qui l'invito del giornale al governo a non curarsi dei soli «effetti», ma a «togliere sin dalle radici la cancrena della camorra» se si voleva assicurare al paese ordine e giustizia417.
Dopo averne seguito nel corso della ricostruzione dei «casi» di Castellammare le azioni d'irretimento nei confronti del potere politico-amministrativo e giudiziario, e i tentativi, piu o meno riusciti, d'innesto nella realtà tumultuaria della renitenza di massa, non è difficile capire quale sia stata la forza di pressione esercitata dai gruppi mafiosi sulla società locale418. È però piu difficile comprenderne l'effettivo peso economico-sociale senza considerare il coevo fenomeno della formazione del nuovo «blocco agrario», fondato essenzialmente sui modi parassitari di percezione della rendita fondiaria e sullo sfruttamento del lavoro dei contadini.
417 «Diritto e Dovere», n. 38 dell'11 ottobre 1864.
418 Col passare degli anni, i dati delle anomalie criminogene rilevati da Ulloa avrebbero assunto caratteri piu marcati. Gaetano Gionfrida, procuratore del re a Trapani, rilevava, per es., che gl'imputati assolti per insufficienza di prove erano passati, in un decennio, nel suo tribunale dal 16 al 29 per cento (Relazione statistica dei lavori compiuti nella giurisdizione del Tribunale civile e correzionale di Trapani entro l'anno 1885 esposta all'Assemblea Generale del 9 Gennaio 1886, Trapani 1886, p. 32). Auspicava perciò severe misure di repressione: «Perché ora vergiamo ad una proporzione si grande? Signori, dirò schiettamente il mio avviso e credo sia positivo ed esatto. Le influenze della mafia in cilindro e caciotto sventuratamente fra noi sono cresciute e cresciute: fino a quando non calcheremo le cento teste di quest'idra cupi da e superba le assoluzioni supereranno anche il massimo che ora dà la Sardegna» (ivi). L'aumento della criminalità nel circondario alcamese avrebbe anche spinto Gaspare Nicotri ad avanzare la proposta di istituire un nuovo tribunale a servizio dell'amministrazione giudiziaria nello stesso circondario (Per il Tribunale in Alcamo, Palermo 1908). Le relazioni giudizi arie del primo '900 avrebbero, poi, tutte denunciato la centralità mafiosa di Castellammare, «in grazia dell'omertà che consiglia il silenzio, perché non ci dev'essere cascittuni, e del terrore che lo stesso silenzio impone alle vittime, ai parenti delle vittime e a tutti coloro che, sfiduciati di tanta libertà nel malandrinaggio, sono inconsapevoli complici della terribile situazione» (cfr. L. CICALA. L'Amministrazione della giustizia nel circondario di Trapani, Trapani 190 l, p. 15).

Lettera del prefetto Lanza a Giuseppe Coppola per le operazioni di leva (ASME. fondo) Coppola, fasc. 302/15).

Il patriota ericino Giuseppe Coppola (l82l-1902).


Lettera di Andrea Di Blasi a Giuseppe Coppola per ringraziarlo della «protezione» usata nei suoi riguardi (ASME, fondo Amico C. 18).
|
|

|





