
Salvatore Costanza

la copertina
© Copyright 1989
Arti Grafiche Corrao
via Valenza, 31
Trapani
Finito di stampare
nel settembre 1989
Ringrazio l'amico
Vito Accardo
per avermi portato
alla conoscenza
di questo libro
Questa ricerca storica riproduce, con ampliamenti e integrazioni, l'omonimo studio pubblicato nel fascicolo speciale dei «Nuovi quaderni del meridione» dedicato alla rivoluzione palermitana del settembre 1866 (n. 16, ottobre/dicembre 1966, pp. 419-38).
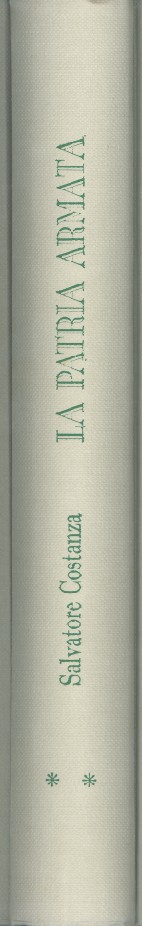
|

|
|
Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
|
LA PATRIA ARMATA di Salvatore Costanza
|
LA RIVOLTA CONTRO I «CUTRARA»
(Castellammare del Golfo, 1/3 gennaio 1862)
8. I fatti del gennaio 1862
L'insurrezione fu decisa per il capodanno del '62. Calcolati inizialmente in circa quattrocento, i ribelli si radunarono nella contrada dei Fraginesi, a nord-ovest dell'abitato, e verso le due del pomeriggio entrarono a Castellammare, preceduti dalla bandiera rossa che poi piantarono su un muro della via maestra. Di li, al grido di «fuori la leva, morte ai cutrara», e di tanto in tanto anche «viva la repubblica», assaltarono le case di alcuni galantuomini333.
333 Calandra, tacendo il grido dei rivoltosi contro i cutrara (concordemente, invece, ricordato dagli altri testimoni al processo), cosi ricostruisce le fasi iniziali della sommossa: «Spuntava il primo gennaro 1862; giorno designato al cannibalesco eccidio. Gli assassini capi, quelli stessi che, mascherati, fingevano con noi amicizia, radunano le vandaliche orde in Curtunaci (contrada dei Fraginesi) ove bivaccarono; danno l'ora agli altri scellerati compagni, e verso le tre p.m. spuntando da destra, e sinistra, andavano ad armarsi, chi mancava di fucile, in una casa sita in bocca della Carrubba che dista da Castellammare meno di un terzo di lega. Poco dopo alzano bandiera rossa, e sotto quella entrano in paese, dalla Santa Croce, sua sommità; piantano nell'estremo muro, che limita il fine della strada maestra, lo stemma della ribellione, ed esordiscono a colpi di fucile, ed al grido di viva la repubblica, abbasso la leva, morte ai liberali; mentre al suono della brogna chiamavano gli altri compagni, che a tutta corsa, ed in gran numero, scendevano dalla strada dei Fraginesi. Accortosi il Delegato D. Gaspare Fundarò della bandiera rossa, e di una folla di armati, si avanza animosamente a far testa col solo appoggio del di lui figlio D. Giuseppe e dei militi a cavallo Baldassare Capelluto, Pietro Franco, Giuseppe Corona, raggiunti poi dal loro compagno Giuseppe Gioia. Ma sopraffatti dal numero maggiore, rimasti miracolosamente in vita, perché le palle fioccavan loro d'intorno, retrocedono per altra via, e si chiudono in casa del sacerdote D. Antonino Zangara cognato al Fundarò. Erano anche sopraggiunti il patriottico giudice signor D. Vincenzo Nicolai, altri liberali, pochi carabinieri; ma visti gli assassini preponderanti, ed in gran numero, il giudice si ritira in casa del sacerdote crocifero D. Pietro Coppola, i cittadini corrono presso le loro famiglie, ed i carabinieri inseguiti sin dentro la loro abitazione, furono poi disarmati dal popolo» (cfr. I casi, pp. 28-29).
Dapprima la folla degl'insorti, che andava man mano ingrossandosi, si diresse verso l'abitazione di Bartolomeo Asaro, commissario di leva, dove in quel momento si trovava pure il comandante della Guardia Nazionale, Francesco Borruso. I due furono pugnalati e, in seguito, trascinati in mezzo alle fiamme. Il pugnale degli assalitori non risparmiò nemmeno la figlia e il genero di Borruso. Si dette poi la caccia agli altri cutrara (Marcantonio, Galante, Zangara e Calandra), saccheggiando le loro case. Nell'abitazione dei Galante venne ucciso uno dei nipoti del sacerdote334. Nel frattempo, però, quasi tutti avevano trovato scampo nelle vicine campagne335.
334 Nei registri parrocchiali della Chiesa Madre di Castellammare (die prima ianuarii 1862 tempore belli) sono espressamente indicati come ab aggressoribus interfecti et incendio projecti: Bartolomeo Asaro (anni 49) di Girolamo e Lucia Colomba; Girolamo Asaro (anni 24) di Bartolomeo e Anna Vivona; Francesco Saverio Borruso (anni 64) di Giuseppe e (fu) Francesca Plaja; Francesca Borruso (anni 26), moglie di Girolamo Asaro, figlia di Francesco Saverio Borruso e Maria Bocina; Antonino Galante (anni 25) di Giuseppe e Anna Galante. Cfr. in AMC, Liber defunctorum huius Venerabilis Matricis Ecclesiae Castriadmare de Gulpho, D. 33 (1859-1865), ff. 79v-80r. Gli stessi, invece, non sono registrati allo stato civile, perché il volume dell'anno 1862 «fu incendiato nella ribellione avvenuta in questa il giorno I e 2 del gennaro 1862» (v. Annotazione in Registro degli atti di morte, i 862, vol. 42, che si conserva nell'Archivio di Stato di Trapani).
335 «I cospicui cutrara - riferiva la cronaca giudiziaria - avvedutisi presto della estrema gravità del pericolo, disperando poter trovare entro l'abitazione consueta difesa e sicurezza contro la reazione vandalica, non avean pensato ad altro pili che a sgombrare, a salvarsi». Tra gli altri il sindaco Marcantonio, «che fidò, e non indarno, ad ignoto sotterraneo, la minacciata salute» (cfr. «Diritto e Dovere», n. 24 del 27 giugno 1864). Anche a Bronte i civili avevano trovato scampo nelle campagne di fronte alla furia dei rivoltosi (v. B. RADICE, Nino Bixio a Bronte, p. 69).
Furono devastati i locali del Municipio, nonché gli uffici della dogana e della regia giudicatura, bruciando le carte degli archivi, forse per ispirazione di qualcuno che avrebbe voluto cancellare le tracce di «talune magagne» nascoste in quelle carte336. Calandra sostenne di aver sentito il notaio Mangiarotti gridare ai rivoltosi dal suo balcone: Ad iddi, ad iddi, ora è ura picciotti, chi Alcamu si rivutau, sorpreso ed eccitato per il loro crescente numero: «Ottocento sono, e di tutti i paesi. Grossa è la palata »337. I carabinieri della locale stazione e il delegato Fundarò, disarmati dal popolo, furono tenuti prigionieri; mentre dalle carceri si fecero uscire i detenuti, i quali si dispersero per il paese.
Spentasi verso sera la furia omicida degl'insorti, si fece intanto luce il proposito di ristabilire in qualche modo l'ordine e impedire ai non pochi malviventi di avere il sopravvento. Si elesse, quindi, un capo nella persona di Pietro Lombardo, il quale accettò a condizione che cessassero gli eccidi e i saccheggi338. Il ritorno alla pace fu di li a poco celebrato nella Chiesa Madre, dove si recarono birritti e cappeddi «ad intonare l'inno delle grazie a Dio»339.
336 Intento dei borbonici «fu di far bruciare nella reazione le carte della cancelleria comunale, ove si erano scoverte talune magagne, e molte altre se ne stava n disotterrando» (cfr. G. CAlANDRA, L'avvocato ed i parricida, pp. 86-87).
337 Ivi, p. 96.
338 «E fu provvidenziale decreto, che i cagnotti di quella nefasta tirannide volessero a capo, anziché taluno fra i sicari o gli istigatori dei saccheggi, degli incendi, degli assassinii, un Pietro Lombardo. Il quale, a trapassare in silenzio le sue opinioni politiche rese per avventura un po' dubbie dal fatto medesimo della sua elezione, merita ricompensa molta di lode per il coraggio civile e la morale virtu, con cui ritraendo la maniaca torma di quegli uomini snaturati dalla esecrabile via, in che l'aveano spinta agitatori schifosi, a consigli men disumani, francò da nuove sevizie la natale città. Perciocché il Lombardo, dopo avere alle sollecitazioni della scapigliata plebaglia opposto reiterati e pericolosi rifiuti, dichiarava sé pronto a farsene duce, ad una condizione però, condizione animosamente posta in modo assoluto; a questa cioè, che, smorzata la facella incendiaria, riposta l'iniquità del pugnale, si dovesse da ogni reato contra le persone e le proprietà desistere incontanente» (cfr. «Diritto e Dovere», n. 24 del 27 giugno 1864).
339 Cfr. G. NICOTRI, Rivoluzioni e rivolte, p. 77. L'episodio era cosi ricostruito dal cronista giudiziario del «Diritto e Dovere»: «Chiamati a prestare l'ufficio dell'arte loro i suonatori, percorrevasi processionalmente il paese inneggiando con ripetuti plausi ai principali della parte borbonica, specialmente al Di Blasi. E tutto insieme questo corteo, nel quale faceano strano contrasto quindi gli eroi dell'impresa ancor brutti di sangue fumante, quinci gli amici e parenti delle vittime martoriate, resi pressoché stupidi dall'interiore trambasciamento e contendenti si a forza lo sfogo del pianto e del gemito: quindi i perseguitati, tremanti del passato pericolo, paurosi dell'avvenire, aventi tuttora nel viso il pallor della morte, che appena credevano a sé stessi di avere evitata; tutto insieme, ripeto, questo corteo trasferivasi alla Chiesa maggiore, ove in rendimento di grazie alla Divinità offesa cantavasi dagli svergognati autori di tante scelleratezze l'Inno Ambrosiano» (n. 24 del 27 giugno 1864). V. anche la deposizione di Mariano Lombardo al processo, ivi, n. 25 dell'8 luglio 1864: il sacerdote Antonino Zangara «aggiungeva essere volere di quei rivoltosi che tutti i galantuomini dovessero recarsi con loro al Te Deum».
Chi fosse Pietro Lombardo (1822-1893), chiamato dalla folla a governare gli umori contrastanti e a mediare gli opposti interessi che dividevano cutrara e popolani, si può forse intuire attraverso le sia pur scarse informazioni che su di lui si sono potute raccogliere. Egli era intanto un possidente di beni non cospicui, ma sicuri e redditizi: terre alla Gagliardetta e case in paese340. Doveva fondare il «rispetto» che manteneva tra i Castellammaresi sulla lunga affidabilità delle cariche amministrative (era stato primo eletto nel decurionato del '49 e, piu volte, consigliere distrettuale341) e di quelle preposte alla sicurezza interna, che aveva gestite con qualche merito durante il passato regime. (Ad es., si accenna a lui nel rapporto sui fatti dell'aprile 1860, inviato dal giudice regio di Castellammare al direttore della polizia in Palermo. Quel funzionario lo segnalò, insieme con Andrea Di Blasi e Gioacchino Ferrantelli, per l'azione spiegata a beneficio dell'ordine e della «salvezza del paese»342.) Anche se Calandra non lo include nel minuzioso elenco dei filoborbonici di Castellammare che pubblica nell'opuscolo sui Casi del '62343, la sua appartenenza alla schiera dei legittimisti non pare che possa essere messa in dubbio. Tuttavia il prestigio di cui godeva in paese lo collocava nella ristretta categoria dei garanti dell'ordine sociale, e quindi al di fuori di ogni formale qualificazione politica. (Per questo Calandra lo considera estraneo ai giuochi di potere, in una posizione di equidistanza dall'una e dall'altra fazione municipale).
340 AST, Catasto provvisorio, cit., vol. 7, art. 2190. Il padre, D. Giuseppe (v. testamento del 12 settembre 1854 in not. Vito Parisi: AST, 1194, ff. 458r-463r), possedeva in contrada Gagliardetta una masseria di 35 ettari di vigneto e 17 ettari di seminatorio, oliveto e giardino. Nello stesso catasto, era pure iscritto, a nome di D. Giuseppe, un fondo vignato di una decina di ettari sito in contrada Molinello di Alcamo. Nel centro abitato di Castellammare i Lombardo possedevano numerosi fabbricati. Il figlio Pietro, prima della divisione dell'eredità patema valutata in lire 170632 e 60 centesimi (atto dell'Il aprile 1865 in noto Vito Mattarella: ANT, 4015, ff. 283r-376v), aveva due case di sua proprietà sulla via maestra. Nato a Castellammare il 3 agosto 1822 da Giuseppe e Vita Polizzi (v. in AST, Registro degli atti di nascita, 1822, vol. 4, N. 157), vi mori il 15 agosto 1893 (ivi, Registro degli atti di morte, 1893, vol. 72, N. 218). Era rimasto celibe.
341 AST, FI, Polizia, Corrispondenza (1849-53), rapporto del capitano Almeida del 23 settembre 1849; e inoltre RD di nomina a componente del Consiglio distrettuale di Alcamo in «Giornale della Intendenza di Trapani», n. 4 dell'aprile 1852, p. 127. Vi fu riconfermato per gli anni 1859-60 con RD del 17 marzo 1859 (ivi, n. 4 dell'aprile 1859, p. 86).
342 ASP, ML, Polizia, b. 1505, filza 48.
343 G. CALANDRA, l casi, pp. 15-16.
La proposta di eleggerlo ad arbitro delle sorti di quella sommossa parti probabilmente da qualcuno che ne riconosceva gli sperimentati meriti di protettore e di mediatore negli affari locali. Lombardo poteva anche non essere un capo mafia, nel senso che noi oggi intendiamo C e, forse, s'intendeva anche allora); ma i sentimenti manifestati al fine di deprimere le animosità contro i cutrara344, e soprattutto il comportamento tenuto successivamente, quando fu lui a costruire su trame omertose il «discarico» a favore di molti imputati, ospitando perfino nella sua casa il giudice che istruiva il processo345, non lasciano dubbi sul suo efficace ruolo di garante Ce connivente) del quadro mafioso castellammarese.
Non ci sono perciò analogie con la posizione assunta da altri «capi» nelle rivolte contadine e popolari avvenute altrove in quel periodo. A Bronte, nel '60, l'avvocato Nicolò Lombardo aveva guidato una rivendicazione demaniale, nell'interesse dei comunisti 346. A Palermo, nel '66, il ceto nobiliare sarebbe entrato a far parte del comitato rivoluzionario perché spinto dal timore di essere trascinato dall'esplosione del mob cittadino fino a compromettere le proprie sostanze347.
344 Numerose testimonianze al processo riferirono sull'opera da lui spiegata, insieme col fratello D. Cosmo, per mettere in salvo alcuni notabili castellammaresi nel primo insorgere della rivolta: ad es., coadiuvato anche da Stefano Barone e Francesco Ferrantelli (sona ca ti pagu), salvò la vita al delegato Gaspare Fundarò (v. «Diritto e Dovere», n. 25 del 4 luglio 1864). Poi, quando fu eletto a capo dei rivoltosi (qualcuno ricordò di aver visto i D'Anna e i Ferrantelli tra coloro che lo avevano indicato ad assumere il rischioso compito), pose sotto la sua protezione i cutrara che non avevano ancora abbandonato il paese, tra cui il sindaco Marcantonio (ivi, n. 31 del 18 agosto 1864; ASf, Corte d'Assise, Verbali, 1864, vol. 8).
345 «Il giudice Milone albergò prima nel convento dei Padri Crociferi, poi nella casa del sig. Pietro Lombardo, uno degl'inquisiti» (cfr. G. CALANDRA, L'avvocato ed i parricida, p. 95). Però, come risulta dalla requisitoria di rinvio a giudizio, D. Pietro Lombardo non figura tra gl'imputati per i fatti del gennaio 1862. Lo stesso Lombardo era imparentato con la famiglia «prepotente» dei Ferro di Alcamo, esponenti della mafia locale (v. in AST, FI, Polizia, Affari generali (J 849-5 J), fase. Spirito pubblico). Lè sorelle Giovanna, Maria Stella, Rosalia e Marianna avevano sposato tutte e quattro membri di quella famiglia, tra cui un Luigi che era stato comandante della compagnia d'armi nel distretto di Alcarno (v. atto di divisione della proprietà di D. Giuseppe Lombardo, in not. Vito Mattarella dell'11 aprile 1865, cit.).
346 Oltre alla citata monografia del Radice, v. la ricostruzione storica di quei fatti curata di recente da E. BETTINI, Rapporto sui fatti di Bronte del J 860, Palermo 1985. Per il movimento di rivendica dei demani nel vicino comune di Biancavilla, v. G. GIARRlZZO, Un Comune rurale della Sicilia etnea, già citato.
347 Alla folla cittadina che protesta lo storico inglese Eric J. Hobsbawm ha dato il nome di mob, individuando nel fenomeno ribellistico la compresenza di varie componenti sociali, di parole d'ordine e simboli spesso reazionari, ma, a parte ciò, riportando il movimento di proletari e piccolo-borghesi che lo esprime nello schema tipologico di una protesta contro le autorità, i ricchi e i potenti, intesa «al fine di ottenere mediante un'azione diretta (cioè mediante insurrezioni o ribellioni) riforme di natura economica e politica» (I ribelli, p. 149). Però, sempre secondo Hobsbawm, una simile azione collettiva di protesta non intende scardinare le basi dell'ordine sociale costituito, ma accetta, in sostanza, la «gerarchia tradizionale», «per quanto il sogno secolare di una società veramente e completamente libera, nella quale non vi siano né 'cappelli', né 'berretti' (per usare l'espressione siciliana) esploda a tratti in massacri selvaggi» (ivi, p. 162). Massimo Ganci pensa che la rivoluzione del sette e mezzo, da cui «non fu assente l'aspetto programmatico» e, quindi, politico, rientri pienamente nel concetto di mob (v. S.M. GANCI, La rivoluzione palermitana del settembre 1866, in «Nuovi quaderni del meridione», a. IV (1966), n. 16 (ottobre/dicembre), pp. 400-18).
La mattina del due gennaio fu spedito da Alcamo un drappello di militi a cavallo, comandato dal capitano Antonino Varvaro, insieme con una ventina di soldati di linea. Nello scontro coi ribelli, alcuni militi e lo stesso capitano Varvaro rimasero uccisi. Gli altri volsero precipitosamente in fuga. Fu allora che il sottoprefetto di Alcamo, resosi conto della gravità della situazione, chiese rinforzi alluogotenente generale in Palermo. Nella notte dal due al tre gennaio giunsero cosi in vista di Castellammare due navi da guerra carichi di truppa. I soldati sbarcati sul molo non riuscirono però a chiudere la ritirata degl'insorti verso i monti che circondano il paese. I cannoni dalle navi tirarono su quei monti, ma senza risultato. Soprattutto la montagna Spàracio era piena di anfratti impenetrabili, e i fuggiaschi vi si poterono nascondere a lungo, riuscendo poi per mesi a sfuggire alle ricerche della forza pubblica348.
Prima di occupare militarmente Castellammare, le truppe dovettero subire gravi perdite. Mori, con altri soldati, il capitano Mazzetti, già combattente nelle guerre per l'indipendenza d'Italia, che «ricevuto il colpo mortale esclamò: Dove venni a perdere la mia vita!»349. Tra gl'insorti, i quali si dispersero dopo aver opposto un'accanita resistenza350, i feriti non si poterono contare, perché nascosti dai parenti. I morti furono sette - secondo quanto risulta dai registri parrocchiali della Matrice di Castellammare351 -, compreso il sacerdote Palermo, che venne fucilato subito dopo il suo arresto.
348 Rapporto del Generale Govone al ministro dell'interno U. Peruzzi, 9 aprile 1863, in u. GOVONE, Il Generale Giuseppe Govone, p. 146.
349 Cfr. G. CALANDRA, I casi, p. 40. Al capitano Carlo Mazzetti è dedicato nel cimitero di Castellammare un sarcofago di marmo con epigrafe commemorati va.
350 «S'impegna animato il fuoco - scrive Calandra -, ed i ribelli fulminati a scaglia non cedono il terreno che a palmo, a palmo, sino al piano del Castellaccio, ove la notte pose fine all'accanito attacco» (ivi, p. 39).
351 Il numero degli uccisi a militibus Regis ltaliae, che è registrato nel Liber defunctorum della chiesa matrice di Castellammare, smentisce l'affermazione di Calandra: «Gli assassini ebbero un morto, un fucilato e due feriti, ignorandosi finora se tra i fuggitivi v'era qualche altro ferito» (cfr. ivi, p. 40).
Che Benedetto Palermo (1818-1862) appartenesse alla fazione capeggiata dal notaio Di Blasi è provato da testimonianze diverse: il rapporto del capitano Almeida sui «partiti» di Castellammare352, nonché una lettera del presidente del Municipio, Giuseppe Marcantonio, indirizzata il l° dicembre 1860 al governatore della provincia, Enrico Parisi, per informarlo sulla condotta del sacerdote. Quest'ultimo era stato incluso dall'arciprete del paese in una tema di nomi proposti al vescovo di Mazara per l'elezione di un cappellano. Definito «uomo perverso, scandaloso, falso testimone, omicida, reazionario, nemico del nostro libero Governo, satellite cagnotto, e spia infame del Borbone», il sacerdote Palermo era già stato sottoposto a «stretta sorveglianza governativa», dopo aver subito una breve carcerazione su ordine del dittatore353.
Fu trovato, dopo il conflitto del 3 gennaio ai Fraginesi, con le armi in pugno. Tentò di far valere le proprie ragioni, ma «comprovato giuridicamente che fu preso in azione» fu fatto fucilare. È quanto riferisce Calandra, il quale si sofferma pure con impietosa precisione sui momenti della tragica fine del sacerdote. Purtroppo è l'unica testimonianza che ci resta, con quel sottofondo passionale che costituisce il ricordo, ancora pungente, di un cutraru colpito nelle sue sostanze e minacciato nella vita: «Il prete brigante e compagni si battevano d'una pagliaia distante due tiri a palla di fucile da caccia da Castellammare, ed un tiro dall'ultimo braccio di questa strada rotabile che porta ai Fraginesi, ov'erano alquanti soldati. L'egregio capitano sig. D. Emesto Bosisio ordina di attaccarli alla baionetta, e cosi facendo i bersaglieri vider fuggire i ribelli, dei quali uno cadde morto sull'istante, un altro ferito restò prigioniero, un secondo ferito al piede corse, due altri, tra i quali il Sangiorgio, si salvarono ancora colla fuga, ma il sesto, era il sacerdote, venne arrrestato. Fattagli perquisizione gli si rinvennero due gilé con le tasche piene di cartucce, una pistola, oltre il fucile che aveva in mano. Tradotto dinanzi il generale Quintini, voleva discolparsi, ma comprovato giuridicamente che fu preso in azione, scaricando contro la truppa, il generale ordina: Dieci passi, e fucilatelo. Difatti un sergente e due bersaglieri gli complimentarono tre palle nell'addome»354. Nell'altro suo opuscolo sui fatti di Castellammare, scritto in polemica con l'avvocato Simone, Calandra aggiunge qualche particolare non trascurabile: «Non fu il sacerdote D. Benedetto Palermo che la mattina del primo gennaro si portò al Trappeto, luogo di convegno pei briganti, li avverti dell'ora in cui dovevano dare l'assalto, e dietro quest'opra, gravida di rovine, e sangue fraterno, tornò in paese ad offrire a Dio l'olocausto della Messa? Ebbe però condegna pena nell'essere prima fucilato, e poi, perché rimasto vivo, scannato, dopo un'ora, dalla baionetta d'un bersagliere»355.
352 AST, FI, Polizia. Corrispondenza (1849-53); rapporto del com.te la colonna mobile in Castellammare al principe di Satriano, 13 settembre 1849, N. 374.
353 Cfr. nota del presidente del Municipio di Castellammare al governatore della provincia, l° dicembre 1860, in AST, Intendenza, b. 1860-61.
354 Cfr. G. CAIANDRA, I casi, pp. 40-41.
355 Cfr. G. CAIANDRA, L'avvocato ed i parricida, pp. 99-100.
La figura di questo sacerdote ci rimane cosi ambiguamente segnata da una ricostruzione di parte. Non ci è possibile, quindi, stabilire se l'impegno antiunitario e filoborbonico lo avesse spinto effettivamente a prendere le armi contro le truppe italiane; se egli nutriva propositi di rivalsa popolare in nome di tangibili rivendicazioni sociali (è troppo vago l'accenno che si fa durante il processo a richieste avanzate dal «partito» dei legittimisti per la quotizzazione ai contadini dell'ex demanio regio di Scopello); né si può precisare il ruolo che egli assunse nel preparare e guidare la rivolta. Se le sue opinioni sul reggimento unitario erano le stesse del cognato Giovanni Sangiorgio, autore del sonetto posto ad epigrafe di questo studio, si può senz'altro affermare che egli fosse animato da un serrato e motivato sentimento di avversione contro il «malgoverno» sabaudo. Certamente egli apparteneva al basso clero; non aveva chiesa propria e non possedeva vistose sostanze, come invece possedevano molti ecclesiastici che militavano nelle file liberali. È solo una congettura: ma può essere stata la sua una prova disperata di reazione contro un ordine politico e sociale che lo aveva escluso perfino dal beneficio di una cappellania356.
356 Non ho potuto raccogliere altre notizie sul sacerdote Benedetto Palermo, nemmeno attraverso lo spoglio degli atti notarili, dove il suo nome ricorre solo due o tre volte in occasione del reiterato atto di costituzione di una banda musicale cittadina, stipulato insieme con un'altra ventina di civili e popolani. (Cfr. il primo di questi atti, dell'8 aprile 1851, in noto Vito Parisi: AST, 1191, fI 238r-243v; vi sono riportati lo statuto della «società per banda musicale», presieduta dallo stesso sac. Palermo e da D. Antonino Costamante, i nomi dei musici e il loro compenso, oltre alle modalità del servizio). Il padre di Benedetto Palermo era fratello di un altro sacerdote, D. Michele, che troviamo spesso tra i prestatori di denaro a cambio marittimo e come mediocre acquirente di fabbricati e fondi rustici (v. inventario ereditario del defunto sac. D. Michele Palermo ad istanza del fratello D. Leonardo, suo erede universale, in noto Gaetano Maria Di Blasi, 29 novembre 1838). Secondo quanto risulta dal libro dei battezzati nella chiesa parrocchiale matrice di Castellammare, Benedetto Palermo era nato da Leonardo e Maria Pilara 1'8 marzo 1818.
Se si deve ancora confidare sulla testimonianza di Calandra, resta poi l'impressione di una spietata, e forse inutile, energia nel gesto di quel bersagli ere sul corpo agonizzante del sacerdote. Non meno spietato fu però il comportamento del generale Quintini che comandò il corpo di spedizione sbarcato a Castellammare. L'ufficiale era reduce dalla campagna contro il brigantaggio nell'Italia meridionale, durante la quale era stato pure autore di sommarie esecuzioni di prigionieri357. Si sapeva già quale condotta avesse regolato in quelle regioni l'azione repressiva dell'esercito, con la «fucilazione sommaria per i "cafoni" colti con le armi alla mano e sospettati di appoggio ai briganti»358. Una tale condotta fuorviava spesso dai limiti della stessa ritualità delle leggi eccezionali, aggravando il senso della reciproca estraneità e ostilità verso le masse e verso lo Stato - che aveva ormai largamente soppiantato l'iniziale entusiasmo per la causa unitaria. A Castellammare, però, mancavano le condizioni di un progetto politico di segno reazionario che in qualche modo giustificasse da parte dell'esercito una cosi dura e arbitraria reazione, in quanto il fronte delle opposizioni borbonicoclericali era fittizio o aleatorio, privo cioè di una «strategia» di manovra che avesse la sua base di massa nel brigantaggio. La rivolta di capodanno del '62 seguiva, o anticipava, seppure con intendimenti diversi, le sollevazioni popolari contro lo strapotere e l'egoismo dei galantuomini che erano già esplose in Sicilia, o che si sarebbero scatenate dopo.
357 Il colonnello Pietro Quintini, promosso generale dopo il vittorioso scontro di Scurcola Marsicana contro le truppe borbonico-clericali, aveva operato alla fine del '61 nella zona di A vezzano sotto il comando del generale Della Rocca. Si vedano su tale operazione antibrigantesca le documentate notizie riportate da c. CESARI, L'assedio di Gaeta e gli avvenimenti militari del 1860-61 nell'Italia meridionale, Roma 1926, p. 158. Dello stesso Cesari, che attinse ai fondi archivistici dell'Ufficio storico dello Stato Maggiore, v. pure Il brigantaggio e l'opera dell'esercito italiano dal 1860 al 1870, Roma 1920.
358 F. MOLFESE, Storia del brigantaggio dopo l'Unità, Milano 1966, pp. 188-89.
Probabilmente l'eccezionalità e l'asprezza dello scontro sociale non permisero al generale Quintini di saper distinguere tra il ribellismo brigantesco nell'Italia meridionale e la sommossa antiborghese di Castellammare: tanto da non fargli rispettare nemmeno quelle «garanzie» della legge marziale che pure avevano indotto Nino Bixio a montare un giudizio formale contro gli autori della rivolta di Bronte. Ciò che scrisse Calandra a proposito delle «prove giuridiche» raccolte contro il sacerdote Palermo (ma non poté dire che fosse stato un tribunale di guerra a condannarlo a morte) è solo maldestra manipolazione di fatti allora certamente non ignoti. Il tentativo di falsare una notizia che, accompagnata alla circostanza delle altre fucilazioni, doveva registrarsi con un certo raccapriccio, ci appare dunque abbastanza scoperto.
Cosi veniamo all'oscuro episodio della fucilazione dei ribelli comandata dal generale Quintini. Le fonti ufficiali non dànno riscontri affidabili sull'evento, che, anzi, per lo piu ignorano. Nessun riferimento ad esso, sia pure indiretto, si trova infatti nei volumi che raccolsero i verbali del dibattimento alla Corte d'Assise di Trapani. Il generale Quintini, nella sua deposizione dinanzi alla stessa corte359, non ne fa cenno. Il governo, che doveva rispondere ad un'interpellanza del deputato D'Ondes Reggio, dichiarò di non aver avuto tempestive informazioni al riguardo. Né, in seguito, volle comunque soddisfare alla richiesta dell'interpellante, al quale era giunta notizia di esecuzioni sommarie di prigionieri: «Intanto ho letto nel giornale uffiziale (non parlo di ciò che narrano altri giornali) che vi furono cinque, se non erro, i quali, presi colle armi alla mano, furono fucilati»360. Il ministro Miglietti negò soltanto che i fatti accaduti a Castellammare potessero essere considerati «come norma del modo col quale la giustizia si amministri in Sicilia»: «Se nell'impeto non hanno potuto i militi reprimere un sentimento, dirò, di giusta ira, in seguito agli immensi danni di cui erano spettatori, non è cosa questa la quale in alcun modo possa essere addotta come argomento che la giustizia sia male amministrata»361. I deputati ministeriali manifestarono in quella occasione i loro timori per la situazione dell'ordine pubblico nel Sud d'Italia, che risultava eccitato dalla fazione borbonica sempre pronta a sfruttare il malumore della gente. Piu che di formali garanzie di legalità costituzionale, si aveva bisogno in certi casi di concreti atti di energia: «Io, o signori confessò Paolo Patemostro, suscitando entusiastiche approvazioni della sua parte politica -, non desidero certo di trovarmi in simili casi; ma, se mi ci fossi trovato, state sicuri che avrei pensato poco alla stretta legalità, poco alle future osservazioni del deputato D'Ondes, ed avrei fucilati, senza misericordia, quei feroci perturbatori dell'ordine». Proposito davvero iniquo per un tutore dei diritti statutari perché D'Ondes Reggio non potesse ribattere con arguta solennità: «Quanto poi a quello che l'onorevole Paternostro ha manifestato che avrebbe voluto adoperare se si fosse trovato al potere, io non gl'invidio la gloria di quello che avrebbe fatto, ma so che non l'avrei mai fatto io, civile europeo»362.
359 «Diritto e Dovere», n. 26 dell' Il luglio 1864.
360 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Sessione del 1861-62, Discussioni, tornata del 15 gennaio 1862, p. 674.
361 [vi, p. 676.
362 [vi, pp. 677-79.
Tra le incertezze provocate dai silenzi, forse imbarazzati, delle autorità locali, nonché dall'atteggiamento di copertura nei confronti dell'operato dell'esercito adottato dal ministero, si poté tuttavia ricavare questa semplice verità: che i ribelli (veri o presunti) erano stati fucilati per un impeto di reazione, non per la decisione di un Consiglio di guerra. Quanti furono? Cinque, lesse D'Ondes Reggio nel «Giornale Officiale di Sicilia»363; ma il numero esatto è ora possibile ricavarlo dai registri parrocchiali della chiesa madre di Castellammare. L'arciprete Girolamo Galante364, alla data del 3 gennaio 1862, si preoccupò di annotare, oltre che i nomi e l'età di ciascuno di loro, anche il luogo in cui avvenne l'esecuzione dei prigionieri, precisando che erano stati a militibus Regis ltaliae interfecti . Oltre al sacerdote Benedetto Palermo, si trovarono nel gruppo dei giustiziati altri due popolani (l'anziano mastro Antonino Corona, oriundo di Gibellina, e il «villico» Marco Randisi)365 e tre donne (la settantenne Angela Calamia, Marianna Crociata e Angela Catalano), sposate a contadini del basso ceto borgese366. La stessa condizione anagrafica della maggior parte dei fucilati conferma l'impressione (o la notizia pervenuta per altre vie) comunicata alla Camera dal ministro della gi ustizia che l'esecuzione sommaria fosse avvenuta sotto l'impeto dell'ira militaresca. E nemmeno, si deve pensare, perché quei popolani furono presi con le armi alla mano. Non c'è a Castellammare, tra le fonti locali, e non c'è neanche nei documenti giudizi ari e di polizia, alcuna testimonianza, diretta o indiretta, delle fucilazioni del 3 gennaio, che pure ebbero la prova «ufficiale» della comunicazione attraverso il giornale governativo. Su quei fatti increscio si, di cui si accusavano le circostanze e le mene borboniche, si stese, come suoI dirsi, un velo di silenzio, verosimilmente per amor di patria.
363 «Sei dei colpevoli, presi colle armi alle mani c in atto di far fuoco contro le truppe, furono trucidati; tre di costoro non vollero palesare il loro nome, uno fu un triste prete imbrancatosi fra quella sanguinosa ribaldaglia» (cfr. «Giornale Officiale di Sicilia», S gennaio 1862).
364 Era arciprete da] 1838 (v. S. A.. ROMANO, La Chiesa Madre di Castellammare del Golfo, Alcamo 1969, p. 69) e sarebbe morto, all'età di 76 anni, il lo giugno 1864 (v. in AST, Registro degli atti di morte, 1864, vol. 4S, N. 93).
365 AMC, Liber defunctorum, 1862, die tertia ianuarii, f. 80v: Benedetto Palermo di Leonardo; Antonino Corona (anni 70) fu Bartolomeo, nato a Gibellina e sposato a Paola Coci; Marco Randisi (anni 4S) di Francesco e Vincenza Messina, sposato ad Antonia Lombardo.
366 [vi, ff. 80r-80v: Marianna Crociata (anni 30) di Antonino e Antonia Messina sposata a Giuseppe Provenzano; Angela Catalano (anni SO), vedova di Giuseppe Di Bona; Angela Calamia (anni 70) fu Pietro e Margherita Gallo, sposata a Pietro Colomba.
La testimonianza del Liber defunctorum della Matrice di Castellammare ci consegna il nome di un'altra vittima del 3 gennaio '62. Una ragazza di nove anni è compresa tra gli uccisi a militibus Regis Italiae; ma stentiamo a credere che anch'essa possa essere stata fucilata in quella circostanza. Comunque il riferimento, seppur vago, alla repressione militare e l'indicazione del luogo (villa Falconera) dove fu uccisa fanno sorgere domande inquietanti sul reale svolgimento del fatti: «Romano Angelafilia Petri et Joanna Pollina consortis. Etatis sl}ae ano 9 circa hodie hor. 15 circo in Castriadmare. Animam Deo reddidit absque sacramentis in villa sicdicta della Falconera quia interfectafuit a militibus Regis Italiae. Ejus corpus sepultum est in. Campo Sancto novo»367. A causare la morte della ragazza può essere stato un coinvolgimento incidentale nello scontro fra le truppe sabaude e il gruppo degl'insorti che si erano concentrati fuori del paese; ma può essere stato anche il ben piti pesante e diretto atto di reazione dei militari contro i prigionieri al cui destino non si sa per quale tragico equivoco Angela Romano si trovò ad essere accomunata.
Segni preoccupanti di rivolta si ebbero contemporaneamente ad Alcamo. Gli scontri fra popolani e forza pubblica durarono almeno per i primi tre giorni di gennaio; ma non si conoscono gli atti specifici del moto alcamese, né il carattere che assunse, con ogni probabilità legato a quello castellammarese dalle stesse emergenze sociali. La sera di capodanno, durante un conflitto a fuoco coi renitenti, vi erano stati feriti quattro carabinieri. L'indomani fu ucciso un ufficiale del 52' reggimento368, mentre un altro risultò gravemente ferito.
367 [vi, f. 80v.
368 L'ucciso fu l'ufficiale di fanteria Ciro Montecchini, di anni 25, nativo di Sant' Antonino di Susa. Lo scontro di cui fu vittima avvenne nella via del Corso, vicino a Porta Trapani (v. in AST, Registro degli atti di morte del Comune di Alcamo, 1862, vol. 55, N. 4 del 2 gennaio). V. pure nell'Archivio della Chiesa Madre di Alcamo, Liber defunctorum ab anno 1858 ad annum 1869, vol. 28, f. 76, n. l, l'atto di morte di Ciro Montecchini, il cui corpo fu sepolto nella Chiesa di S. Maria di Gesu. Non ho invece rinvenuto l'opuscolo composto dal sacerdote Sante Impellizzeri in morte dell'ufficiale (Elogio funebre di Ciro Montecchini luogotenente nel 520 reggimento fanteria dell'esercito italiano. Letto nella Matrice di Alcamo il 16 gennaio 1862, Palermo, Tip. di Benedetto Lima Lao, 1862, 16 pp. in-4°).
Ad Alcamo si era frattanto trasferita nella notte del 3 una parte dei soldati sbarcati col corpo di spedizione del generale Quintini; ma ancora per tutta la successiva giornata la resistenza dei ribelli si manifestò piuttosto ostinata369.
L'ordine fu perciò ristabilito con un pesante costo di vite umane. Ai fucilati della parte popolare debbono aggiungersi le perdite subite dalla forza pubblica e dall'esercito. Secondo quanto avrebbe riferito al tribunale il generale Quintini, si contarono nelle tre giornate, fra i soldati, sette morti e undici feriti. Altri due militi e un carabiniere, nonché il capitano Carlo Mazzetti, morirono negli assalti di quei giorni370.
369 «Lo stesso giorno del tre gennaio trovavasi in Calatafimi il battaglione del 52° rilevato da Trapani, ed ebbe ordine da quel prefetto muovere per Castellammare; ma siccome in Alcamo si mostrarono anche sintomi di ribellione, è chiamato là dal sotto prefetto, che contentatosi d'imporre sui rubelli ancora non pronunziati parte, collo stesso, e giunge in questa verso le ore due e mezza della notte. Con tanta forza, si era preparato per il giorno quattro un attacco contro i briganti, che si erano raggranellati in Baida ed Inici. Ma appena spuntava l'alba del detto giorno, un espresso avvertiva il sotto prefetto, che in Alcamo, poco dopo mosso quel battaglione, era cominciato, nell'ambito del paese, un fuoco di fucileria, che aveva fatto vittima un tenente di linea. (Anche la notte del giorno due erano stati feriti, con pallini da caccia, tre carabinieri). Fu allora che l'energico sig. sotto prefetto, verso le undici s.m., muove per Alcamo, in uno al generale Quintini, ed alla truppa, lasciando in Castellammare 256 uomini» (cfr. G. CALANDRA, 1 casi, pp. 39-40).
370 Deposizione del generale Quintini riportata dal «Diritto e Dovere» nel resoconto giudiziario del n. 26 (lI luglio 1864). Nei registri parrocchiali della Matrice di Castellammare non sono annotati i soldati uccisi durante i conflitti a fuoco del 2 e 3 gennaio, ad eccezione del comandante della cavalleria di Alcamo, Antonino Yarvaro (anni 26) e del capitano dell'esercito Carlo Mazzetti di Gaetano (anni 38). Y. AMC, Liber defunctorum, 1862, f. 80r. Calandra ricorda però anche i nomi del brigadiere Mariano Bochini, che comandava la locale stazione dei carabinieri, e del milite a cavallo Giuseppe Lazzara (v. L'avvocato ed i parricida, p. 76).
|
|

|





